![]()
![]()
![]()
Cessa del Congo contro Venere di Kinshasa
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
Layla
Gallego voleva parlarmi, ma io non avevo la più pallida idea di cosa volesse.
Per la verità, non sapevo neanche chi fosse.
D’altra parte, in quell’eterogenea spedizione, in pochi si conoscevano tra loro.
Il meccanismo era stato messo in moto dal Dottor Monsen: lui solo conosceva tutti gli altri.
Mi aveva pagato bene, anche per non fare domande. Da me si aspettava che io facessi il mio lavoro di archeologo, e da parte mia stavo facendo qualcosa che avrei fatto anche senza essere pagato: cosa volevo di più?
La partecipazione all’impresa di un nutrito gruppo di gorilla non prometteva nulla di buono, questo era vero, ma da quelle parti occorreva proteggersi, e questo era altrettanto vero.
Quanto alla Gallego, ne conoscevo il nome, la bella faccia e il sorriso ammiccante, ma non avevo ancora capito che ruolo ricoprisse nella squadra di Monsen.
 Una stagionata majorette o un rincalzo di lusso? Era presto per
sbilanciarsi.
Una stagionata majorette o un rincalzo di lusso? Era presto per
sbilanciarsi.
D’altronde, grazie al suo caschetto di capelli color mogano, sembrava l’unico componente della spedizione a essere in sintonia con la foresta amazzonica che ci inghiottiva da giorni; di più: sembrava una sorta di vessillo di quell’albero monumentale, l’oro rosso dell’Amazzonia, il legno più conteso al mondo per le insuperabili proprietà e l'irripetibile colore.
Sulla bandiera del Belize c’è scritto, ai piedi di un albero di
mogano: “sub umbra floreo”, “all’ombra (del mogano) fiorisco”; e, francamente,
all’ombra della Gallego sarei fiorito anch’io.
In mezzo a queste divagazioni, stavo per decidere se accettare il suo invito. L’appuntamento era nella sua tenda, dopo la cena.
Se il motivo della chiamata rimaneva incerto, d’altra parte il non andare sarebbe stato - di certo - una fesseria.
Dunque mi lasciai convincere senza troppe difficoltà: la avvicinai e le comunicai la mia decisione.
![]()
 Dopo la cena al bivacco, mi ritirai nella mia tenda e feci
trascorrere dieci minuti.
Dopo la cena al bivacco, mi ritirai nella mia tenda e feci
trascorrere dieci minuti.
Quindi uscii, mi guardai intorno, mi diressi verso la tenda della donna e la chiamai sommessamente, da fuori: «Signora Gallego… sono il Dottor Gomez…».
«Venga dentro… la stavo aspettando.
Grazie per essere venuto».
«Di cosa voleva parlarmi?», cercai subito di arrivare al punto, non appena mi fui seduto a gambe incrociate, di fronte a lei.
«Non beve qualcosa?», la Gallego avvicinò una bottiglia. «Questo rum farebbe venire i brividi a un cadavere…
Non ci crede? Allora lo provi… non ho i bicchieri, però».
«Vuole dire che somiglio a un cadavere…?», cercai di sdrammatizzare e di mostrarmi a mio agio, nonostante non lo fossi affatto.
Mi diede il tempo di mandar giù un paio di sorsi e tornò al punto: «Non intendevo questo, ma il condizionamento della civiltà è un peso enorme nelle relazioni sociali… e lei sembra essere uno dei pochi uomini civilizzati di questa missione. Spero tuttavia per entrambi che la civiltà non le abbia dato alla testa…», e nel muoversi per riporre in disparte la bottiglia, perse l’equilibrio e mi cadde addosso; non avevo ancora capito se si fosse trattato di una mossa volontaria, quando mi sfiorò il sesso con mano esperta, rovesciandomi per terra.
Fu allora che il mio dubbio divenne ridicolo: quell’aspetto rassicurante, da cinquantenne per bene, era solo la facciata di una donna scaltra e disinvolta.
«Qualunque altro uomo, civilizzato o meno, non esiterebbe a divorarmi, Dottor Gomez, specie in questa giungla desolata… e invece lei è fermo, inquieto, ed è per questo che l’ho chiamato: lei non solo è un individuo civilizzato, ma anche un uomo nel senso più compiuto del termine…
Ora però mi baci, la prego…».
La sua voce, il corpo soffice e caldo, gli occhi penetranti, non ammettevano indugi.
Lei mi incoraggiò ad andare oltre, io cercai di trattenermi, perché era l’unica donna della compagnia e non mi andava di esporla a situazioni imbarazzanti.
C’era troppo silenzio nell’accampamento e certi rumori sono inconfondibili…
Ma non riuscivo a fermarmi e lei non voleva che io lo facessi.
Ci liberammo dalle camicie umide di sudore e fummo a contatto, petto contro petto.
Sarebbe bastato toccarla, sarebbe bastato guardarla, sarebbe bastato sognarla, ma a me capitavano tutte le cose insieme, troppo insieme, e non riuscivo bene a comprendere quello che facevo, come uno che abbracci l’acqua senza saper nuotare.
Le esplosi dentro senza rendermene conto.
E rimasi a guardarla, quasi inebetito.
Per fortuna l’acqua era bassa.
Fu lei a disimpegnarsi. Sembrava aver recuperato in fretta il suo autocontrollo.
Si rivestì.
Io ero ancora inerte.
«Era di questo che voleva parlarmi?».
«Certe cose valgono più di mille parole.
Vede… io sono da sola in questa avventura.
E dunque sto tastando il terreno intorno a me», continuò la donna. «Ma non preoccuparti... la civiltà non ti ha annebbiato del tutto», era stato più difficile arrivare al “tu” che alle sue cosce.
«C’è altro che devi dirmi, Layla?».
«No, abbiamo parlato abbastanza».
«Allora… a domani… e grazie per il rum».
«A domani, Pablo».
Chi era, dunque, Layla Gallego?
E che cosa ci faceva in quel posto?
Mi addormentai senza che queste domande potessero minimamente intaccare la mia febbricitante estasi.
![]()
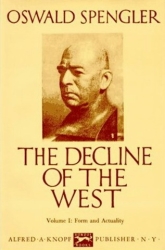 Il giorno dopo, di nuovo in marcia, il Dottor Otto Spengler
attaccò bottone parlandomi del suo famoso avo.
Il giorno dopo, di nuovo in marcia, il Dottor Otto Spengler
attaccò bottone parlandomi del suo famoso avo.
Non avevo mai letto “Il Declino dell’Occidente”, perché m’era sembrato superfluo approfondire una questione fin troppo chiara.
Tuttavia, Spengler Jr. insisteva nel decantarmi tutte le qualità dell’opera.
Da parte mia,
per non sembrare scortese, facevo finta di ascoltarlo e
in mezzo alle sue parole, come pronunciate da un pesce, riflettevo sulla mia
fulminea ascesa.
Giunto il crepuscolo, e consumata la solita cena al bivacco, rimasi deluso dal
fatto che Layla Gallego non avesse niente da
dirmi, quella sera.
Mentre leggevo degli appunti nella mia tenda, uno strano senso d’inquietudine mi colse, quasi d'improvviso.
Tergiversai per qualche minuto, poi quella sensazione aumentò di intensità e mi decisi a fare qualcosa. Niente mi impediva di farle visita. Mi incamminai verso la sua tenda. Il passo era veloce, ma non capivo che fretta avrei dovuto avere.
«Signora Gallego…», chiamai sottovoce, da fuori.
Nessuna risposta, nessun rumore dall’interno, nessuna luce.
Non era detto che fosse nella sua tenda, naturalmente.
Ma qualcosa mi spinse dentro.
Entrai e la vidi distesa sul giaciglio, voltata di fianco, sul lato esterno.
Poiché non si era accorta della mia presenza, esitai, pensando per un attimo che stesse dormendo, ma sentivo che qualcosa non andava.
Mi mossi in avanti e le scossi leggermente la spalla.
Bastò quella leggera pressione affinché il corpo della donna si ribaltasse supino…
Mi mancò il fiato…
Un manico di pugnale sporgeva dallo stomaco di Layla Gallego!
La lama era affondata quasi interamente.
Accesi subito la lampada a gas.
La Gallego aveva gli occhi pietrificati, ancora carichi dello stupore con cui era stata sorpresa dal suo assassino.
La bocca era aperta in maniera innaturale. Un rivolo di sangue le colava dal labbro.
Quasi mi spaventai quando vidi sbattere le palpebre, ormai pensavo fosse morta, e forse lo era, forse era stato soltanto un sussulto.
Il cuore pulsò forte. Cercai conferme. Speravo che fosse ancora viva.
«Layla…», ero quasi più morto di lei.
Gli occhi della donna ebbero un altro sussulto, un tenue alito di vita prese forma nel suo sguardo spento: mi aveva visto o sentito, e forse riconosciuto…
L’assassino aveva colpito da poco. Io ero disarmato. Lei non era in condizione di parlare. L’omicida aveva creduto che fosse morta.
Dopo questi pensieri mal collegati, l’adrenalina cominciò a entrare in circolo e ciò mi diede la forza per pensare soltanto a qualcosa di utile. La collera sostituì qualsiasi altra emozione.
«Layla, devi stare calma, sono io, Pedro, capito?».
Uscii dalla tenda e urlai verso due gorilla poco distanti: «Sicurezza! Presto, c’è un’emergenza!», sperando non fossero loro gli assassini.
«Allarme! Allarme! Venite tutti qui, presto!», decisi di evitare questo rischio.
Il campo entrò subito in fibrillazione, dopo le mie urla.
Tornai dentro, accanto a Layla.
In pochi attimi fu lo stesso Monsen a entrare nella tenda. Imprecò selvaggiamente. Sembrava sincero. Io, però, diffidavo di tutti, chiunque poteva essere l’assassino, e non ne conoscevo il movente.
Nella spedizione non c’era alcun medico. Si poteva contare soltanto su una cassetta del pronto soccorso: davvero troppo poco per Layla, ma meglio di niente.
Monsen ordinò ai suoi di portarla immediatamente.
Io rimasi attaccato alla Gallego, perché l’assassino avrebbe cercato di infliggerle il colpo di grazia, qualora non fosse presto deceduta a causa della prima pugnalata.
Nell’irreale attesa, mi sembrò di percepire una morbosa eccitazione correre di bocca in bocca per l’accampamento. In un lampo si diffuse la notizia che la bella Layla Gallego era stata accoltellata a morte.
Il Dottor Monsen, laureato in economia, cercò di farle dire qualche parola, ma inutilmente. Tuttavia ciò sembrava dimostrare che fosse estraneo all’omicidio, o almeno alla sua esecuzione, perché tutto lasciava pensare - in caso contrario - che non avrebbe sollecitato il nome dell’assassino alla sua stessa vittima.
La cassetta era arrivata.
Usammo i sali sintetici per cercare di rianimarla, ma la cosa non ebbe molto successo.
Era chiaro che non avremmo estratto il pugnale, almeno per il momento. Sarebbe stata un’azione delicatissima, che avrebbe potuto stroncarla definitivamente.
Mentre stringevo la mano di Layla e osservavo lo sforzo della donna, costretta a lottare come una tigre per non lasciarsi andare, mi venne un’idea: chiesi l’intervento dei cani.
Uno di questi annusò il manico del pugnale e si diresse senza esitazioni verso una tenda dell’accampamento.
Era quella di Otto Spengler!
Non lasciai la mano di Layla, ascoltavo le voci.
Lui non c’era, fu chiamato ad alta voce, ma nessuno rispose.
Monsen ordinò di braccarlo con i cani.
Dunque tutto faceva supporre che fosse lui il crudele assassino che aveva colpito la Gallego, anche se poteva avere dei complici o dei fiancheggiatori rimasti nell’ombra.
E perché diamine si era fatto scoprire così facilmente? Aveva agito d’impulso o secondo un piano?
Dovevo rimanere sospettoso e vigile.
«Layla… è stato Otto Spengler a colpirti?», era soprattutto un modo per cercare di mantenerla cosciente.
La Gallego chiuse le palpebre. E le riaprì, per fortuna. Era stato lui, dunque, quel porco di tedesco che si vantava di discendere da Oswald Spengler e che mi aveva avvicinato con la scusa del libro…
Aveva ammazzato Layla, la donna che m’aveva portato sulla luna…
Gli sguardi di coloro che entravano nella tenda e posavano gli occhi sulla donna erano sconsolati. Sembravano dire tutti la stessa cosa: che non ci fosse più molto da fare.
Io, però, non la guardavo con eccessiva compassione, avevo fiducia in lei, e lei stringeva la mia mano, specie nei momenti più difficili: aveva capito che non l’avrei mollata, che la scopata aveva funzionato e che al tempo stesso non era servita a nulla.
L’omicida le aveva affondato il pugnale nello stomaco con rabbia, con un gesto che sembrava carico di risentimento personale, non c’erano molti dubbi a riguardo. Poi forse, per la fretta di andarsene, aveva tralasciato di controllare la morte della donna, oppure si era semplicemente sentito sicuro di averla stroncata.
Paura della fine e frustrazione erano i sentimenti che sembravano lacrimare dagli occhi di Layla Gallego. Ma su tutto spiccava il suo sguardo ammutolito, la sua incredulità di fronte alla scaltrezza dell’assassino che l’aveva sorpresa senza che lei potesse accennare la minima reazione.
Cercai di ricostruire quei momenti fatali: Spengler la chiama sottovoce da fuori, come avevo fatto io la sera prima, lei lo fa entrare, lui si accomoda e parlano; lei è seduta sul giaciglio, lui fa finta di mostrarle qualcosa e invece - fulmineo e letale - tira il fuori il pugnale e la colpisce, tappandole la bocca con l’altra mano per impedirle di urlare; poi attende che gli occhi della donna fissino il vuoto, quindi ne rovescia sprezzante il corpo dalla parte opposta alla sua, per non guardarla più negli occhi, o per avere più tempo per allontanarsi indisturbato; prima di andarsene, spenge la lampada a gas, pensando che il corpo venga ritrovato il giorno dopo.
Interruppi qui i miei pensieri e asciugai il rivolo di sangue che le colava dal labbro e il sudore freddo che le ammantava fronte, collo e petto.
Stava soffrendo molto, a ogni respiro, a causa della lama ancora immersa in corpo. Decidemmo di praticarle un’iniezione di morfina. Venivo ascoltato, perché lei stringeva la mia mano.
Ero spaventato dall’idea di estrarre il pugnale. Non sapevo come fare e degli altri non mi fidavo. Almeno così continuava faticosamente a vivere.
I gorilla di ritorno dalla caccia all’uomo annunciarono a Monsen che Spengler era stato catturato. Il capo della spedizione intendeva interrogarlo subito. Io rimasi accanto a Layla e nel mentre cercavo di farmi venire qualche idea su cosa fare di lei.
![]()
Alla fine un’idea mi venne, ma avrei dovuto farla digerire al Dottor Monsen e anche a me stesso, che l’avevo partorita in un momento di follia.
Purtroppo quando ci si perde tra le braccia di una donna come Layla, tutto il resto appare indegno di essere difeso, incluso il proprio io.
Monsen rientrò nella tenda dopo pochi minuti: evidentemente Spengler aveva cantato senza fare tante storie.
L’espressione del capo spedizione era in qualche modo imbarazzata, come se dovesse farmi digerire qualcosa che non avrei gradito.
D’altra parte io intendevo fare lo stesso con lui, quindi forse saremmo stati pari.
«Spengler ha confessato. È stato lui. Ma il movente è pazzesco. E tuttavia, Dottor Gomez, lei capirà come io debba far prevalere gli interessi della mia spedizione. Comprendo che lei fosse “in contatto”, diciamo così, con la Signora Gallego, ma questo non deve farle dimenticare per quale motivo lei si trovi qui adesso e i suoi obblighi nei miei confronti…».
Non avevo intenzione di arrabbiarmi, pensavo esclusivamente a salvare Layla, se rimaneva una sola possibilità di farlo.
«Mi dica tutto, Dottor Monsen. La sorte di Spengler non mi interessa, purché lei non trascuri di aiutare la Signora Gallego».
«Ebbene, può sembrare assurdo, ma Spengler ha colpito la Gallego per propiziare un rito magico. Non sono un esperto di queste cose, Dottor Gomez, ma Spengler tenterà stanotte di entrare in contatto con lo spirito di Jack Sanders, per farsi rivelare dove egli nascose l’oro dei selvaggi prima di lasciarci la pelle… perché fu una donna bianca, di grande bellezza, con i capelli color mogano, l'unica a essere risparmiata dai selvaggi.
E tuttavia, ne sia certo, alla fine della missione Spengler risarcirà, con la sua parte di tesoro, i danni che ha provocato. Lo garantisco io. Non voglio dissidi fra i miei uomini».
Rimase in attesa della mia risposta, ma era inutile obiettare: era fin troppo chiaro come Monsen fosse accecato dalla brama dell’oro e del tutto indifferente alla sorte di Layla. D’altronde i gorilla che si era portato appresso rispondevano a lui soltanto e perciò non potevo alzare troppo la cresta.
Dovevo preoccuparmi di ottenere ciò che volevo, e basta. La mia missione archeologica era finita: ora ne iniziavo un’altra per cercare di salvare la pelle a una donna.
Quelli che Monsen aveva qualificato come selvaggi erano in realtà i membri di una popolazione indigena di origini molto antiche, che abitava quella regione adottando standard di vita che apparivano primitivi agli occhi degli osservatori occidentali.
Tuttavia questa gente rappresentava l’ultima speranza per Layla. I loro guaritori possedevano conoscenze molto avanzate, anche se venivano minimizzate dalla scienza ufficiale, perché in contrasto con gli interessi economici dell’Occidente.
A me di quella diatriba tra forme di civiltà opposte non interessava nulla: il mio scopo era di tenere in vita Layla e non potevo trascurare l’ultima chance che le rimaneva, anche se questo significava andare incontro a un pericolo mortale, a causa dell’odio, ben giustificato, che quel popolo nutriva verso i bianchi.
«Dottor Monsen, comprendo le sue ragioni. Tuttavia lei è uomo d’onore e quindi capirà che è mio dovere tentare tutto il possibile per salvare la vita della Signora Gallego. E non vedo altre possibilità se non quella di rivolgermi agli indigeni di questa regione. Le chiedo di aiutarmi, ma sarò io solo a rischiare il contatto».
Monsen era visibilmente contrariato.
«Può aspettare domattina?».
«No, ho urgente bisogno di trasportare la Signora Gallego lontano dal campo per fare in modo che gli indigeni si mostrino. Stanno sicuramente seguendoci sin da quando siamo entrati nel loro territorio, ma sono intimoriti dai suoi uomini e aspettano nell’ombra».
«Ma è un suicidio!».
«Devo tentare».
«Come vuole, Dottor Gomez, la pelle è sua.
Ma si ricordi che di belle donne ce ne sono tante in Sud America…».
Forse contento di liberarsi d’un sol colpo di due ospiti ormai ingombranti, mise a mia disposizione un paio dei suoi uomini; con l’aiuto di questi, dopo che fu approntata una barella di fortuna, trasportai la Gallego abbastanza lontano dal campo e feci rimontare la tenda e accendere un nuovo fuoco.
Ringraziai i gorilla, e quando se ne furono andati, mi adoperai per tirar su una sorta di totem della pace, utilizzando alcuni segni simbolici di quella cultura primordiale. Lasciai partire anche qualche urlo, pronunciando i nomi dei loro Dei.
Quindi rimasi in attesa accanto a Layla, resa semicosciente dalla morfina.
Passò meno di mezzora e la punta di una lancia fece capolino all’interno della tenda…
L’arma era brandita da un ragazzo forte e agile.
Se era finita, l’avrei saputo molto presto.
Alzai lentamente il braccio libero, mostrando la mano aperta, ma l’attenzione del giovane fu immediatamente catturata dalla donna con un pugnale immerso nello stomaco.
I suoi occhi intelligenti mostrarono subito di aver afferrato la situazione. I bianchi non avrebbero mai concepito una trappola del genere: troppo elaborata. Per loro le donne erano solo un intralcio.
I suoi occhi si ammorbidirono. Si avvicinò a Layla e sembrò assicurarsi che respirasse ancora.
In segno di pace depose la lancia a terra e disse qualcosa ai suoi compagni, evidentemente in attesa all’esterno.
Quindi si sedette di fronte a me.
Abbassai il capo per ringraziarlo e protesi la mano in segno di amicizia, ma lui non la strinse e indicò la donna. Lo faceva per lei. Mi stava dicendo che lo faceva per lei.
Il piano procedeva meglio di quanto pensassi. E se non mi sbagliavo, il giovane guerriero aveva fatto chiamare un guaritore.
Non molto dopo ne ebbi la conferma.
Riuscii a notare l’arrivo di un anziano, disteso su una specie di lettiga.
Ma non era ferito.
Data la sua età avanzata, gli indios avevano fatto in questo modo per andare più spediti.
Appena vide la donna, trasalì. Era rimasto colpito sia dalla bellezza di Layla che dalla crudeltà della ferita che le era stata inferta. Imprecò sottovoce. Sembrava scandalizzato. Si rivolse al giovane guerriero con un tono minaccioso. Questi cercò di farmi capire qualcosa: si passò il taglio della mano alla gola, simulando uno sgozzamento. Avrebbero ucciso qualcuno, forse cominciando da me…
«Tu non avere paura, uomo bianco», il Guaritore intuì i miei pensieri senza neppure avermi guardato in faccia; parlava la mia lingua in maniera più che passabile.
«Io ho paura per la mia amica».
«Tu ora zitto. Come chiamare tua amica?».
«Layla. Layla Gallego».
«Layla Gallego», ripeté sottovoce.
Il Guaritore preparò pozioni e unguenti.
Le fece bere qualcosa, molto lentamente.
Poi si concentrò, come in trance. Fece un cenno e il giovane guerriero, rimasto in attesa, immobilizzò la donna, lasciandomi tenere la mano.
Stava per cominciare la parte più difficile. Il Guaritore aveva deciso di estrarre il maledetto pugnale.
Applicò un unguento intorno alla lama.
Quindi, come rimanendo in ascolto di un suono di bassissima intensità, cominciò a sfiorare il manico dell’arma, stringendolo a poco a poco, fin quando sembrò che la sua mano fosse diventata una cosa sola col pugnale stesso.
Mezzo centimetro, mezza unghia alla volta, valutando in ciascuna occasione la reazione di Layla, e compensando l’emorragia con un denso unguento verde, il Guaritore estrasse il maledetto pugnale dal corpo della donna. La sua mano rimase a tamponare la ferita che si richiudeva su sé stessa.
Layla tremava come una foglia d’autunno, il volto scolorito in un pallore mortale. Io stavo per vomitare.
Eppure, dopo il terribile stress, la respirazione della Gallego si stabilizzò e i suoi occhi mi guardarono come attraverso un sogno: si era liberata di un grosso peso, non credeva di sopravvivere tanto.
Anche il Guaritore tremava. Come un vero medico, aveva assorbito su di sé la sofferenza e la paura del ferito, ed era perciò esausto.
Ciò nondimeno, continuava a premere la mano sulla ferita di Layla.
Un denso unguento verde, simile a un mastice gommoso, la ricopriva interamente. Da questo strato di mastice non filtrava nemmeno una goccia di sangue, la tenuta era ermetica. Era semplicemente straordinario!
Rimaneva più che aperta la questione dell’emorragia interna, ma a quel punto c’era una piccola possibilità di salvarla.
![]()
Quella lunga notte non era finita.
Si udirono spari e urla. Provenivano dall’accampamento. Forse gli indios erano entrati in azione.
C’era fermento intorno alla tenda.
Infine, il giovane guerriero mi fece cenno di seguirlo. Io mi mostrai titubante.
«Curare io Layla Gallego. Tu conoscere uomo che ha colpito lei?», domandò il Guaritore.
«Lo conosco», e a quel punto non potei evitare di seguire il guerriero.
Mi condusse verso l’accampamento.
O quel che ne rimaneva…
Intorno a me si stendevano morte e sangue.
Era stato un massacro.
Il Dottor Monsen, però, era ancora in piedi e quando mi vide gesticolò al mio indirizzo: «Dottor Gomez! Dottor Gomez, parli a questi selvaggi! Faccia qualcosa! O ci scanneranno come maiali!».
Mi avvicinai.
«Questa gente vuole sapere chi ha pugnalato la Signora Gallego, Dottor Monsen».
«Ebbene, noi lo sappiamo, non è vero? Venite, venite, vi mostrerò io l’assassino…».
Monsen si diresse verso la tenda di Spengler e lo trovò nei pressi, riverso a terra, cadavere, con una lancia nella schiena: «È lui! È stato lui!».
Gli indigeni gesticolavano e cercavano di farsi capire. Nervosi.
«Vogliono sapere perché non è stato lei a punire il colpevole, Dottor Monsen».
Il capo della spedizione impallidì. Balbettò qualcosa, poi cercò di inventare qualcosa di decente: «Gomez, lei conosce la verità! Lei deve raccontare a questi selvaggi tutta la verità! Io l’avevo imprigionato, in attesa di sottoporlo a un regolare processo. Noi non siamo dei selvaggi. Tra persone civili non si usano processi sommari… Gomez, glielo dica!».
Aveva perduto una piccola parte della sua tracotanza, ma pensava ancora di condurre il gioco.
Gli indios mostrarono i polsi di Spengler: erano liberi e privi di segni. Solo la morte l’aveva imprigionato.
«Ci stanno dicendo che il prigioniero non ha sofferto alcuna prigionia», in fondo la situazione era grottesca.
«E dove poteva scappare? Ma c’erano due guardie a sorvegliarlo! Lo giuro! Racconti tutta la verità, Gomez, la prego!».
«D’accordo, Dottor Monsen, racconterò la verità, ma lei è sicuro di volerlo davvero?».
«Quello che vuole lui non ha importanza.
Parla, straniero. Ti ascolto», dalla penombra emerse un possente guerriero, che dall’autorità del portamento doveva essere il capo degli indios; si era espresso perfettamente.
Monsen fu messo in ginocchio con la faccia schiacciata a terra.
Salutai con la mano aperta e cominciai a parlare: «Quest’uomo mi ha chiesto di dire la verità. Tu mi hai chiesto di dire la verità. L’uomo con la lancia nella schiena», e lo indicai per distinguerlo dagli altri, «si chiamava Otto Spengler ed è stato lui a pugnalare la Signora Gallego; pare intendesse compiere un rito di magia nera, al fine di evocare l’ombra di Jack Sanders, un uomo bianco che saccheggiò i vostri tesori e li nascose nella giungla, prima di rimanere ucciso».
Soddisfatto dell'inizio, il capo mi esortò, con un cenno della testa, a proseguire.
«Io sono stato il primo a soccorrere la Signora Gallego, e grazie ai cani, che hanno fiutato l’odore dell'assassino, è stato possibile smascherare il colpevole. Tuttavia, il Dottor Monsen qui presente, il capo di questa spedizione, era il mandante di Spengler, perché interessato a ritrovare l'oro perduto».
«Non è vero! Sei un bastardo, Gomez! Un bastardo!», ringhiò da terra Monsen.
«Il nostro popolo punisce i capi più duramente dei servi», sentenziò il leader degli indios.
Il capo lanciò un urlo e dai suoi occhi si sprigionò una scintilla di fuoco.
Uno dei guerrieri si avvicinò con un machete e tagliò di netto la testa di Spengler; quindi ne smembrò i quattro arti.
Monsen era attonito.
Il capo si incamminò, seguito dai suoi, due dei quali trascinavano Monsen; anche io fui coinvolto e non pochi timori si affacciarono alla mia mente; il giovane guerriero mi posò una mano sulle spalle per rassicurarmi.
Così, aiutando Layla, avevo aiutato me stesso.
Dopo una breve marcia, il gruppo raggiunse i limiti di una palude.
Un guerriero si arrampicò su un grande albero i cui rami si protendevano sopra la mefitica superficie dell’acqua; per sicurezza si legò la vita a una liana.
Quindi un compagno gli passò gli arti di Spengler, uno alla volta.
Il guerriero sul ramo lanciò in acqua gli arti, il più lontano possibile dalla sponda, quindi afferrò anche la testa; in pochi istanti la palude si animò di voraci coccodrilli; quando le acque ne pullularono, il guerriero lanciò per aria anche la testa di Spengler, intorno a cui, prima che toccasse la superficie dell’acquitrino, scattarono le fauci orrende di quelle primitive bestie, in gara tra loro per aggiudicarsi il boccone, in una furibonda tempesta di acqua zampillante.
La parabola dell’Occidente aveva toccato il fondo.
Poi fu la volta di Monsen. Fu legato come un salame e issato a forza sul grande ramo. Quindi fu spinto verso la sua estremità, sulla punta delle lance.
Cercava di non perdere l’equilibrio e intanto invocava pietà, mentre sotto di lui i coccodrilli scivolavano in agguato sul filo dell’acqua.
In mezzo alle sue accorate suppliche, secchi colpi di machete risuonarono nella giungla. Non ci fu misericordia. I capi erano puniti più duramente dei servi.
Il ramo si incrinò, e poi - sotto il peso da maiale - si spezzò definitivamente.
Monsen cadde nel vuoto, ma ancor prima di sfiorare l’acqua, fu squartato in tanti pezzi da una moltitudine di coccodrilli che se ne contesero le parti più grasse.
Il giovane guerriero mi accompagnò indietro, verso la tenda di Layla.
Il cuore pulsava forte, forse l’avrei trovata cadavere.
Invece i suoi occhi erano vitali quando finalmente rientrai nella tenda.
![]()
Il tempo passava e le condizioni di Layla - molto lentamente - miglioravano, grazie alle cure attente e costanti dell’anziano Guaritore.
Ci vollero settimane affinché si riprendesse completamente.
Nel villaggio dove eravamo stati condotti, la Gallego era trattata come una Regina, forse perché la sua florida bellezza sembrava l’espressione allegorica della foresta circostante.
Inoltre, l’aver affrontato e superato una tale ferita le conferiva un’aura sacrale.
L’anziano Guaritore mi aveva garantito che nessuno ci avrebbe trattenuto con la forza, e d’altra parte il soggiorno era tutt’altro che spiacevole.
Layla era una donna troppo forte e indurita dalla vita per provare dolcezza e tenerezza verso un uomo, ma quella drammatica esperienza ci aveva uniti sotto un altro modo.
Il declino dell’Occidente si era compiuto, ma noi ci eravamo salvati, l’uno sull'altra.
Venne infine il giorno degli addii.
Il capo del villaggio aveva preparato una colorata cerimonia in onore di Layla, per festeggiare la sua piena guarigione e salutarla. Poi ci avrebbero accompagnato fin nei pressi di un attracco fluviale gestito da bianchi, non troppo pericolosi. Gli indigeni avrebbero comunicato, a mezzo tamburi, ai loro osservatori a valle, di verificare il passaggio di una barca con a bordo una donna dai capelli color mogano: in quella zona non ve ne era di sicuro nessun altra.
Le indagini della Polizia brasiliana sarebbero state blande, in molti svanivano in Amazzonia e spesso nessuno li rimpiangeva.
Le paludi non restituivano avanzi.
Noi comunque non avevamo niente da nascondere: Layla era stata aggredita, io l’avevo aiutata, non sapevamo altro.
Io, in particolare, non lo sapevo davvero.
Sembrava che tutto potesse filare liscio.
Il giorno degli addii, invece, si rivelò il giorno delle parole di troppo.
Al culmine della cerimonia, la Gallego si lasciò commuovere dal Guaritore che le aveva salvato la vita, e benché nessuno avesse finora osato chiederglielo, si fece scappare le fatidiche parole: «C’è nulla che possa fare per voi?».
Il Guaritore non parlò subito, ma intanto prese le mani della donna tra le sue, per farsi ascoltare meglio; e alla fine glielo disse: «Aiuta noi a ritrovare nostro tesoro».
Layla mi guardò, forse per prendere tempo, non credo chiedesse il mio parere, sapeva che l’avrei seguita ovunque.
«Come pensi che io possa riuscirci, mio saggio amico?».
Il Guaritore rispose anche a quella domanda: «Perché cattivo uomo bianco fatto venire te, in mezzo a foresta?».
Non sapeva solo guarire.
«Io non sapevo cosa volesse da me il cattivo uomo bianco. Mi sono fidata di lui. Ma accetto di aiutarvi».
Di sicuro la Gallego sperava di ottenere una ricompensa, in caso di ritrovamento dell'oro.
Il ritorno alla civiltà era rinviato.
![]()
Il mattino dopo ci mettemmo in marcia.
Non ci furono novità fino al primo pomeriggio del secondo giorno, allorché l’anziano Guaritore fece arrestare il gruppo e parlò con Layla: quella era la zona in cui il razziatore bianco, ferito e braccato, doveva essersi alleggerito del suo pesante fardello, allo scopo di accelerare la fuga.
Era come cercare il classico ago nel pagliaio.
Il Guaritore cominciò a gesticolare e a sussurrare una cantilena; quindi sfiorò lo stomaco di Layla.
Riuscì a parlare, senza muovere le labbra.
«Tu, maledetto! Hai avuto il suo sangue! Ora parla! E troverai il riposo!
Guida i miei passi verso ciò che è nostro!
A te, spirito maledetto, non giova il metallo del sole, né qui, né all'inferno dove sei diretto!».
Mentre ascoltavo basito, cercai di mettere in ordine i frammenti di quella sporca storia, riempiendo gli spazi vuoti con le ipotesi più plausibili.
Jack Sanders, un avventuriero razziatore, sebbene ferito gravemente, era riuscito a fuggire con il tesoro degli indios. Per cercare di sottrarsi al loro inseguimento, si era alleggerito dello zaino, contenente l’oro di cui si era impadronito, contando di riprenderlo in un secondo momento.
I suoi complici erano già morti, tranne una donna dai capelli color mogano... molto bella... con il camicione sbottonato... Layla Gallego.
Era sopravvissuto più a lungo degli altri, ma non abbastanza per riprendersi il tesoro. Le sue ferite lo tradirono. Però, prima di morire, versò qualcosa nell'orecchio di qualcuno, e questi versò a sua volta in quello di Monsen.
Altro che majorette, dunque! L’unico superfluo ero io.
Ero stato assunto per dare una parvenza di serietà scientifica alla spedizione.
Spengler aveva promesso a Monsen che nel caso la Gallego non fosse riuscita a individuare il posto (d'altra parte la giungla cambia continuamente aspetto), ci avrebbe pensato lui, evocando l'ombra di Sanders, di sicuro parcheggiata intorno all'oro, senza però spiegargli come.
 In
effetti il razziatore aveva quasi raggiunto una zona sotto il controllo dei
bianchi, quindi gli indigeni non ebbero la possibilità di effettuare un setaccio
sistematico di quel tratto di foresta, né sapevano che Sanders si era liberato
dell'oro.
In
effetti il razziatore aveva quasi raggiunto una zona sotto il controllo dei
bianchi, quindi gli indigeni non ebbero la possibilità di effettuare un setaccio
sistematico di quel tratto di foresta, né sapevano che Sanders si era liberato
dell'oro.
Nel frattempo il Guaritore, in stato di trance, portandosi dietro Layla, riprese a camminare; giunto in una radura, rallentò fino a fermarsi; senza nemmeno guardare dove andava, si mosse verso un grosso semitronco di mogano, crollato al suolo forse a causa di un fulmine, quasi interamente ricoperto dalla vegetazione del sottobosco.
Sempre in trance, allargò il braccio, un guerriero gli strinse nella mano un machete e con forza innaturale per un anziano, con un colpo secco e quasi liberatorio, calò la lama sul tronco, fracassandolo come fosse cartone.
Il legno tintinnò…
Era stato svuotato dalla cupidigia degli insetti che amano il legno pregiato.
Layla lanciò un urlo e sembrò mancare, io la sorressi.
I guerrieri mostrarono l'oro al Guaritore: quel tronco cavo conteneva lo zaino di Sanders.
Il mogano, l'oro dell'Amazzonia...
Layla mi spinse via e crollò sulle ginocchia, singhiozzando: «Io lo amavo, maledetti...».
Il Guaritore scelse una collana, molto bella, d'oro massiccio, e gliela lanciò contro le ginocchia, con assoluto disprezzo, sia della collana che della donna.
«Portala via...», mi disse.
Per me non ci fu nessuna mancia.
Non avevo un caschetto di capelli color mogano in testa, io.
Un paio di guerrieri ci scortarono presso un punto di imbarco.
L'avventura era finita.
«Sono una cagna, l'hai visto, non valeva la pena di salvarmi».
Non replicai.
«Ho qualche anno più di te, ma non sono finita.
Insieme possiamo farci comodo, Pablo».
«Che facciamo?», stavolta replicai con una domanda.
«Mi
farò venire qualche idea, ma cambieremo zona, non ho intenzione di lasciare la
pelle in questa fogna verde».
Annuii.
Per me l'importante era rimanerle accanto.
Non so se chiamarla ascesa o declino, ma poco importa, quando ti strusci addosso una donna come Layla Gallego.
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)

Era fatta.

L’oro c’era. E tanto.

 Un
grosso deposito abbandonato dai belgi in fuga.
Un
grosso deposito abbandonato dai belgi in fuga.
L’olandese non si era sbagliato.
Con la mia fetta avrei potuto soddisfare i vizi di Layla.
Qualcosa, però, era destinato a non quadrare.
Proprio sul più bello, irruppero sulla scena quattro jeep.
Ci avevano pedinato, la giungla si affollava.
Nessuna esitazione, nessuna pietà, nessun avvertimento.
Tanto l’oro non si sgualcisce e non versa sangue.
RAT-RAT-RAT
RAT-RAT-RAT
RAT-RAT-RAT
Raffiche furiose, resistenza minima, la loro superiorità era schiacciante, l’effetto-sorpresa devastante.
A noi non restava che ripararci alla meno peggio e tentare una strenua resistenza.

Van de Kerkhof era stato giocato: uno squalo più grande di lui voleva mangiarselo e io c’ero finito in mezzo.
Fu in quel momento che Layla ebbe paura e tentò la fuga.
RAT-RAT-RAT
La falciarono con una raffica di uzi prima che riuscisse a scomparire nella macchia.
La Boyle inarcò la schiena, rimase in piedi e girò su sé stessa, mostrando il petto.
Layla intuì che avrebbero sparato ancora, per stroncarla definitivamente.


«NO!!», urlò con tutta la forza che le rimaneva in gola, implorandoli disperatamente con gli occhi, credo, dimenticando però di avere gli occhiali addosso.
Era grave, gravissima, ma forse non ancora condannata.
Quelli, però, volevano essere sicuri di non lasciarsi dietro nessuno, neanche le belle donne.
Si liberò degli occhiali, forse per mostrare la sua disperazione.
Ma non servì a molto.
RAT-RAT-RAT
Un’altra raffica impietosa.
Layla fu crivellata di colpi.
Benché la successione delle pallottole fosse fulminea, in quel lungo istante gli occhi della donna sembrarono sbarrarsi in veloci fotogrammi di allibita sorpresa, nel mentre incassava con l'addome, rinculando leggermente.
Erano davvero tanti.
Povera Layla. Adesso come avrei speso tutti quei soldi?
La camicetta bianca, perfetta per lei, volgeva rapidamente al rosso fatale.
Finito l'attimo, si schiantò in avanti a braccia molli.
«LAYLA!!», urlai con quanta forza avessi in gola, senza poterla raggiungere.
La sparatoria imperversava feroce, anche se la nostra fine era segnata.
Non mi rimase che tentare anch'io il tutto per tutto, buttandomi a capofitto nella macchia.
Fui più fortunato di Layla.
Mi riavvicinai soltanto quando gli spari cessarono e i motori delle jeep sfumarono in lontananza.
L’unico cadavere mancante, oltre al mio, era quello di Van de Kerkhof: un dovuto riguardo per il vecchio squalo.
Una delle nostre jeep era ancora intera.
Caricai in fretta il corpo di Layla, senza guardarla, sul posto del passeggero, come se fosse viva, e cercai di raggiungere un villaggio.
Non sapevo né quello che stavo facendo, né tantomeno dove stavo andando; ero in preda alla follia.
Layla mi cascava continuamente addosso, sferzata dalle vibrazioni della strada sterrata; ma dovevo stare attento che non cadesse dall'altra parte, la jeep era scoperta, un vecchio tipo molto essenziale, con pochissima carrozzeria, cioè tutto il contrario della libanese. Quell'aria da troia si prende solo in medioriente e lei l'aveva presa tutta.
Ogni tanto quasi cercavo di guardarla, con la coda dell'occhio; e la chiamavo; ma non arrivava alcuna risposta; era ovvio.
Tutta la figura era talmente scompaginata che non si capiva nemmeno da che parte fosse rivolta.
Avevo paura di fermarmi e di constatarne la morte.
D’altronde, con una quindicina di pallottole addosso, anche una come lei non poteva essere che morta stecchita.
Alla fine non resistetti più alla tentazione di fermarmi.
Dovevo averne la certezza.
«Layla…!».
La tirai a me, afferrandola per la camicia. Era sbottonata fino allo stomaco, la portava sempre così.
«Layla… parla… è tanto piombo, ma una come te…».
La strattonai.
Aveva la lingua arricciata sotto il palato, segno che si era irrigidita fino all’ultimo per cercare di resistere; una reazione istintiva, non sorprendente in una donna come lei, piena di sé, che avrebbe sperato di trovare una via di scampo anche di fronte a un plotone di esecuzione.
«LAYLA!», le urlai addosso, con il pericolo di richiamare attenzioni non gradite.
La libanese era tutta contratta, raccolta entro sé stessa, irrigidita.
Forse ero pazzo, ma sembrava ancora viva...
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!
Le fracassai le orecchie con il clacson della jeep.
Si divincolò dalla mia presa e allungò la mano verso il volante, come se vedesse per la prima volta un'auto, o cercasse l'origine di quel rumore.
Il cuore mi suonò dentro come avessi premuto un'altra volta il clacson.
Layla aveva conservato un soffio di vita!
Mugugni senza vocali, mentre le mani tremanti si portavano sulla pancia, dove c’era la maggior parte dei buchi.
E la prima, faticosa parola.
«Ma…le…detti…».
«Bastardi…», le feci eco, mentre le tamponavo la pancia con l’ovatta della cassettina e le asciugavo il viso e il collo. Avrei dovuto farlo prima, ma ero sotto shock.
Poi le feci bere un goccio di whisky. E un altro ancora.
«Non hanno… avuto pietà…
Ma io… ho stretto… il culo... ho stretto... e sono… sono… voglio... non voglio... morire…».
Aspettava la fine tutta tesa, cercando in qualche modo di essere pronta a reagire, le mani sulla pancia, la bocca bella aperta per respirare con ansia e tanta faccia tosta per crederci malgrado tutto.
Layla Boyle stava lasciando pelle e tette su quella jeep, in un bagno fatale di lacrime, sudore e sangue, rimpiangendo una vita che stava schifosamente trattenendo a sé con ogni sorta d’artificio, compreso quello della camicetta sbottonata fino allo stomaco e relativo scollo.
D'altronde era il suo marchio di fabbrica. Lei stessa amava guardarsi lì dentro e lo stava facendo anche in quel momento supremo.
La sua prospettiva era diversa da quella di chiunque altro.
«Il cuore… e la testa… sono illesi... io… non sono… finita…».
Le piaceva illudersi, evidentemente.
«Hai ragione, ma ora risparmia il fiato».
Ripartii e raggiunsi un villaggio.
C’era uno stregone: era l’ultima possibilità.
Mentre quello tentava qualcosa, io le tenevo forte la mano.
«Bill… sei stato… la mia rovina…», recriminava la troia.
«Che vuoi dire? L’affare era andato in porto. I rischi c’erano, lo sapevi.
Quell'oro faceva gola a molti...».
«Guarda… come sono… ridotta… uno zombi…».
Lo stregone sorrise.
«Tu, allora... mi hai rovinato più volte, Layla.
Non potremmo lasciarci senza rancore?».
«Io... crepo… come dico io… da donna… che ci ha provato… fino all’ultimo…».
Vedendomi esitare, lo stregone intervenne.
«Tu parlare. Tenere impegnata donna».
«Mi dispiace, Layla. Tra noi non ha mai funzionato; e questi sono i risultati».
«Dovevo… scappare… con te…».
«Hai fatto sempre di testa tua, lo sai».
Stava per andarsene, gli occhi al cielo, la bocca spalancata.
«Layla…».
Un mugugno senza vocali. Era tornata nel limbo.
La Boyle soffriva terribilmente nel lasciare quel polposo impasto di carne.
Bill… Bill…
Diedi io un nome - con un po’ di fantasia - a quei gemiti gutturali.
«Sono qui, Layla», risposi a me stesso.
Lo stregone la riforniva di pozioni, la manteneva in un limbo, tra la vita e la morte. Usava anche siringhe, da queste parti si erano evoluti.
Bill, questa è la volta che mi decido a scappare con te...
Sognare non mi costava niente.
 Però quando voltò leggermente il
capo nella mia direzione, mi venne un dubbio.
Però quando voltò leggermente il
capo nella mia direzione, mi venne un dubbio.
Oh! L'aveva detto sul serio!
E si sforzava di ripeterlo.
«Va bene... ho capito...
Ti fai rattoppare dallo stregone e poi scappiamo insieme».
«Ma...le...detto...».
«Sì, maledetto.
Ma io e te... insieme... noi siamo oro, Layla».
«Stronzo... ce ne sono... un paio... dure... da digerire... Cristo...».
Layla si era fatta i conti.
Tanto oro maledetto, un po' di pallottole da digerire, e uno stronzo a rimorchio.
![]()
![]()
CESSA DEL CONGO
CONTRO
VENERE DI KINSHASA
di Salvatore Conte (2025)

Il Rhino Express fila sul Congo come un coccodrillo famelico.
Nel sottofondo dei suoi barilotti di plastica si può trovare un po’ di tutto, come nello stomaco di quelle bestie immonde.
La Capitana del cargo si chiama Anna Frentzen, detta la Cessa del Congo.
Cinquantanni maturati a
perfezione, possente, bella, risoluta, malamente sbottonata nella sua
camicetta allentata e sdrucita, Anna fa piangere lacrime d’amore perverso lungo le
anse del grande fiume, ed è in grado di carpire con facilità i segreti dei
capi-tribù del Congo.
Secondo alcuni, non esisterebbe donna più bella al mondo; perciò è anche detta
Cessa del Mondo.

Pur tuttavia, commerci inconfessabili l’hanno ingrassata al punto da renderla troppo ingombrante.

È perciò che occorre trovare un contrappeso da opporle; e l’immagine è tuttaltro che metaforica.
Layla Boyle, detta la Venere di Kinshasa, ha il peso necessario all’impresa.


La Venere di Moravany fu rinvenuta nel 1938, lei - invece - una trentina d'anni più tardi, nel 1966.



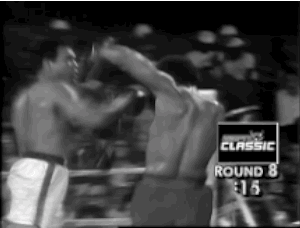 Donnone di razza,
da salotto o da battaglia, morbido, bello, intenso, affetto da certa
splendida steatopigia, è ferocemente conteso dai capi-tribù di tutto il Congo,
alto o basso, belga o indipendente, popolare o democratico.
Donnone di razza,
da salotto o da battaglia, morbido, bello, intenso, affetto da certa
splendida steatopigia, è ferocemente conteso dai capi-tribù di tutto il Congo,
alto o basso, belga o indipendente, popolare o democratico.
Fasciata a perfezione dalle sue camicette allentate fino allo stomaco, Layla è l'incontrastata potenza del grande fiume, immagine sacra agli occhi degli indigeni.
Anna Frentzen e Layla Boyle: i pesi massimi dello Zaire!
![]()
 Lo scambio avviene in mezzo al
fiume, lontano da sguardi indiscreti.
Lo scambio avviene in mezzo al
fiume, lontano da sguardi indiscreti.
Corna di rinoceronte e zanne d’elefante in cambio di molti, moltissimi dollari: i committenti non badano a spese.
La potente Cessa - fasciata morbidamente dalla sua camicetta ampiamente allentata, con bella vista sulle splendide tette a penzoloni - controlla attentamente la merce; secondo i capi-tribù del Congo, vale tanto oro quanto pesa.
Magnifiche creature vengono orribilmente mutilate per la vanità di stupide bestie. E con il concorso perverso di due potenze del grande fiume.
Quel corno tanto lucido e dolcemente ricurvo l'affascina fino a farla sudare.
È talmente catturata che non si avvede della trappola: i suoi uomini vengono fulmineamente liquidati da quelli della Boyle!
La Venere di Kinshasa, con un cenno del capo, indica di procedere.
I due sgherri si avventano alle spalle della Cessa, spingendola forte contro il corno, ben fermo nelle mani di Layla!
SZOCK
La bocca si allarga, gli occhi strabuzzano, la sorpresa la penetra.
Ma è un attimo.
Un ghigno perverso affiora tra le labbra: il Dio l'ha scelta, è entrato
dentro di lei.
E lei non lo deluderà.
A dispetto della mortale incornata, infatti, Anna sente forte la voglia di reagire, vendicarsi e inseguire una via di scampo: è la Cessa del Congo, bella e rabbiosa, non una comune mortale. Non sarebbe finita così.
E in ogni caso, avrebbe trascinato con sé la Venere di Kinshasa.
Intanto, però, la vendetta del rinoceronte è sotto gli occhi di tutti e dentro il ventre della Frentzen!
La Cessa del Congo è incornata dal Dio!
Ma non è finita: un altro cenno della Boyle e i due brutti ceffi si apprestano a spingere ancora più forte...
«Aspetta… così mi uccidi...
Sparirò per sempre... non... non mi farò più vedere...».
«Questo è sicuro...», replica freddamente la Venere di Kinshasa.
«Sono una bella donna... come te... non farlo...», insiste Anna.
Un lampo negli occhi di Layla. Ma è tutto inutile, l’eccidio della Frentzen è deciso.
La Cessa del Congo non ha scampo.
I due flagelli non si fermano fino a quando il corno non spunta dalla schiena della Frentzen!
![]()
Stavolta è la Venere a lavorare, sfilando il corno dal ventre della Cessa, mentre i due complici la tengono ferma.
SWISH
È fuori. Dolorosamente fuori.
Impazzita per la fatale incornata che non le lascia scampo, la Frentzen scivola giù e comincia a strisciare all'indietro sul ponte della nave, schiena a terra, inorridita, rabbiosa, decisa a guadagnare tempo, le mani a pressare con disperato zelo l'enorme buco da cui affiorano le sue stesse budella.
È tanta roba anche per una come lei.
Ora, la Cessa, tanto avida di denaro, avrebbe dato qualunque cifra per una chance di salvezza.
E nel frattempo, ansimante, cerca di incassare il colpo, spendendosi tutta.
La mitica Frentzen afferra disperatamente degli stracci sporchi d'olio e nafta per tamponarsi freneticamente il buco. L'infezione ci metterà molto più tempo dell'emorragia a ucciderla. Vuole provarci, vuole farcela.
I due, giunti a questo punto, si aspettavano una fine rapida.
Per certi versi delusi, per altri basiti e soprattutto ammirati.
«Di questa puttana che ne facciamo?
Sta lottando...».
«Della Cessa, vuoi dire?», la precisazione di Layla è un omaggio alla sua nemica.
Annuisce.
«La Cessa non molla facilmente, va finita.
L'ordine è di eliminarla».
«Prima, però... non potremmo divertirci un po'...?».
«E va bene. In fondo è il suo destino.
Ma state attenti, è pericolosa anche così...».
«Okay, capo, rilassati».
![]()
Layla - forte della sua possanza - sta scaricando nel fiume le carcasse dei due sgherri di Anna.
Evidentemente è intenzionata a prendere possesso del Rhino Express.
Sul suo motoscafo, agganciato al cargo per mezzo di una fune, farà salire uno dei suoi uomini.
Non appena avranno finito con la Cessa.

Il boccone, però, è troppo grosso per i due guitti di fiume.
SZOCK
RAT-RAT-RAT
La Frentzen è entrata in azione!
E qualcuno l’ha già preceduta all’inferno.
Nel momento culminante del maschio, quando la percezione della realtà si annulla, ha estratto un coltello dallo stivale e ne ha trafitto all'origine, in gola, i gemiti di piacere; un attimo dopo, allungando il braccio dietro un barilotto di plastica dove sapeva di trovare una uzi, ha fatto partire una misurata raffica contro l'altro… una pennellata d’artista, con perfetto controllo del brandeggio...
Lo scagnozzo è colpito al petto e finisce in acqua scavalcando involontariamente la sponda dello scafo. I coccodrilli del Congo piangeranno presto nuove lacrime.
Adesso è la volta di Layla...
«No! Come hai fatto?!».
RAT-RAT-RAT
La Venere incassa in pancia (!): è una vendetta efferata, una decina di pallottole tutte per lei (!), quasi a segarla in due (!), da un fianco all'altro, se non fosse per il tronco possente; gli occhi strabuzzano impazziti, per la paura e la sorpresa, nemmeno il tempo di accorgersi che la sua vita è finita e che lei - la Venere di Kinshasa - è morta ammazzata.


Un fatale eccesso di sicurezza.

 L’impatto è violento anche per una come lei: la
Boyle allarga
scompostamente le braccia, indietreggiando per forza d'inerzia, in precario equilibrio,
di un paio di passi.
L’impatto è violento anche per una come lei: la
Boyle allarga
scompostamente le braccia, indietreggiando per forza d'inerzia, in precario equilibrio,
di un paio di passi.
Layla urta la trave di sostegno del ponte superiore, lo fa quasi crollare e stramazza lei stessa su un largo cassone di legno, il corpo a pancia in su, le braccia lunghe sopra la testa (come ad arrendersi), il sangue che cola lento dai buchi, un mortale stupore impresso sulla faccia pallida, più bella e intensa di prima.
La Venere ha avuto il fatto suo.
Se non è crepata, ci manca poco.
È mattanza di donnoni sul Congo.
«Anna… perdonami… mi hai fottuto... sto crepando…», la Boyle si guarda spaventata i tanti buchi che buttano sangue; da un paio di questi esce nero (!); è il suo fegato scoppiato (!); le ferite non le lasciano scampo e nemmeno molto tempo.
«Layla… mi hai costretto... ma adesso... basta...».
La Frentzen, sorretta dai suoi demoni, sembra avere ancora qualche energia da spendere.
Si rovescia a pancia sotto, portando un braccio a tamponarsi il buco nell'addome, mentre con l’altro cerca di accompagnare la spinta delle gambe, strisciando ventre a terra verso la Venere di Kinshasa.
«Layla… sto arrivando… non crepare…».
«Anna... aiutami… sto morendo...», la Boyle, tremante di freddo fatale, si è disperatamente incrociata le braccia sul ventre, cercando in qualche modo di reagire.
«Layla… dobbiamo tentare... ti porto... da un dottore…».
«Io... non volevo... devi credermi… fai presto… ho paura... dammi la mano...», si contorce su un fianco e lascia cadere un braccio fuori dal cassone, attendendo l'arrivo della Cessa, prima acerrima nemica, adesso compagna di sventura e ultimo miraggio di salvezza.
La Venere di Kinshasa prova a non pensare al suo destino, tira al massimo i freni, lotta, suda freddo, per non vomitare subito la vita.
Vuole almeno guadagnare un po' di tempo.
Con la bocca orrendamente spalancata, come un pesce fuori dall’acqua, compensa la mancanza d’aria.
Cerca di distrarsi un po' e di ritrovare coraggio, andando con la mente a quando irretiva i capi-tribù con i suoi balli sfrenati.
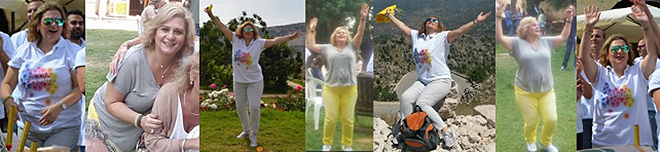
Ora balla per sé stessa, per tenersi la pelle con una danza propiziatoria; vuole ottenere la salvezza, ci proverà fino all’ultimo, con tutti i mezzi, compresa l’autosuggestione.

 La Cessa, intanto, le ha preso la
mano.
La Cessa, intanto, le ha preso la
mano.
«Layla... siamo... sulla stessa barca...».
«Anna... io... m...u...o...i...o...», sussurra disperata.
In effetti il braccio si fa molle e cade a penzoloni, senza più controllo, dal bordo del cassone di legno, sopra cui la Venere è stramazzata dopo la raffica fatale di mitraglietta uzi, che l'ha raggiunta in pancia.
Layla è ormai cadavere. Ha fatto i conti con la realtà.
«Stupida puttana...», mormora tra sé la Cessa. «Io... non farò... la stessa fine... io... posso salvarmi...».
La Frentzen - intravedendo nella fine della sua nemica la sua stessa fine - cerca di rilanciarsi, rinnovando la rabbia.
E continua a strisciare fino alla cabina di comando.
Sorretta dalla sua indomabile volontà, riesce ad aggrapparsi al lussuoso timone del suo sgangherato cargo.
![]()
Il Rhino Express avanza a tutta forza, cercando di bruciare le tappe; il tempo scarseggia.
L’acqua scorre sotto la chiglia, il villaggio è ormai in vista.
L’ultimo obiettivo della Frentzen è lo Stregone Bianco, un medico belga che ha un laboratorio sulle rive del Congo.
Ha elaborato unguenti quasi miracolosi, in grado di cicatrizzare le ferite più devastanti; si dice inoltre che sappia distillare un plasma compatibile con quello umano; infine, che sia un esperto di sedazione pre-mortem.
Dalla riva si vedono arrivare il cargo. Lo conoscono bene. La sagoma del Rhino Express è inconfondibile ai loro occhi.
La barca, però, non rallenta, e punta dritta verso il villaggio.
Comincia a diffondersi un certo allarme.
Viene chiamato di corsa il capo-tribù; e lo Stregone Bianco.
Con il cannocchiale inquadra la cabina di comando.
C’è una donna al timone.
È la Cessa del Congo, in posizione da pilota automatico.
Non lontano, riversa su un cassone, un’altra donna: è la Venere di Kinshasa, dalle inconfondibili forme, il braccio rivolto verso la Cessa, che però non sembra prestarle attenzione.
Il capo-tribù ordina di sgombrare la riva.
Il Rhino Express è in rotta di collisione con il porticciolo del villaggio.
Lo Stregone Bianco mette a fuoco il cargo e scruta i dettagli.
La Venere di Kinshasa è scossa da strani sussulti, probabilmente è in fin di vita.
Si contorce su un fianco, la camicetta è zuppa di sangue, il volto nitidamente visibile, tirato e disperato.
Attanagliata dalla morte, si sbilancia e frana sul ponte, rotolando addosso alla fiancata di tribordo.
La caduta della possente Venere di Kinshasa sortisce un effetto che ha dell’incredibile.
La Cessa si sbilancia dallo stesso lato, la barca vira all’improvviso a dritta, schivando la riva prima dell’inevitabile disastro.
Il Rhino Express è duro a morire.
Il cargo è impazzito, gira su sé stesso diverse volte, scavando l’acqua.
Alla fine, però, il motore strozza e si spegne.
![]()
Non molto dopo, due lettighe trasportano altrettanti corpi, dirette al laboratorio dello Stregone Bianco, nascosto nel folto della giungla congolese.
La postura è la medesima.
Le braccia cadono a penzoloni fuori dalle barelle, le bocche sono spalancate, gli occhi dilatati e increduli.
Lo scontro fra le dominatrici del Congo è finito male per entrambe.
Violente, invasate, famigerate; ambedue potenti.
Il passo lento dei barellieri trasmette una terribile angoscia a chi osserva in disparte.
La mancanza di fretta è un segnale allarmante.
Neanche avvicinandosi, si riesce a distinguere il numero e la tipologia delle ferite, per quanto le camicette delle due donne sono fradice del loro sangue.
La Venere di Kinshasa è tuttaltro che sfrenata, stavolta.
E anche la Cessa del Congo, che di sfrenate ha sole le budella, sul punto di saltarle fuori dalla pancia.
Gli abitanti del villaggio, in triste processione, cercano di cogliere qualche lieve sussulto dai corpi, ma il sentiero accidentato non permette di distinguere tra semplici movimenti inerziali e latenti spasmi agonici.
A qualcuno pare strano che due donnoni tanto potenti si arrendano, si lascino diventare cadaveri, senza tentare un’ultima reazione.
La Venere di Kinshasa è pallida come uno spettro, con la bava alla bocca da entrambi gli angoli; si è spremuta a fondo, le ha provate tutte; ma troppe le pallottole incassate, difficili da gestire anche per una come lei; volto spento, occhi gelati, un braccio molle a penzoloni dalla barella: l'immane tragedia sembra inevitabile.

Si levano grida di disperazione dal villaggio.
C'è incredulità. C'è rabbia.
Sembravano invincibili e invece sono tornate al villaggio in posizione orizzontale.
 Al malinconico passaggio, le
donne soffiano loro in bocca, rallentando le lettighe pur di mandargli aria e
provocarne un sussulto; piacciono a loro quanto agli altri, sono modelli perfetti
a cui ispirarsi.
Al malinconico passaggio, le
donne soffiano loro in bocca, rallentando le lettighe pur di mandargli aria e
provocarne un sussulto; piacciono a loro quanto agli altri, sono modelli perfetti
a cui ispirarsi.
La Cessa del Congo non sta di certo molto meglio.
Pezzi di carne viva si intravedono fra i grumi di sangue, lo sguardo è latente e desolato, come per il fallimento di un grandioso progetto.
 Anche lei è circondata da avviliti
indigeni che esortano le loro donne a soffiarle in bocca. Il potere rigenerante delle compagne
è superiore, secondo le credenze locali.
Anche lei è circondata da avviliti
indigeni che esortano le loro donne a soffiarle in bocca. Il potere rigenerante delle compagne
è superiore, secondo le credenze locali.
E in mezzo a tutto questo, le dita della Cessa vibrano repentine!
È un sussulto, un segnale, è qualcosa.
Per la Venere la situazione è più complicata.
Ha il fegato spappolato ed è stata colpita in diversi organi vitali: stomaco, utero, pancreas... la differenza, pur sottile, si vede.
L’ha tirata per le lunghe grazie al fisico, ma adesso è troppo spremuta.
È per questo che intorno a lei si affolla la maggior parte delle donne.
Le soffiano in gola, impongono le mani, le sussurrano all’orecchio, mentre gli occhi tristi, fissi nel vuoto, della Venere di Kinshasa raccontano la fine della storia: un dolore inconsolabile per la vita perduta.
Ma c'è anche una disperata richiesta d’aiuto, se si legge sulle labbra morte.
Si allunga il passo, si cerca di far presto, i segnali delle due grandi potenze del fiume sono scarsi, ma quegli occhi - carichi di latente attesa - lasciano interdetti, spingono a tentare il tutto per tutto.
«Dentro!», lo Stregone Bianco porta i corpi all’interno del suo laboratorio, anticamera della morte.
Però Anna è stata di parola: l'ha portata da un dottore.
L’attesa del villaggio si protrae.
Sulla Porta di Dite.

![]()
![]()
di Salvatore Conte (2025)
SCIAFF!
Un bicchiere d'acqua gelata in faccia sa fare più male di un pugno.
E io che ho sempre pensato che a farmi male fossero tutti i bicchieri di whisky che butto giù. Che stupido.
Mi ritrovo sdraiato su un letto con mani e piedi legati, e la testa che mi scoppia, e il materasso che si abbassa di lato mi fa capire che accanto a me c'è qualcuno seduto.
«Bentornato nel mondo dei vivi, cowboy», la vista è annacquata, ma intravedo subito che questa è una gran brutta situazione.
«Voi aspettatemi fuori», fa un cenno e le due belle tirapiedi escono dalla stanza senza rifiatare. Gran belle fighe, la lesbica sceglie bene le sue compagnie.


«Finalmente soli.
Vediamo se le piaci quanto le è piaciuto il tuo amico Jim...», mi mette una scatola sul petto coperta da un panno di velluto rosso.
 «Jim... cosa vuoi dire?», cerco di
schiarirmi insieme la voce e le idee, mentre lei tira via il velluto e la
trasparenza del contenitore mi fa vedere quello che ci cammina dentro...
«Jim... cosa vuoi dire?», cerco di
schiarirmi insieme la voce e le idee, mentre lei tira via il velluto e la
trasparenza del contenitore mi fa vedere quello che ci cammina dentro...
Uno schifoso ragno nero!
«Voglio dire che stamani è rimasta vedova del tuo amico...».
Jim... lurida bastarda!
Questa giornata di merda è cominciata una settimana fa, quando il mio uccellino di fiducia mi ha cinguettato che dalla Costa Ovest sarebbero arrivati due uomini con 20 chili di droga.
Come sempre mi ha fornito il profilo completo degli interessati, insieme ad altri fondamentali dettagli: qualità della cocaina, orario d'arrivo del volo, modello d'auto noleggiato, hotel prenotato. E numero di camera.
L'uccellino canta bene quando vuole e chiede il 10% dell'affare: 2 chili su 20 è una cifra ragionevole, a me e a Jim sarebbero rimasti 9 chili a testa, un quantitativo che ci avrebbe permesso di uscire dal giro.
Palle all'aria di giorno e in bocca a qualche puttana di lusso la notte.
Tre giorni dopo l'informazione, il lavoro è già stato fatto, pulito e semplice.
Troppo.
Siamo entrati nella camera 111 dell'hotel, pistole spianate e sguardi e modi di chi ci mette mezzo secondo a mandarti al creatore.
I due uomini della Costa Ovest non hanno fatto storie, hanno tirato fuori le due valigette, pesanti 10 chili di bella vita l'una, e sono rimasti inginocchiati nell'angolo della loro stanza, buoni e docili come agnellini.
L'uccellino evidentemente aveva fischiettato solo un pezzo della canzone, ignorando fra l'altro a chi appartenesse il copyright.
E l'ignoranza non perdona.
Chana… quella partita di droga l'aveva comprata lei, pagandola già per metà.
E noi gliel'avevamo soffiata sotto il naso.
Si era incazzata parecchio, sacrificando subito i due agnellini, ma prima di sgozzarli si era fatta descrivere le nostre facce e con gli identikit in mano ci ha messo poco a scovarci...
![]()

Nome: Chana.
Cognome: Budak.
Soprannanome: la Turca.
Nazionalità: turca a stelle e strisce.
Segni particolari: tutti.
Professione: traffico d’armi, d'organi e avanzatempo droga.
Hobby: omicidi e cose turche.
Copertura: scarsa.
Dress code: scollacciata per vocazione, in genere si sbatte in giro dentro una camicia bianca da uomo, lasciata molto sbottonata.
Gran brutta carta d'identità.
La Turca... non solo per le sue origini ottomane, ma soprattutto per il suo aspetto: pesante, greve, intossicante.

«Vieni qui, piccola...», prende la vedova nera con delle lunghe pinze e la toglie dal contenitore, mettendomela sul petto con una delicatezza che mi farebbe sorridere, se solo avessi un motivo per sorridere.
«Vedi di non muovere un solo muscolo, o un solo nervo. Non muoverti nemmeno con il respiro.
Al tuo amico per crepare è bastato fare mezzo secondo di tutto questo».
Sento le zampe che mi solleticano il petto e la bestiaccia sembra che mi guardi, aspettando che io faccia qualcosa. Giusto per avere la scusa di mordermi, come a dire che non è stata colpa sua.
Legittima difesa; e se ne tornerebbe nella sua scatola completamente scagionata. Innocente.
«Ti concedo 4 minuti e 11 secondi per dirmi dov'è la roba», prende da terra uno stereo e lo mette sul comodino. «La durata di questa canzone.
Trascorso il tempo, se non avrai ancora parlato, e se sarai riuscito a restare sempre immobile, le pizzicherò il culo e ci penserà lei».
Una maledetta bestiaccia nera e una canzone dei Kiss sparata a tutto volume, questo è il metodo che la Turca riserva ai suoi nemici per farli parlare; l'avevo sentito dire, ma avevo sempre pensato fosse una delle tante leggende metropolitane che circolano nei bassifondi del nostro ambiente.
Sbagliavo.
 Qui di metropolitano c'è solo il
traffico che scorre caotico fuori dalla finestra e di leggenda nulla, le zampe
schifosamente pelose del ragnaccio ce l'ho addosso, concrete e reali come le
chitarre dei Kiss.
Qui di metropolitano c'è solo il
traffico che scorre caotico fuori dalla finestra e di leggenda nulla, le zampe
schifosamente pelose del ragnaccio ce l'ho addosso, concrete e reali come le
chitarre dei Kiss.
"Not for the innocent", conosco il pezzo delle quattro maschere di Detroit e so che siamo agli sgoccioli, devo decidermi. La bestiaccia è sempre qui, sul petto, e per ora riesco a tenerla ferma obbligandomi all'immobilità di un manichino da vetrina.
Ma l'altra bestiaccia... non si farà tenere a bada oltre l'ultima nota.
Le regole del gioco me le ha spiegate bene.
«Allora, cowboy...?», porta le pinze a mezzo centimetro dalla schiena della bestia. «I Kiss stanno per tornare dietro il sipario. E non faranno nessun bis».
Peccato, avrei ascoltato volentieri tutto l'album. Anzi tutta la discografia.
La canzone sfuma. Finisce. E lascia la stanza in silenzio.
La quiete prima della tempesta.
«Allora, dov'è la mia roba?», le pinze si aprono vicino al culo della bestiaccia, se si richiudono sono già all'inferno. «Non te lo ripeterò una terza volta, cowboy».
«La roba l'ho già venduta.
Non ce l'ho più», mi decido, parlando in apnea, sembro un robot.
Nei suoi occhi lampeggia una voglia tremenda di ammazzarmi subito, di toccare la sua piccola amica e lasciare che mi faccia fuori all'istante. O di spararmi lei stessa un bel colpo in testa.
Ma non può farlo. È obbligata a controllarsi.
Perché se crepo, crepano con me anche i suoi 20 chili di dollari.
«A chi?», se possibile la voce è più assassina dei suoi occhi.
«Toglimi questa bestiaccia di dosso e andremo insieme da chi...», eh no, Turca, non mi ammazzo con le mie mani.
Mi fissa in silenzio, inespressiva.
Deve soffrire molto a non potermi fare fuori.
«E se invece ti faccio secco e me ne sbatto della roba?».
«Non lo farai. Sono troppi soldi».
E se lo facesse davvero?
La Turca è pazza; e non credo sia un'altra leggenda metropolitana.
Ma rinunciare a tutti quei soldi sarebbe da sciocchi più che da pazzi.
Mi toglie da dosso la bestia, rimettendola nel contenitore di plastica.
«Ti farò fuori appena avrò riavuto la mia roba.
Hai solamente rimandato l’esecuzione della condanna, cowboy».
Un rinvio della pena, al momento mi basta questo. Almeno ho la possibilità di togliere la corda dalle mani del boia, per poi tentare di appenderci lui al cappio.
Si alza e fa rientrare nella stanza le sue amiche.
«Tiratelo su e andiamocene da qui».
«Cammina!», le amiche della Turca hanno modi sbrigativi, ma con i corpi che si ritrovano possono permettersi tutto.
La bionda e la roscia, belle e con le tette gonfie al punto giusto, come lesbica la Turca si tratta proprio bene.
![]()
Mi abbassano la testa e mi infilano in macchina: la bionda al volante a fare da tassista e io nei sedili posteriori in mezzo alla Turca e alla rossa, stretto a pressione fra due grosse paia di tette, che esplodono dalle rispettive camicette. Praticamente, l'uniforme del Corpo Giannizzere della Turca...
«Dove andiamo, cowboy?».
«Forse sarebbe meglio se...».
«Non sarebbe meglio un cazzo.
Dimmi dov'è che dobbiamo andare per riprendermi la roba», la Turca non concede nulla, nemmeno il tempo di finire la frase.

«All'Hangar 14. È lì che tengono la roba, pronta per le spedizioni.
Ma ci sono anche i cani da guardia. E sono armati.
Sarebbe meglio buttare giù un piano, prima di presentarsi così, senza invito».
«Anche noi siamo armate, cowboy», la roscia tira fuori un kalashnikov, e altrettanto fa la bionda, alzandolo nella mano, mentre con l'altra continua a guidare.
«Sei sempre convinto che i cani siano più armati delle cagne?».
No, Turca, sono sempre più convinto che qui ci lasceremo la pelle in parecchi.
![]()
«Fermati qui», faccio accostare la bionda a cento metri dall'hangar, dietro un mucchio di bidoni accatastati.
«Tieni, cowboy. Avremo bisogno anche della tua mira», la Turca mi passa una uzi, che di mira non ne richiede neanche un po'.
«Non hai paura che te la scarichi addosso...?», è veramente pazza.
«Non lo farai».
No, non lo farò. Sono pazzo anch'io, l'ho sempre sospettato.
«Prima di entrare, dimmi chi è quel bastardo che stiamo andando ad ammazzare.
Voglio sempre conoscere il nome di chi mando all'inferno».
La Turca è curiosa.
«Ora puoi dirmelo, ormai siamo sulla stessa barca».
Sì, una barca che punta sugli scogli...
«La Libanese...».
«La Libanese...?!».
Sì, lei, anzi Layla. La rivale più pericolosa della Turca.
«Allora ci sarà anche Sal Virgiliano...».
«Senza dubbio, lei lo tiene a catena...».
«Meglio così, salderò il conto a entrambi».
Ci avviciniamo all'hangar con le armi in pugno e la notte senza luna ci dà una grossa mano, nascondendoci a chi potrebbe venire subito a romperci i coglioni.
«Quattro più la vacca», la rossa ritorna dalla sua avanscoperta, il portellone lasciato semiaperto le ha permesso di contare quanti cani ci sono dentro, oltre alla padrona.
La Turca sbircia dalla fessura con i propri occhi.
«La tua amica si prepara a volare via», fa cenno verso un piccolo aereo parcheggiato al centro del grande capannone. «Magari ha programmato un bel viaggio ai Caraibi con la mia roba. Ma adesso le faremo cambiare destinazione».
Gran brutta situazione.
«Siete pronte?».
«Pronta».
«Pronta».
«E tu, cowboy? Sei pronto, o il puzzo che si sente è perché ti stai cagando addosso?».
«Quando vuoi, Turca».
«Lo voglio adesso», e si infila nello spazio lasciato aperto.
«Fermi tutti! Che nessuno provi a muovere un dito!», dal tono si vede che è un'esperta di queste gran brutte situazioni.
«Buttate a terra le armi!», la roscia le dà una mano nell'impartire le direttive.
«Anche tu, Libanese».

 Layla ha una pistola infilata
nella cinta con cui si stringe la pancia; indossa una camicetta bianca da gran
puttana e una giacchetta nera.
Layla ha una pistola infilata
nella cinta con cui si stringe la pancia; indossa una camicetta bianca da gran
puttana e una giacchetta nera.
È costretta a mollarla.
Layla è una grandissima zoccola, faccia malata da bocchinara incallita, imbolsita e consumata, ma sempre la migliore.
È da poco venuta fuori, non si sa come, da un brutto cancro allo stomaco; però c’è chi dice che abbia solo guadagnato un po’ di tempo, che l'abbiano ripulita d'urgenza, ma con le metastasi che vanno avanti e l'avrebbero uccisa. Avrei voluto approfondire, ma non ne ho avuto il tempo.
 «Che cazzo vuoi, cowboy...?», Sal si
incazza subito con me. «Mi sembra che noi l'affare
l'abbiamo già concluso ieri mattina», mi guarda più incazzato della sua voce.
«Che cazzo vuoi, cowboy...?», Sal si
incazza subito con me. «Mi sembra che noi l'affare
l'abbiamo già concluso ieri mattina», mi guarda più incazzato della sua voce.
«Tira fuori la roba o ti faccio secco prima degli altri, e tu, troia, stai ferma là!», la Turca mi toglie dall'imbarazzo di rispondere a un deficiente.
«Ho capito... hai voluto guadagnarci due volte.
Maledetto bastardo...».
Come al solito non hai capito un cazzo, Virgiliano. Ma non ho tempo per discolparmi.
Il pavimento dell'hangar è un tappeto di pistole, mitragliette e fucili a pompa, i cani da guardia di Layla sono stati ubbidienti e hanno mollato tutti i loro ossi metallici.
Sembra che la gran brutta situazione sia meno brutta di quel che pensavo.
Sembra.
«Andate all'inferno!», da una porta esce un tipo alto due metri con una mitraglietta stretta fra le mani.
Rat!Rat!Rat!
«Uhhh...!», la rossa si becca in pieno la raffica di pallottole.
I cani erano cinque e non quattro, il calcolo sbagliato l'hai pagato caro, lasciandoci le tette, bellezza.
La porta da dove è uscito è quella del cesso. Si può crepare anche per una pisciata, magari fatta in piedi.
Bang!Bang!Bang!
«Bastardo!», la Turca risponde subito e rimette a posto i conti.
Io mi butto dietro la carena del piccolo aereo, non mi va di fare la stessa fine, anche perché Sal e il resto del branco si sono ripresi i loro giocattoli e l'hangar è già diventato un poligono di tiro.
La Libanese è rientrata in gioco.
«Terry...», la bionda è accucciata sulla sua amica, la prende dietro le spalle e riesce ad arrivare insieme a lei fino alla mia postazione.
La roscia è sdraiata vicino a me, conto almeno cinque buchi.
«È sempre viva la tua amica?», sentendola lamentarsi, la mia più che una domanda è un'affermazione.
«Stai calma, Terry... ti porterò fuori da qui», la bionda le passa una mano fra i capelli rossi, prima di alzarsi e scaricare il suo kalashnikov verso gli uomini della Libanese. «Ohhh...!», riesce a centrare uno di quei bastardi, prima che una raffica la colpisca in pieno, buttandomela addosso di schiena. «Salva... la mia amica... ohhh...», e mi crepa con la testa appoggiata sulle ginocchia.
Non ti prometto nulla, bionda. Sarà già tanto se riuscirò a salvare la mia di pelle.
«All'inferno, cani!», intanto la Turca, riparata dietro un grosso bidone, ne ammazza un altro.
Adesso dovremo essere due contro tre. Qui è bene non sbagliare i conti.
«Tirami su... ohhh...», Terry si aggrappa ai miei pantaloni. «Mettimi seduta... e ridammi... la bestia...», l'assecondo, entrambi non abbiamo niente da perdere; la prendo e l'appoggio con la schiena al carrello dell'aereo.
E le metto in mano il kalashnikov della bionda, aiutandola a ricaricare.
«Quei bastardi... devono crepare... insieme... ohhh... a noi...», e guarda la compagna, riversa sul pavimento.
«Se ce la fai, inizia a sparare», voglio cambiare posizione, e da lì sparare all'uomo che si è nascosto dietro una pila di pneumatici usati.
«Ce la faccio...».
Rat!Rat!Rat!
È di parola, ce la fa davvero, la Turca sceglie sempre le migliori, e anch'io ce la faccio.
Rat!Rat!Rat!
Questa è la mia uzi. E quello era il penultimo uomo di Layla.
Due contro due. Più mezza Terry.
Bang!Bang!
«Maledetta puttana!», Virgiliano scarica un paio di colpi contro la Turca, entrambi fuori bersaglio.
Bang!
«Ahh...», a lei invece basta un colpo per beccarlo alla spalla.
«Uscite fuori, bastardi!», adesso li vuole sottomano.
A me non rimane che seguire il duello a distanza, sto portando la pelle a casa e non voglio schivare altre pallottole.
Resto con la mia uzi in mano, ma da questo momento sarò solamente un neutrale guardone.
Screek...!
Il rumore di una porta tradisce chi se l'è appena chiusa alle spalle.
WC, è sempre la porta di quel maledetto cesso.
La Libanese e Virgiliano si sono rintanati lì, la Turca l'ha capito.
La osservo mentre ricarica, calma, fredda, senza furia.
E adesso è pronta.
«All'inferno, bastardi...!».
Bang!Bang!Bang!
Bang!Bang!Bang!
La gragnola di colpi continua a oltranza ed è la porta stessa a cadere pesantemente in avanti.
Lo spettacolo ci concede l'ultima scena, tragica e comica allo stesso tempo.
La scena della morte di Sal Virgiliano e della Libanese di Las Vegas.
Sono seduti sul water, uno contro l’altra, in prima fila Sal, in seconda Layla, busto e testa leggermente inclinati all'indietro a trovare un appoggio che ormai non serve più.
È tutto finito.
![]()
«Quei due stronzi hanno avuto quel che si meritavano...».
«La tua roba è in due sacchi neri sistemati sui sedili dell'aereo.
Ci ho dato un'occhiata fra un colpo e l'altro».
«Allora adesso dovrei ucciderti...», la Turca mi rammenta la sua promessa.
«Ohh... Chana... aiutami...», la rossa è sempre maledettamente aggrappata alla vita e al carrello dell'aereo.
«Terry...», e adesso anche alla Turca, che la rimette in piedi sostenendola con un braccio.
«Vai a prendere la macchina, cowboy.
Mi servi ancora per un po’».
Sarebbe davvero tutto finito, se non fosse che alle mie spalle sento qualcosa spiaccicarsi a terra, qualcosa come uno stronzo cagato fuori dalla tazza...
Mi volto di scatto, appena in tempo per vedere il corpo di Sal a terra e una uzi spianata sulla porta del cesso...
Rat!Rat!Rat!
La roscia è falciata, la Turca è costretta a sacrificarla, tenendosela addosso per pararsi dalla raffica.
Proprio come ha fatto la Libanese, che ha usato il corpo di Sal alla stregua di un giubbotto anti-proiettile...
Non me la sento di intervenire, rimango neutrale.
Si scambiano i colpi, ma per il momento non c’è ancora scappata la morta.
Di questo passo, comunque, una delle due non tarderà a lasciarci il culo; se non entrambe.
Il duello finale, però, non arriva al culmine.
Alcune guardie giurate irrompono nell’hangar...
Di solito non ficcano il naso negli affari altrui, ma stavolta il casino è stato tale che non potevano proprio farne a meno, suppongo.
Le due stronze non vogliono finire dentro e vendono care le tette.
La Turca trova un varco e riesce a svignarsela. Poco dopo, sento una macchina allontanarsi con un pazzesco stridio di gomme.
Layla è rimasta in trappola, ma spara come un’invasata, sta utilizzando tutte le armi dei suoi uomini, compreso un fucile a pompa.
La Turca aveva troppa fretta per pensare alla roba, i sacchi sono rimasti sull’aereo...
Comincia a venirmi l’acquolina in bocca.
 Se avessi la fortuna di vedere
Layla e le guardie accopparsi a vicenda, potrei essere io a chiudere la mano.
Se avessi la fortuna di vedere
Layla e le guardie accopparsi a vicenda, potrei essere io a chiudere la mano.
La Libanese mi ricorda Al Pacino in "Scarface", nella scena-madre finale, braccato e circondato, ormai preda di un’isterica follia.
«Venitemi a prendere, fottuti bastardi!».
Rat!Rat!Rat!
Eccola...!
Layla si è beccata una raffica in pancia!
Per sua sfortuna, un mitra è finito nelle mani sbagliate...
I buchi sanguinolenti sulla camicetta bianca sono evidenti, ma la Libanese continua a sparare come se niente fosse, rimanendo bellamente in piedi.
«Non mi avete fatto niente... capito...? Niente…!».
Però è sempre più isterica.
Rat!Rat!Rat!
A questo punto, entro in gioco io e sistemo l’ultimo bastardo rimasto una volta per tutte.
Bang!Bang!
La Libanese mi ringrazia con un paio di colpi: bell’amica...!
Fortuna che me l’aspettavo...
Riesce a raggiungere l’aereo e ad abbrancare i sacchi con la roba: una mano su quelli, l’altra sulla pancia; non sa proprio rinunciare a nulla.
Barcolla, ma non molla.
![]()
Ne perde uno, ma l'altro se lo porta fino in macchina, e parte con una sgommata da brivido.
Non credo che ne abbia per molto, devo solo seguirla.
Dopo un paio di miglia, infatti, comincia a procedere a strappi, la vecchia troia non ce la fa più. Sbanda a destra e prende in pieno un grosso cactus.
Beep!Beep!Beep!
Il clacson suona all’impazzata, deve essersi accasciata sul volante.
Mi fermo, scendo e la rimetto contro lo schienale.
È stordita, ma respira ancora.
Potrei mollarla lì, ma decido di portarmela appresso.
La tiro fuori, non senza fatica, la carico sul sedile del passeggero, prendo l'altro sacco e riparto.
«Dove cazzo... mi porti...», si è ripresa.
Si tiene gli avambracci incrociati nervosamente sulla pancia, mentre con gli stivali si puntella smaniosa contro la scocca dell’auto, cambiando spesso postura, in una sordida, sensuale, disperata agitazione.
Una vecchia puttana, certo, ma la Libanese è ancora un bel guardare.
«Emiliano... fermati... controllami i buchi... non vorrei che... ci rimanessi secca...».
Mi fermo e le do un’occhiata, fingendo un controllo accurato.
«Quanti sono...».
«Sei o sette... ma nessuno mortale, Layla.
Sei la solita fortunata.
Adesso ti porto nel mio covo e facciamo venire un dottore.
Spiegami piuttosto la faccenda del tumore...».
«L'ho ripulito... ma ho delle metastasi... ho bisogno di soldi... per curarmi...
Tu... non dovevi... metterti... con la Turca... mi hai deluso...».
«Mi ha obbligato, mi ha minacciato, ma lo sai che ho un debole per te».
La gran troia respira pesante, il petto sale e scende irregolare, il sangue le è salito alla bocca.
«Devo... ricostruire... la banda... Emiliano... mi serve... un braccio destro...».
In sostanza, deve sostituire Sal Virgiliano.
«Se hai pensato a me, la cosa mi lusinga molto».
E riparto.
![]()
La Libanese continua a puntellarsi con grande maestria, la suola degli stivali contro il telaio dell’auto, la schiena che si assesta di conseguenza. Layla sta disperatamente cercando di tenere sotto controllo la situazione.
La vedo tentare di allentarsi la
cintura, la controllo con la coda dell’occhio.
«Non credo sia una buona idea, Layla...».
«Forse... capisco... cosa intendi...
Allora... tu... ci tieni... a me...».
«Perché non dovrei... sei sempre una gran puttana, Layla...
La cinta ti tiene insieme, ti tiene allacciata alla vita...».
«Sì... è così... io... mi tengo stretta... la pelle...
Sono pazzi... a sparare così... sono piena... di buchi...».
«Anche tu non hai scherzato, Layla...».
«Ma io... sono... una bella donna... loro no...».
«Tu sei la migliore, ma non tutti hanno il buongusto di capirlo».
![]()
Siamo al covo.
Una villetta rustica ai margini del deserto.
La porto dentro, al primo piano.
La sistemo su un letto a due piazze, al centro, con diversi cuscini dietro la schiena, la faccio morire in posizione eretta, un po’ come fa vivere me adesso. Anche se gliel’ho nascosto per galanteria, si ritrova con almeno due pallottole, tra stomaco e fegato, che la porteranno dritta al cimitero.
«È un bel posto… è tuo…».
«Non proprio. Lo tengo a disposizione per le emergenze».
«Emiliano… io pensavo… che io e te…», si umetta le labbra impastate di sangue e si stira addosso la camicetta.
Vede la morte e fa la ruffiana.
«Layla… pensavo anch’io la stessa cosa… sai?».
È gonfia, abbondante, polposa. La Libanese non ha rivali.
«Però... io... non voglio crepare...».
Me l'aspettavo, mi presenta subito il conto.
«Ho già mandato un messaggio alla mia infermiera di fiducia, è meglio di un dottore qualsiasi. Sa usare apparecchiature sofisticate e a minuti sarà qui con tutto il materiale».
«Ho fatto bene... a mettermi... con te...», farfuglia con la lingua attaccata al palato, sembra una vecchia rincoglionita.
«Tu tieni i freni tirati e andrà tutto bene».
![]()
Anna è arrivata.

Si è trasferita a Las Vegas dalla Costa Est, dopo essere rimasta coinvolta in uno scandalo: sembra che lo prendesse in bocca al Primario; se poi l'Ospedale è pure religioso, allora...
Camice sbottonato e cuscinetti di carne ovunque: più che un'infermiera sembra una grossa troia, ma è brava e arrotonda come meglio crede.
Anna lavora subito con perizia. Layla è fasciata a regola d’arte con tamponi di profondità e una densa schiuma applicata sulle ferite. I buchi sono nove, mi ero tenuto basso per non impressionarla.
Doppia flebo (plasma e alimentazione), ossigeno e monitoraggio cardiaco.
Tutte le cure palliative del caso sono attivate.
«Vuoi salvarla a tutti i costi?».
«Certo, altrimenti perché ti ho fatto venire?».
«Non scaldarti».
Anna inizia a montare uno strano apparato.
Il congegno è alimentato da una comune batteria per auto.
In pratica si tratta di un rianimatore portatile, ma con la particolarità di avere uno stimolatore da introdurre nelle vagina, un cazzo elettrico a tutti gli effetti.
Layla muove la mano, mi chiama.
Accenna a togliersi la maschera dell'ossigeno, vuole parlare.
Anna l'accontenta.
«Emiliano... ho deciso... tu... sei... il mio nuovo... braccio destro... accetti...».
«Accetto, Layla. Sono il tuo nuovo braccio destro».
Il braccio destro di un corpo che non c’é quasi più, è sicuramente l'incarico più bizzarro che abbia mai accettato finora.
Vuole che le stringa la mano, lo faccio e la guardo: gli occhi sono sempre più confusi, come se tentassero di mettere a fuoco qualcosa, è già con un piede e mezzo all’inferno.
«Layla... guarda me...».
La distolgo da visioni aliene, lei deve rimanere con gli occhi su questo mondo, a cominciare da me.
«Emiliano... so che è finita…», finalmente è sincera, la morte evidentemente funziona da siero della verità.
«Non essere drastica, Layla.
Ho armato questo casino per tentare il tutto per tutto.
Qui sei monitorata a vista. È tutto sotto controllo, Layla.
L'infermiera è a tua disposizione, pronta ad assisterti, se le cose dovessero precipitare».
«Su questo non c'è dubbio, cowboy...».
Cristo...
La Turca...
«Te la sei cavata senza un graffio, vedo...».
Il camicione bianco è allentato fino all'ombelico, le enormi zinne le cascano a penzoloni sulla panza da cessa, è evidente che intende provocarmi.
«Non può dirsi altrettanto della tua amica, cowboy.
Non dirmi che ti sei messo con lei...».
«Ho cercato solo di aiutarla, ha poco da vivere e in più è malata terminale di cancro».
«Sì, l'avevo sentito dire.
Però all'hangar quasi mi fotteva, questa gran troia...».
«Tu sei invincibile, Chana».
«Molto galante, cowboy. Ma non so se basterà per salvarti.
Intanto voglio far secca questa troia...».
«È proprio necessario?».
«Lo è.
Spostati, cowboy, e con le mani sempre in vista».
È decisa e spietata come sempre. Ma forse intende risparmiarmi.
«Addio, bellezza...», mi piego sulla Libanese e la bacio. «Dispiace che debba finire così, ma almeno non morirai di cancro».
«Ben detto, cowboy.
Volevi fottermi, vero, Libanese?», la Turca motiva sommariamente la sentenza. «Ma di solito chi crede di fottermi ci lascia la pelle…».
Bang!
"Di solito" non è sempre, Chana.
Un colpo secco rimbomba fra le quattro mura della camera da letto.
Vedo la Turca piegarsi in due.
La accompagno sulla poltrona ai piedi del letto.
«Anna ti darà un'occhiata...», le sussurro.
Mentre la baciavo, ho aspettato che mi sfilasse la pistola dalla cinta, prima di rimboccarle le coperte.
![]()
Anna, però, ha altro da fare adesso.
Layla è in crisi. Sta stirando le zampe.
L'infermiera l'attacca velocemente alla macchina e attiva anche lo stimolatore vaginale.
«Hhggg...gg...hgg...», un terribile rantolo strozzato, gli occhi vitrei, forse gli ultimi secondi di vita della leggendaria Libanese.
«Fai presto... dille qualcosa... non durerà a lungo!», esclama frenetica Anna.
«Layla, ti voglio, non crepare, sei la migliore!», quasi le strillo nell'orecchio.
«È come una macchina che va a due pistoni, non può risponderti, ma vuole vivere, ci sta provando...».
«Layla, puoi farcela, tu e Chana farete la pace e insieme domineremo la feccia di Las Vegas: ci stai?».
Non so se per puro caso, ma cerca di allargare la bocca.
E non so neppure se voglia mandarmi a fanculo, o sottoscrivere l'accordo.
«Forse riesco a stabilizzarla!», esclama ancora Anna.
A confronto di Layla, Chana sembra ferita lievemente, benché abbia riportato un grosso buco sullo stomaco.
Fatto sta che di emozioni oggi ce ne sono state davvero troppe, e di confusione ancora di più...
E se proprio mi gira storto, mi copro con l'infermiera...
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
 Doveva
essere uno scambio di routine, avevo una larga esperienza di queste cose e ce l’aveva pure la mia
socia, Janet Frexhen, ex operativa in Libano.
Doveva
essere uno scambio di routine, avevo una larga esperienza di queste cose e ce l’aveva pure la mia
socia, Janet Frexhen, ex operativa in Libano.
Era da un paio d’anni che facevamo affari insieme in Africa, spesso in piena giungla congolese, come quel giorno.
Funzionava. Soldi e sesso. Era stato un buon periodo.

Si trattava, però, di affari rischiosi; era per questo che si facevano tanti dollari.
Allo scambio erano ammesse soltanto quattro teste. Una di queste voleva tutto il piatto: dollari e diamanti.
A decidere la partita fu la legge del piombo.
E io, per fortuna, fui abbastanza veloce da chiudere la mano.
L’apertura, invece, era fallita: la Frexhen s’era beccata due pallottole in pancia…
![]()
«Che cazzo ti salta in testa…!».
«Io… voglio il massimo… come te…».
«Potevi avvisarmi, almeno».
«Doveva essere… una sorpresa… Bob…».
«E lo è stata…
Ce la fai a camminare?».
«Sì… non è un cazzo… andiamo…».
Guadagna subito qualche metro per dimostrarmi di poter stare in piedi.
Una chiatta a motore ci aspetta lungo un’ansa del Congo. Ma per arrivarci ci sono da coprire duemila metri di giungla.
«Quel bastardo… fottuto… », impreca la Frexhen, tanto piegata in due da non potermi guardare in faccia.
«In fondo lo stavi fregando, no…?».
 «Sì… è vero… ma il
bastardo… gnhh... aveva in canna… pallottole… a espansione… gnhh...».
«Sì… è vero… ma il
bastardo… gnhh... aveva in canna… pallottole… a espansione… gnhh...».
«Dici sul serio?», si tiene l’addome da quando è stata colpita, non ho ancora visto le ferite.
Se ha detto il vero, Anna è spacciata, punterò tutto su Romina.
«Dico sul serio… Bob…
Fammi tirare…».
«Lo sai che non voglio… ma viste le circostanze…».
La faccio sedere contro un tronco.
E ne approfitto per controllare.
Le allargo le braccia.
Cazzo…
Una doppia condanna…
Sono davvero pallottole a espansione, Anna ci rimane secca, non ci sono dubbi.
«Per una come te, due palle in pancia sono niente».
«Lo so… va già meglio…», ringalluzzita dalla roba.
Non perdo nemmeno tempo a tamponarle i buchi.
Le accompagno le mani sul ventre, e la lascio a cuocere nel suo brodo.
L’unica cosa che posso fare, per sveltire i tempi, è prendermela in braccio.
E non è affatto semplice...
![]()
 Ci siamo. Vedo la barca.
Ci siamo. Vedo la barca.
È una chiatta di tipo moderno, con motore fuoribordo, in uso anche ai militari.
Depongo la socia e sciolgo gli ormeggi: inutile star lì a compatirla.
La missione è riuscita solo in parte, rimpiazzare la Frexhen sarà un bel problema.
La vacca si piega su un fianco, la faccia da troia contratta in un’espressione di doloroso rimpianto, le mani pressate sul ventre.
Anna evita il mio sguardo.
La conosco: fa l’offesa, perché non mi sto strappando i capelli per lei.
La corrente è leggera, spengo il motore e vado alla deriva, un po’ come lei.
Devo consolarla.
È la mia donna da un paio d'anni.
 «Anna…», me la tengo
sul petto.
«Anna…», me la tengo
sul petto.
«Bob… ho tanta paura…».
«Non devi averne. Tra poco saremo alla base».
«È durata... due anni… Bob... gnhh...».
«Continuerà ancora a lungo, Anna...», la rimetto seduta.
«Bob… sto morendo… vero…».
«Dovevi pensarci prima, Anna.
Ti ho insegnato che con la pelle non si scherza.
Ma tu hai voluto troppo, pupa.
E magari, se ci rimanevo secco pure io… ti prendevi tutto…».
«Io… io... ho preso… due pallottole… gnhh...».
«Tu volevi fregarmi, Anna; e sei rimasta fregata.
Quando sei stata colpita, hai capito di non potermi più eliminare. Avevi bisogno d’aiuto».
Gli occhi guardano lontano, ho fatto centro. Voleva tradirmi.
«Io... io... ero stanca... gnhh... di questa vita… stanca di te… gnhh... tu e quella vacca...
Adesso... ho paura... gnhh... non voglio... morire così… non lasciarmi… Bob…!», sembra Rita Hayworth nella parte della Signora di Shanghai.
«So come sei fatta. Ti tenevo d’occhio».
Eppure, riuscirò a fare come Orson Welles, che - mentre Rita, ferita a morte, lotta a terra per resistere, aspettando disperata l'ambulanza - se ne va per conto suo?
D'altra parte, ha due condanne in corpo: due pallottole a espansione che le hanno maciullato le budella; è un tipo di proiettile che non lascia scampo, usato per la caccia grossa.
E lei è una grossa troia, infatti.
E voleva anche fregarmi.
Ma è un peccato che non si possa fare più niente.
Me lo tira ancora parecchio.
Non penso di avere il sangue freddo di Orson Welles; anche se ho ucciso diversi uomini.
Dopo due anni non mi ha ancora stancato.
Voglio che muoia tra le mie braccia.
Rimetto in moto e proseguo per la base, accelerando.
![]()
Le anse del Congo passano e lo spettacolo peggiora.
Bocca spalancata, lingua sotto il palato, sguardo allucinato.
Anna è in dirittura d’arrivo.
Forse non arriva neppure alla base.
L’ultima carta che posso giocare in favore di questa troia è quella di portarla al villaggio dei pigmei, un piccolo popolo rimasto ai tempi della preistoria.
Piccoli di statura ma non di cuore, digiuni di ogni conoscenza scientifica moderna, hanno appreso dalla natura le proprietà delle piante e ne distillano molti tipi di veleno.
Non so se ciò basterà per assestare la Frexhen, ma le sue zinne sono sempre più a penzoloni e non ci sono alternative.
Ha una doppia condanna in pancia, è vero, però un mio amico italiano dice spesso che sopra a tutto c’è sempre la Cassazione e che non bastano due condanne per fare un colpevole.
Come sopra, così sotto.
La Cassazione infernale non ha ancora emesso l’ultima condanna.
E allora bisogna che i pigmei prendano tempo.
Bisogna ottenere dalla Suprema Corte almeno un rinvio.
![]()
La massiccia figura della vecchia Romina mi riporta alla realtà.
Ci stava aspettando.
Romina Lopez è un altro grosso mignottone della mia scuderia.
«Anna sta male, la portiamo dai pigmei, tu intanto dalle qualcosa».
«Bob... potrebbe essere pericoloso».
«Non discutere».
Controllo che le dia anfetamina e altra robaccia per farle ritrovare un po’ di verve e rallentare l'emorragia.
«Sei carina… con me… Romina…».
«Siamo dalla stessa parte, Anna.
Ma non ti illudere, sei messa molto male...».
«Attenta... Romina… la giungla… è pericolosa… gnhh... anche... per una vacca… come te… gnhh...».
«Io non mi faccio fottere, Anna.
Io sono ancora intera e sempre pezzo di fica».
«Forza... si riparte...», stanno sempre a discutere.
![]()
Dopo un po', lascio il timone a Romina per controllare Anna.
È ancora lucida: serra le mascelle e strascica gli scarponi sullo scafo, cercando di gestire la poca birra che le rimane in corpo.
È tempo di abbandonarsi ai ricordi.
Con un occhio guardo lei, con l’altro il passato.
«Te lo ricordi quando ci siamo conosciuti?».
«Certo… a quella festa… ho capito subito… gnhh... che eri… uno stronzo…».
«E io che eri una troia...».
«Credo... che tra noi... sia finita... Bob... gnhh...», ma per farmi imprecare si stira addosso il camicione di jeans, pompando le tette. Che zoccola di fiume!
Inaffidabile e volubile, lo sapevo. Ma sempre gonfia come piace a me.
Ma non c'è il tempo di altri rimpianti, perché vedo Romina mettersi la uzi sottobraccio.
Mi volto, c'è una chiatta simile alla nostra che incrocia controcorrente.
Un paio di uomini a bordo.
RAT-RAT-RAT
RAT-RAT-RAT
Un primo scambio di raffiche. D'assaggio.
I due trafficanti seccati da Anna avevano degli appoggi; come me del resto.
Riprendo il volante e imbocco una diramazione laterale. Il Congo ne ha tante.
Ho un po’ di vantaggio. Procedo a zig-zag per confondere le acque, nel senso letterale del termine.
E poi mi acquatto dietro un’ansa a gomito.
Stanno arrivando.
Romina è pronta, non ha paura, le ho insegnato a non averne in questi momenti.
Eccoli!
RAT-RAT-RAT
RAT-RAT-RAT
RAT-RAT-RAT
È finita, beccati tutti e due!
«Bob…!», è la voce di Romina.
Ma adesso non posso darle retta.
RAT-RAT-RAT
Affianco l’imbarcazione e scarico la uzi sui due corpi riversi all’interno dello scafo.
È una precauzione necessaria, voglio essere sicuro, di sorprese oggi ce ne sono state abbastanza.
E purtroppo non sono ancora finite.
Romina è seduta contro il bordo della chiatta...
È stata colpita!
Ha preso cinque colpi in pancia...
Stavolta le è andata storta.
«Non ti agitare, Romina. in questi momenti, se perdi lucidità, è finita».
«Bob… non voglio crepare… voglio rimanere con te...».
«Andrà tutto bene, baby».
Fa la ruffiana, vuole salvarsi, ma almeno è una che non mi ha mai tradito.
Anna, intanto, continua a languire spiaccicata sullo scafo.
È contenta di non aver preso altro piombo, glielo si legge in faccia.
In più ha annusato il sangue di Romina, come Romina aveva annusato il suo.
Adesso sa che anche la Lopez è condannata, che si accompagneranno all'inferno.
Non mi resta che proseguire con il programma.
Anzi lo devo raddoppiare.
![]()
In meno di mezzora sono dai miei amici.
Gli ho sempre portato qualcosa. Mi aiuteranno.
Parlo con lo stregone e mi metto d'accordo.
Vuole una delle due.
«Ora sta a voi, ragazze. Non mi deludete…».
E le lascio in piccole, ma buone mani.
Mi accendo una specie di sigaretta, che riempio con un’erba nera che conoscono solamente i miei piccoli amici; una vera bomba allucinogena, per questo mi limito a inspirarne solo un paio di boccate, ho bisogno di restare il più lucido possibile per portare il culo fuori da questa foresta.
I pigmei saranno anche rimasti allo stato primordiale, ma sanno bene come fare gli affari.
Se non ne rimane nemmeno una, resti tu al posto loro...
Lo stregone si è parato il culo, prenotando il mio...
Meglio trovare un’alternativa, non vorrei sperimentare sulla mia pelle la teoria dell'uomo piccolo uguale cazzo grosso.
Con un piede appoggiato alla chiatta, guardo il Congo: solitamente è con questi panorami che mi viene l'ispirazione.

«Portatemi dallo stregone».
Eccola, puntuale come al solito.
I tre piccoli uomini che mi stanno facendo ombra da quando sono arrivato al villaggio, mi indicano il cammino con le loro rudimentali armi fatte di legno e pietre appuntite.
«Te le lascio tutte e due, le donne».
Lo stregone mi guarda inevitabilmente dal basso verso l'alto e tira una grande boccata di erba nera, e gli occhi gli si accendono come la punta della sigaretta.
Borbotta qualcosa e indica il fiume, e se possibile tira una boccata ancora più lunga e profonda.
La punta aguzza di una lancia mi sfiora il culo, facendomi intendere che posso prendere la via che mi riporta alla chiatta: è un sì.
E il mio culo se l'è cavata con un lieve solletico.
Poteva andargli molto peggio.
Due pallottole a espansione per Anna e cinque colpi di mitra per Romina, due donne morte al prezzo di un uomo vivo: questa volta te l'ho buttato in culo io, piccolo simpatico stregone.
Accendo il motore della chiatta e il casino che fa copre tutto, dai rumori dell'Africa ai rimorsi.
Magari una delle due ce la farà pure, con molta fortuna, a non lasciarci la pelle.
Entrambe no, la percentuale è pur sempre matematica e non va sfidata oltre il ragionevole.
Quindi non avrei preso niente comunque. E anzi, avrei rischiato di rimetterci.
Guardo l’interno dello scafo, e ovunque c'è il ricordo di Anna e Romina, lasciato sotto forma di strisce di sangue.
Avrei dovuto restare al villaggio per consolarle fino alla fine: ma lo stregone ha rilanciato troppo forte, non potevo rischiare l'intera posta.
E la chiatta se ne va, mentre il Congo si è fatto più nero dei suoi abitanti; e della mia stessa anima; anche se cerco di rischiararla con una grossa sigaretta allucinogena che adesso voglio fumarmi fino in fondo.
![]()
SEI MESI DOPO
Non posso lamentarmi, gli affari mi stanno andando proprio bene; solamente con l'ultimo - un passaggio in lavanderia di un bel mucchio di dollari - sono riuscito a tenermi in tasca centomila bigliettoni, lavati, puliti e stirati.
Sì, ultimamente la ruota sta girando per il verso giusto.
Forse troppo.
Quando la pallina si ferma ripetutamente sul tuo numero, è bene alzarsi e cambiare tavolo, tutto è opinione a parte la matematica: i numeri non mentono mai e sfidarli, specialmente nel mio campo, può comportare grossi problemi di salute, diciamo così.
Sarà per questo che mi ritrovo al molo 22, aspettando nervosamente l'ora dell'incontro.
Uno scambio facile-facile, una valigetta di polvere in cambio di una piena di dollari. Combinerò per venerdì sera al molo 22...
Se vuoi, ti spedisco anche due dei miei a tenerti compagnia...
No, fottuto di un Lacasette, dei tuoi tirapiedi non so che farmene, io lavoro da solo.
Almeno da sei mesi a questa parte.
Il contatto lavora per un pezzo grosso, un senatore.
Fornisciti della roba migliore che ci sia sul mercato e alza pure il prezzo, il senatore non ha problemi di liquidità...
Le 23.46, l'appuntamento con il contatto è a mezzanotte, devo aspettare ancora, e ormai sono quasi due ore che aspetto.
È sempre così quando mi sento nervoso: arrivo prima agli incontri, mi serve per prendere confidenza con il posto e per calarmi nella parte.
Due fari a farsi luce fra la leggera nebbia portuale fanno un giro attorno alla mia macchina e dopo essersi rimessi in linea davanti a me, si fermano a una decina di metri dal mio cofano.
L'attesa è finita.
Dall'auto scendono due uomini, più neri di questa fottuta notte, e mentre il primo si piazza davanti a coprire un faro, il secondo apre la portiera posteriore destra: il mio contatto si tratta bene.
Scendo dalla macchina, valigetta nella mano sinistra e mano destra pronta a infilarsi sotto la giacca ad altezza gingillo di ferro.
Cazzo...
Due belle scarpe rosse con tacchi a spillo, ecco quello che esce per primo dalla portiera posteriore.
Il contatto è una donna; salvo sorprese.
La penombra lascia intravedere solo i contorni della sua imponente figura.
«Mezzanotte spaccata...», resto fermo e aspetto che si avvicini lei. «Mi complimento per la puntualità», è da galateo rompere il ghiaccio con una signora.
«Sono sempre puntuale, Bob... dovresti saperlo bene».
La voce mi arriva dritta in faccia e mi colpisce mille volte più violenta di un pugno.
Non è possibile...
Arrivata a meno di due metri da me, riesco a vederla bene.
Per tutti i diavoli dell'inferno...
La voce combacia con la figura.
È lei.
«Non mi dai la bentornata dall'aldilà?».
«An...na...», per quel che mi ricordo, penso sia la prima volta che mi trema la voce.
«Sì, proprio io, Bob...», mi fissa penetrando con lo sguardo la notte e la nebbia in un colpo solo. «A volte capita di ritornare dall'inferno. Anche da quello più nero».
«Due pallottole a espansione in corpo... ero sicuro ci saresti rimasta secca...».
«Invece non sono bastate», si stira addosso il camicione di jeans, lo stesso di quel giorno, e si sfiora i buchi, rammendati a perfezione, lasciando intendere che anche la pelliccia è andata a posto.
«I buchi mi avevano sgonfiato, ma adesso mi sono rigonfiata a dovere». Vedo, vedo. «E tutto per quella troia di Romina. Non mi guardavi più, Bob». Tradisco la curiosità con gli occhi. «No, lei non ce l'ha fatta.
Non ha il mio fisico.
Ma prima di crepare mi ha raccontato tutto.
Stava con te solo per i soldi. Alla prima occasione ti avrebbe mollato.
Io stavo già meglio, lei continuava a lottare.
L'avevo lasciata da poco, dovevamo rivederci la mattina dopo.
Un clamore si alzò improvviso per il villaggio.
Era la notizia della sua morte.
Non c'era più niente da fare.
Solo io ce l'avevo fatta...».
Intanto i due uomini mi si piazzano di lato, uno a destra e uno a sinistra.
L’urlo di una sirena, una nave che parte, e il ricordo della mia chiatta che se ne va lungo il Congo, lasciando tutto dietro di sé, Anna e Romina comprese.
«Spogliatelo di tutti i giocattoli», i due colossi d'ebano, forse due souvenir riportati dal Congo, mi alleggeriscono senza darmi la facoltà di protestare: le uzi che mi puntano in faccia mi sconsigliano mosse false.
«Anche la pistola che tiene legata al polpaccio destro».
«Ti ricordi anche questo...».
«Non dimentico mai nulla, lo sai».
«Vacci piano... sono sempre stato molto sensibile là sotto», mi struscia una mano sull'uccello, su e giù per un paio di volte.
«Voglio solo essere sicura che nel frattempo non hai aggiunto altri nascondigli...», e rassicurata ritorna qualche passo indietro, lasciandomi in faccia il suo alito da vecchia troia.
C'è poco da fare: è sempre il massimo. Non credo ci sia in giro un'altra donna come lei.
«In un finale scontato adesso dovresti vendicarti, facendomi fuori e prendendoti gratis la mia bella valigetta...», mi gioco le ultime fiches rimaste. «Ma queste trame, Anna, lasciamole agli scrittori di serie B». La guardo cercando di trovarle gli occhi. «Io che prendo un colpo in testa e tu che rimetti il tuo bel culo in macchina, dopo che i tuoi scagnozzi mi hanno spedito nelle acque puzzolenti del porto».
«Già... un bel finale scontato, non c’è che dire».
«Ma tu non sei mai stata una donna scontata», seppur sincero, con il tono sconfino volutamente nell'adulazione.
«Sì, Bob... non sono mai stata una donna scontata.
Ma invecchiando ho capito che quasi sempre nello scontato si trova la via più facile», le sirene del porto continuano a lamentarsi una dietro l'altra e per non rischiare di perdermi qualche concetto, mi improvviso anche lettore labiale, adesso ogni parola può essere pesante come piombo. «E cosa c’è di più facile di tutto questo?», tira fuori un bel gingillo calibro 38 da dietro la schiena.
«Niente», non le do certo la soddisfazione di supplicarla. «Più facile di questo non c’è assolutamente niente, Anna», col petto gonfio e senza nessuna benda sugli occhi; se vuole farmi la pelle, me la deve fare così, senza concedersi ulteriori godimenti da vecchia bagascia.
«Andate a prendere la valigetta».
Un attimo di smarrimento negli sguardi che si cercano interrogativi fra loro.
«Ma signora perché dovremmo prendere...», il nero più grosso prende parola e iniziativa, tutto insieme e tutto d'un fiato.
«Ho detto di andare a prendere quella fottuta valigetta.
Tutti e due», Anna ha sempre saputo come farsi intendere.
«Se è questo che vuole, signora...», e come due cagnacci scuri si avviano verso la macchina dando la schiena al molo 22.
Cosa diavolo vuoi fare, Anna?
Vuoi farmi crepare con la valigetta piena di soldi in mano, per farmi rimpiangere ancora di più il fatto di doverci lasciare la pelle?
No, Anna... non deludermi.
Questo sì che sarebbe un finale scontato.
Già... proprio un copione del cazzo: la vendetta di un mignottone che ritorna dall'inferno per fottermi, e visto che c’è, per fregarmi cinque chili di cocaina purissima.
Va bene, Anna, starai anche per fottermi, ma di sicuro non vincerai mai l'Oscar quale migliore sceneggiatrice.
Ancora il lamento stridulo di una sirena.
BANG
BANG
Gli spari si sentono appena. O forse li immagino soltanto.
«Ho voluto darti retta anche questa volta, fottutissimo bastardo».
Laggiù in terra, vicini come due grosse cagate di elefante, ci sono i souvenir africani...
«L'hai detto anche tu, non sono mai stata una donna scontata», le unghie smaltate di rosso-puttana mi spingono all'indietro fino al paraurti della mia macchina. «Sono potente, nessuno può fermarmi...», e mi infila un tacco nello stomaco, sdraiandomi di schiena sul cofano. «Prendimi, Bob... una volta eravamo invincibili insieme, ora lo sono anche per conto mio...», si piega su di me e lascia che il suo seno molle da vacca cinquantenne mi penzoli vicino alla faccia. Mi tira giù la zip e si serve da sola. «E cerca di non farmi rimpiangere lo stregone», si umetta le labbra e inizia subito la cavalcata, senza sella né redini, coi tacchi al posto degli speroni a strusciare sulla carrozzeria.
Cavalca e mi viene da sorridere.
Per essere vivo.
Per la situazione.
Per le due cagate nere che iniziano già a puzzare al posto mio.
E sorrido per quello che ha detto.
Cerca di non farmi rimpiangere lo stregone...
Avevo quindi ragione: lo stregone pigmeo era basso d'altezza ma non di lunghezza...
Certe vecchie teorie non sbagliano mai.
Quindi, Anna, pensandoci bene, perché vorresti vendicarti?
In fondo ti ho lasciato in buone mani, no?
«Sì... così, Bob... ohh... ancora...», il suo sguardo sopra di me a un alito dal mio.
Su e giù sopra di me, e noi due sopra il cofano, con la lamiera che si avvalla sotto il peso dei suoi chili e della sua libidine incattivita dallo scoparsi me, quello che l'ha venduta al cazzo di un pigmeo per guadagnarsi il proprio culo.
Una delle tante luci vaganti del porto incrocia un oggetto sopra il mio naso e lo fa scintillare casualmente portandolo per un momento in primo piano.
«Non avrai pensato sul serio di cavartela solamente con una scopata», e la sua calibro 38 si muove in sincrono con le sue anche, che spingono dentro e fuori il mio membro.
Maledizione. Non farlo, Anna.
«Ohh... godo... e ti sparo...», e da come sta gemendo penso davvero di avere i secondi contati. Il tempo di una fica che si bagna. Una fortuna per pochi quella di morire scopando. «Fottutissimo… bastardo... vengo... ohhh...».
Mi pianta le unghie nel petto insieme alla canna della pistola: il tempo è scaduto.
BANG
BANG
«Uhhh!».
UEEE! UEEE!
Maledette sirene, mi fate perdere le sue ultime parole.
«Cosa... cazzo...»,
giusto il tempo di guardarsi.
«Io... non l'avrei... mai...
fatto...», sospira tirata.
Di solito chi muore non mente.
Peccato, Anna, hai tirato troppo la corda. Un'altra volta.
Adesso vediamo chi ti ha fottuto e cosa farà di me; ma intanto ho guadagnato
tempo, mentre tu l'hai perso, vecchia troia.
La pistola scivola via come una saponetta, ma le mani piantate addosso a me continuano a sostenerla, tenendomela precisa sopra, come stesse ancora scopandomi.
Con l'unica differenza che adesso lo sta facendo senza più muoversi.
Un mimo senza gesti.
Una pianta ferma al vento.
«Anna... davvero non lo avresti fatto...?», glielo chiedo anche se non può più rispondermi: ha due grossi buchi sulle tette da puttana rimaste a penzolarmi, sgonfie, a due centimetri dalla faccia.
E il sangue comincia a sgocciolarmi sulla bocca, facendomi assaggiare un sapore che avrebbe potuto essere il mio. Ma è quello di Anna.
«B…o…b…», mi chiama dall’inferno, con l'ultima bolla d'aria; incredula, impotente; l'hanno sfondata, senza lasciarle scampo. Voglio proprio sapere chi è stato.
Sono talmente preso dalla mia vecchia troia che me la tengo addosso, rigida come un cadavere.
E continuo, perché no, se lei è arrivata, voglio arrivare anch’io.
In fondo provo a rianimarla, è una buona azione.
Anna mi guarda con occhi vitrei, ma sembra godere anche lei.
Solo quando mi libero, tento di sfilarmi.
Ma non è una cosa semplice.
Mi ha di fatto seppellito sotto le sue tette sanguinolenti.
Devo sforzarmi per muovermi da quella posizione e a fatica provo a staccarmi da dosso la Frenzhek, che è diventata più pesante e immobile di una statua di marmo: non vuole proprio saperne di separarsi da me.
Evidentemente ho retto bene il confronto con lo stregone.
Riesco finalmente a farla uscire da me e la lascio scivolare all'inferno, lungo il cofano, sempre con le braccia tese e il corpo contratto nella posizione assunta nei momenti fatali, quando si è beccata il cazzo e le pallottole, e c'è rimasta secca; allora si rovescia a terra e finalmente allarga le braccia, arresa al destino.
«Sarei quasi tentata di spararti io stessa…».
«Romina...!».
Sono senza parole.
La matematica è andata a farsi fottere.
«Anch'io ho il fisico, Bob...
Ma non potevi staccarti prima?
Era sola una vacca sfasciata, fuori di testa».
«Ho provato a rianimarla…».
«Troppo tardi, bello…
È stata la vostra ultima scopata».
«Cazzo, potevi beccarla alla spalla…».
«Non l'avrebbe nemmeno sentita».
«Hai ragione, tanto peggio per lei.
Era tanto orgogliosa dei suoi buchi: ora ne ha aggiunti altri due alla collezione».
«Bastavano anche per un elefante.
Io mi prendo la loro valigetta, tu ti tieni la roba, va bene?».
«No, la consegna devo farla lo stesso.
Gli metto la roba in macchina e mi prendo i soldi.
Con questa gente non si scherza».
E nel frattempo mi chino su Anna, mettendole due dita sul collo.
UEEE! UEEE!
Ancora quelle dannate sirene...
Non ti fanno capire niente.
![]()
![]()
«È morta, Bob.
L'ho condannata».
«Sì, Romina... ma stavolta voglio essere sicuro».
«L'ho fottuta: stavolta non la salva nessuno...
Ma una valigetta è mia, senza di me saresti morto».
«Lei ha detto che non mi avrebbe sparato...».
«E tu le hai creduto?
Non dimenticare che ho io la pistola... e che due valigette sarebbero anche meglio di una...».
Allora la vecchia Anna non aveva tutti i torti su Romina...
Le rimetto due dita sul collo.
«Anna... è rimasta uccisa...», sono ancora incredulo.
«Andiamocene…», mi prende per il braccio e mi costringe a staccarmi.
«Ma…»
«Te l'ho detto: è finita, non vedi?».
La grossa mignotta ha gli occhi fissi sulle stelle.
Anna...!
Mi rendo conto che ha ragione, non serve a niente stare lì.
Le lancio un ultimo sguardo, non ricambiato, e mi infilo in macchina, mettendo in moto.
Ingrano la retromarcia per non schiacciarla come una merda e mi allontano lentamente, guardando negli specchietti con una strana ansia.
La vecchia troia, però, non accenna a muoversi... neanche un sussulto... è morta stecchita!
È finita sul serio, stavolta.
UEEE! UEEE!
Stavolta sono le sirene della polizia. Per fortuna qualcuno ha visto, o sentito. Altrimenti l'avrebbero ritrovata fra diverse ore.
Chissà se con una bella scarica...
«In fondo avrei dovuto saperlo fin dal primo momento che la conobbi».
«Cosa, Bob?».
«Che per lei ci sarebbe voluta, come minimo, una doppia condanna...
Forse anche tripla...».
UEEE! UEEE!
E mentre le stramaledette sirene mi salutano, ripenso a quei lievi battiti.
Chissà se ricorrendo a una bella scarica... si riuscisse a portarla in Cassazione...
Intanto inchiodo l'auto e faccio sbattere il grugno a Romina.
Dovrà fare un bel bagno d'umiltà.
Se la vedrà Lacasette con il senatore, avrà in mano la roba e i soldi. Anna non mi aveva ancora sparato, in fondo.
Mi fermo sulla collina che domina il porto: c'è concitazione intorno a lei, tra gli stregoni bianchi.
L'ambulanza non riparte subito.
Anna è arrivata in Cassazione.
![]()
ALTRI SEI MESI DOPO
«Non sei ancora pentito della tua scelta?».
«Per niente», il camicione sbottonato non lascia adito a dubbi.
«Perché lo hai fatto?».
«Me ne sono scopate tante, ma tu sei speciale, lo sai».
«Forse quella sera t'avrei sparato veramente; te l'ho detto: non avevo ancora deciso».
«Non fa niente, me lo sarei meritato; nemmeno un giudice sa subito cosa decidere: tu c'hai riflettuto insieme a un bel cazzone entrato nella tua Camera di Consiglio...».
«Bob... che faccia avevo quando... mi ero appena presa le due pallottole?
Le ultime due, intendo...».
«Quella di una morta...
Mentisti perfino in quell'occasione...».
«Mai stata più sincera, invece.
In un momento come quello è impossibile fingere, anche per una come me.
Ero davvero morta, ma per un niente, per un cavillo, ero ancora aggrappata alla vita e ho cercato di sfruttarlo».
«E ci sei riuscita.
Ora però ci sposiamo e passi dietro una scrivania.
L'inferno ha già battuto tre volte».

![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
«Perché una come te, che poteva avere tutto, si è ridotta così?».

«Senti... senti...
Perché un ragazzo come te, che poteva fare tante cose, si è ridotto così?».
«Ma è vero che tieni nascosto un kalashnikov?».
«È una cazzata, come tante…».
«Me l'hai fatto venire duro, voglio farti».
«Allora mettici sopra un pezzo da 50 e vieni a fottermi…
Vediamo cosa tieni nascosto tu…».
Visti i soldi, che si aggiungono ai 300 di prima, la potente Anna Frezzante si distende sulla branda e allarga le cosce.
«Mi piaci perché sei una zozza, una vacca...
Solo tu ti sbottoni le camicette in questa maniera qui... come fai...».
«Non sei tanto stupido, in fondo...
È un cannone… ohhh… altro che kalashnikov…!».
«Ahhh… Anna… mi fai impazzire… a cinquant’anni sei ancora bona…
Solo tu… mi fai venire così…».
Anche oggi tanti ricavi, ma nessun fornitore pagato.
Anna non paga nessuno, è decisamente una cattiva pagatrice.
Non paga le tasse sulla casa, ad esempio, perché vive in una baracca sul Tevere, in un villaggetto abusivo a pochi metri dalla Salaria e dai suoi uffici di lusso, uno dei tanti ghetti invisibili di Roma. Una riserva naturale, sulla carta; una fogna pestilenziale a cielo aperto, nella realtà delle cose.
Il giorno dopo, qualcuno viene a ricordarle che non paga nemmeno la merce.
«Lo sapete che sono malata, no? I soldi mi servono per curarmi».
«Sono tutte storie, a me non sembri tanto malata...».
«Vi ho fatto vedere le analisi. Ho solo bisogno di un po' di tempo per rimettermi in piedi. Lo sto tenendo a bada. Ma se mi aggravo, ci lascio la pelle. Se riparte, hanno detto, è una fiammata; una fiammata che mi farà secca...», cerca di convincerlo e di farsi commiserare.
«Io so solo che noi paghiamo a vista. I turchi non scherzano, dovresti saperlo».
«Anch'io non scherzo».
«Non fare la dura. La tua posizione scricchiola, Anna.
Non vorrei che al Capo venisse in mente di fare una chiacchierata proprio con i turchi... quella è gente che fa pure il recupero crediti».
«Adesso che me l'hai detto, lasciati un po' andare…
Metto su il caffè».
Anna ha fatto la spia in Libano, è lì che ha imparato a usare il kalashnikov.
Si ripresenta poco dopo con il camicione di jeans pesantemente allentato, le zinne in vista e le tazzine in mano; lo zucchero lo conosce.
Il caffè diventa un aperitivo, la prestazione è gratuita, un omaggio all'esattore poco efficiente.
«Se decidono di farti la pelle, ti avviso».
«Ci conto, Carlo. Grazie. E tornami a trovare...».
![]()
In questo tratto la sponda del Tevere è ripida, oscura, fitta di boscaglia e canneti; è una giungla urbana, ma non in senso metaforico; a riva approda un po' di tutto: imballaggi, lattine, bottiglie, perfino copertoni d'auto.
Anna è sola, adesso.
Anche stavolta l’ha sfangata con il fisico.
Però non deve esagerare; una triplice minaccia pende sul suo capo: lo stesso coltellaccio con cui medita di farla finita, i vermi che la divorano da dentro e le pallottole dei suoi esattori.
Anna vive di espedienti, truffe, spaccio e prostituzione; fa la cantautrice per i servizi e riceve in cambio la necessaria tolleranza per tirare avanti. Sempre sul filo del rasoio, in molti si sono ripromessi di aprirla fino all’ombelico e di buttarla nel Tevere, ma in fin dei conti nessuno l’ha ancora fatto.
Lei pensa sempre di fregare o incantare tutti, compreso un brutto male che le sta scavando la pancia, ma che riesce ancora a gestire, non si sa per quanto.
Così Anna consuma la sua sporca esistenza.
«Se provano a farti fuori, li ammazzo tutti».
A parlare è Johnny, un uomo della Magliana, la viene a trovare con un piccolo motoscafo.
«In fondo hanno ragione, no?», Anna fa finta di contraddirlo.
«A una donna del tuo stampo è permesso tutto; specialmente adesso che stai lottando contro un brutto male».
«So che tu lotterai con me, Johnny, ma non farti il sangue amaro.
Non posso tirare avanti ancora per molto, anch'io ho dei limiti».
«Anna...», Johnny è incredulo di doverla perdere.
Le crolla sulle ginocchia e si mette a piangere come un ragazzino, benché abbia un curriculum con almeno quattro omicidi all'attivo.
«Parliamo di mesi... o di settimane...».
«Di settimane... ormai ho una paura fottuta, Johnny...
Quando farò la biscia, contorcendomi sul letto, dovrai starmi vicino.
Ma niente buchi in pancia, voglio provarci fino all'ultimo, assumerò pasticche fino alla fine».
«Va bene, mi trasferirò qui».
![]()
È notte fonda quando dal suo tugurio discende l’erta sponda, sgusciando con insospettabile agilità fra le canne di Tiberino. Conosce il percorso come le sue tasche.
Tirata in secco e dissimulata tra le frasche del Tevere, c’è una rudimentale zattera di legname marcio, ultima via di scampo dai molti nemici in agguato.
È sempre lì, quella vista la rassicura.
È pronta a tutto pur di salvare la pelle, anche se sa di non poter sfuggire al malaccio che la sta scavando senza pietà; eppure cercherà di portarlo per le lunghe; con gli occhi dilatati, immersi nell’oscurità del fiume, si immagina negli ultimi giorni di vita, a rigirarsi come una biscia sulla branda, aspettando di trovare il coraggio per ficcarsi in corpo il suo coltellaccio da cucina.
«No... non voglio morire... voglio salvarmi...», sussurra alla notte, a denti stretti.
Quell’immagine ha il potere di eccitarla.
Ritorna nella sua baracca, si distende sulla branda e si mette a fissare, nella penombra, il maledetto coltellaccio, che le restituisce bagliori sinistri.
Tra un po’ di tempo dovrà farlo, dovrà spingerlo forte dentro di sé, per non lasciarsi scampo e non avere la tentazione di tornare indietro.
I meschini abitanti del suo villaggetto se ne sarebbero accorti troppo tardi.
Li avrebbe chiamati ormai in fin di vita, con la morte negli occhi, senza più tempo per tentare una corsa in ospedale.
Sarebbero rimasti increduli: nessuno di loro avrebbe immaginato che la facesse finita da sola. In fondo pensano stia ancora curandosi.
«Idioti… ci rimarrete male… nel vedermi crepare…», mormora trasognata nell'oscurità.
Anna ha gli occhi sbarrati, suda freddo, la fine si avvicina, la intravede e ha paura di sé stessa, di non sapersi colpire, o di non sapersi colpire accettandone le conseguenze, cioè di non essere pronta a crepare, con la conseguenza di dover poi lottare anche contro una lama da 30 centimetri in corpo.
Adesso, però, si consola, è ancora di grado di gestire il suo problema.
«Non sono fottuta… non sono fottuta…», ripete a sé stessa, senza riuscire a convincersi, inquieta, ombra fra ombre, sorca fra sorche.
![]()
RAT-TA-TA-TA
La sveglia suona presto, per lei abituata a poltrire fino a tardi.
I turchi fanno anche recupero crediti. A colpi di kalashnikov.
Un commando di tre uomini sta attaccando il villaggetto.
«Figli di puttana… adesso vi faccio vedere io…».
Anna scalza dal pavimento una tavola putrescente e abbraccia un kalashnikov. Quella storia è vera, altro che cazzate.
RAT-TA-TA-TA
Un turco è falciato, gli altri rispondono.
RAT-TA-TA-TA
RAT-TA-TA-TA
Il legno marcio offre scarso riparo alla vecchia troia.
Anna incassa piombo...!
Si ingobbisce in avanti, ma rimane in piedi...
RAT-TA-TA-TA
Un altro turco cade.
Ne rimane dritto soltanto uno.
Ma deve stare attenta a non prendere altro piombo.
RAT-TA-TA-TA
Quello rimasto, però, è schifosamente letale!
Anna si prende un’altra raffica!
RAT-TA-TA-TA
Riesce ancora a rispondere, con la forza della disperazione, ma è colta dal panico.
Si conta impazzita i buchi, ma si ferma quando le sembrano maledettamente troppi.
Adesso deve salvare il salvabile.
Anna preferisce morire di cancro, con comodo.
Con un braccio stretto sulla pancia, a tapparsi i buchi, e l’altro sul kalashnikov, esce in fretta dal retro e cerca di raggiungere la zattera.
Il cuore le pulsa forte: sa non di avere scampo, ha preso troppo piombo, ma vuole illudersi fino alla fine.
Piange lacrime mute, sa che la morte l’ha presa, che non sarà lenta come lei aveva sperato, ma è colta dalla frenesia di salvarsi a ogni costo, se si ferma è perduta, vuole fuggire e trovare una via di scampo.
Per non perdere l'equilibrio si aggrappa alle canne, Tiberino le dà una mano.
Vuole a tutti i costi salvarsi. Era sicura che sarebbe morta di cancro, o con un coltellaccio nella pancia.
«Figli di puttana… vi ho fottuto…», ma il sangue le sale in bocca, a essere fottuta è anche lei.
RAT-TA-TA-TA
E c’è pure chi vuole saldarle il conto.
Per sua fortuna, la fratta tiberina la nasconde.
Anna si apposta.
RAT-TA-TA-TA
E colpisce al giusto fremito di fronda.
Lei sa distinguere tra fremito e fremito. Quello è il suo territorio.
Un fresco cadavere rotola a valle.
È la sua Vittoria di Pirro.
La vecchia troia è ormai giunta a riva, si accascia sulla zattera e striscia verso l'acqua con tutto il legno.
![]()
Non ha le forze per scegliere la direzione, deve affidarsi alla corrente.
Non sa neppure lei dove sta andando.
È troppo tardi per finire all'ospedale e morire come una stronza.
«Cancro al colon in fase terminale e il rischio imminente che attacchi il pancreas, con le conseguenze che può facilmente immaginare».
Si consola pensando a quel medico menagramo che ha sbagliato diagnosi.
Non morirà di cancro al colon, ma di indigestione di piombo turco.
Si volta a pancia in su e aspetta la fine guardando il cielo.
![]()
![]()
«Oh, Cristo!».
L'ha vista.
Johnny sta risalendo il Tevere dalla Magliana.
La abborda e la tira dentro.
Sull'Isola Tiberina c'è un ospedale religioso.
La Banda ha ottimi rapporti con il Vaticano e le suore.
Anna è ricoverata d'urgenza, in maniera discreta.
Non viene operata, perché una nelle sue condizioni non se lo può permettere, il tumore l'ha troppo indebolita.
Viene medicata e tenuta in vita.
Poi chiede di tornare al suo villaggetto. Lì è considerata una Regina.
Johnny e qualcuno dei suoi ragazzi la proteggeranno da altri incidenti.
![]()
I giorni passano, e benché tornata nel suo villaggetto, per il giubilo degli infrattati tiberini, le condizioni di Anna si aggravano.
Ma lei non si muove da lì, l'ha promesso a tutti.
La situazione peggiora giorno dopo giorno, ormai è alla stretta finale.
Anna è bloccata sulla branda, come temeva nei suoi incubi.
Confessa a Johnny l’unica via di uscita che ha in mente.
Minaccia di mandarlo via se non l’aiuterà.
E così tutti gli smartphones del villaggetto sono pronti.
Tutti sanno quello che sta per accadere e vogliono riprenderlo.
Anna è stata portata - con tutta la branda - al centro del piccolo villaggio di baracche e tuguri.
Gente strana, della più variegata origine, barboni della prima ora, mariti separati rimasti senza niente, sfrattati, hippies tradizionali, latitanti, monnezza varia.
Senza il bisogno di scrivere complicate e artificiose costituzioni di carta, né di tenere chissà quale assemblea, era sembrato a tutti chiaro - fin dal suo avvento - che Anna sarebbe stata la Regina del villaggetto sul Tevere, presso la borgata Fidene.
In mezzo a tanto squallore, la figura di Anna appariva un prodigio.
Anche se miserabili, gli infrattati tiberini le portavano doni, offerte, regalini.
E adesso, pur afflitti, vogliono almeno conservarne la memoria e il culto, riprendendo tutte le fasi della sua tragedia.
«Uhh...», la punta del grosso coltello da cucina assaggia il sangue di Anna. Lei aspetta qualche istante, poi fa un lungo respiro... e con rabbia se lo spinge dentro... «Ohhh...!», una..., «Ohhh...!!», due spinte... «Ohhh...!!!», fino in fondo... fino al manico...!
Gli occhi strabuzzano dalle orbite, la bocca si spalanca, è entrato tutto!
Anna rimane riversa su un fianco, gli infrattati hanno intuito, ma non visto.
Quasi a volerli accontentare, si rovescia supina sulla branda.
Eccolo!
La tensione sale alle stelle.
Il coltellacio che le toglie l’ultimo scampolo di vita è ora visibile a tutti, protende dallo stomaco, affondato implacabilmente fino all’impugnatura, la grossa lama completamente sepolta nella carne di Anna.
Anna cola sangue da ambo i lati della bocca, lo sguardo è vago e rivolto al cielo, le mani ancora intorno al coltello.
Gli smartphones scattano foto a raffica e registrano video: rimarrà un momento tragicamente indimenticabile, da rivivere mille volte.
Ognuno zoomma dove meglio crede: chi sul volto sofferente e tirato, chi sulle zinne da vacca ormai sgonfie, chi - naturalmente - sul coltello fatale e le mani tremanti.
Anna indossa il suo tipico camicione di jeans.
Johnny le solleva leggermente la testa, per evitare che muoia soffocata dal suo stesso sangue.
Chi zoomma sul coltello, invece, può notare che dalla ferita non esce vero sangue, ma un siero lattiginoso, l'ascite tumorale: è talmente marcia che perfino i vermi della tomba la fuggono...
Eccola... sembra voler parlare... muove le labbra.
Gli smartphones si avvicinano il più possibile, come in una delirante conferenza stampa a due passi dall’Inferno, sulla Porta di Dite.
«Non c’erano... alternative... gnhh... gnhh... ero io... a dovermi spremere... gnhh... a sudare freddo... gnhh... a cagare lento... gnhh... gnhh... a stare sempre... sul cesso... gnhh... sapevo... che sarei morta così...», sofferente, ma ancora lucida.
Mentre Anna crepa, attorniata dal popolo degli infrattati, una perturbazione passeggera si addensa sul Tevere; non piove che qualche goccia, ma un rombo possente scuote l’aria; si alza la brezza, si oscura il cielo.
KRA-KOOM
E s’abbatte la saetta!
Un albero è spaccato in due, dalle fratte secche l’incendio si appicca alla baracca più vicina.
Il fumo e l’odore acre richiamano subito l’attenzione.
«Il villaggetto brucia! Il villaggetto muore con Anna!».
I miserabili infrattati sono un volgo superstizioso.
Ben presto anche il supplizio di Anna è minacciato dalle fiamme.
Ormai è fottuta, ma poiché non tira ancora le cuoia, bisogna portarla via da lì, o morirà bruciata viva anziché accoltellata di propria mano.
«Voglio crepare qui... gnhh... combattete le fiamme...».
Si lotta con le coperte e i secchi d’acqua attinti dal Tevere.
Lo scrosciare della pioggia dà una bella mano agli infrattati, che alla fine la spuntano.
È stata una bella vittoria.
Possono di nuovo concentrarsi su Anna.
Il coltello nella pancia ruba la scena.
Nessuno glielo toglie, perché è l’ultimo filo che la lega alla vita.
«Bravi... non bisogna fuggire... gnhh... ma combattere... gnhh...».
Ecco, a proposito, Anna...
Tu vuoi ancora combattere?
La cosa sta andando per le lunghe, pensa qualcuno.
Forse ci ripensa e prova a salvarsi, dice qualcun altro.
Johnny la mette alla prova.
«Se ti estraggo il coltello, soffrirai meno...».
«No... non toccarlo... gnhh... o crepo all’istante...» ansante, con la disperazione negli occhi, quasi piangendo; ancora con qualcosa in testa. «Voglio... rivedermi... gnhh...».
I presenti le fanno rivedere il momento in cui s’è scannata.
Strabuzza gli occhi come in quel momento, spaventata a morte.
«Perché... l'ha fatto...», quasi parlasse di un'altra.
Ma passa solo un attimo e le mani si staccano per la prima volta dal coltellaccio fatale... e cadono molli lungo i fianchi!
La disperazione dilaga tra gli infrattati del villaggetto.
Anna è in fin di vita; la bocca semiaperta, sbigottita, e gli occhi vitrei; con rapidi sguardi sul coltello, quasi a sperare che sia solo un incubo.
«Anna!», le urla contro Johnny.
E allora tira fuori una bombola d’ossigeno con relativa maschera.
L’aveva preparata per ogni evenienza, anche in considerazione delle complicanze tumorali.
Gliel’attacca subito.
Il pesante petto si scuote, riparte.
Non servirà a molto, ma le concede qualche minuto in più.
Si è ripresa, adesso gliela toglie.
«Fatele vedere cosa si è persa...», rivolto agli astanti.
E quelli le mostrano il momento in cui ha perso il controllo.
«State vicini... gnhh... manca poco... ma non toccate... il coltello... gnhh...».
E tuttavia invoca la maschera, si dispera e impreca, con un coltellaccio da 30 centimetri nello stomaco, un tumore da tempo fuori controllo e diverse cicatrici calibro 45 sparse per la pancia.
Questa è Anna.
Questa è la Regina del Villaggetto.
E anche il cielo si commuove per la sua fine.
Iride non è ancora giunta a strapparle il capello fatale.
La tragedia è incompiuta.
![]()
 Anna gira in
carrozzella per il villaggetto, ogni tanto lascia la branda.
Anna gira in
carrozzella per il villaggetto, ogni tanto lascia la branda.
Un sacchetto di plasma e una flebo sempre attaccati al braccio.
Sono due mesi che si è tolta il coltello.
Il tumore è progredito ancora, ma il pancreas è rimasto pulito.
Grazie al suo fisico possente, riesce tuttora a gestirsi, passando molto tempo sul water. Scarica direttamente nel Tevere, senza cambiarlo molto.
Ma almeno è cacca reale, anzi cagarella.
Quanto ancora possa andare avanti, nessuno lo sa.
Ma se il pancreas rimane pulito, farà ancora la biscia, senza ritegno.
Gli abitanti del villaggetto portano doni e offerte, e passano il giorno a guardare e a riguardare i loro epici video.
La tragedia rimane incompiuta, ma la gran paura, anzi il terrore di tutti, è che Iride si decida a scrivere il finale, nell'unico modo che sa fare, ovvero tagliando i capelli.
In mancanza di meglio, Anna preferirebbe un finale aperto.
E finché Iride non ci ripensa...
![]()
Nei momenti peggiori Anna, oltre al respiratore in faccia, si fa mettere un parrucchino biondo in testa, ovviamente per ingannare Iride, nel caso le facesse visita.

Sarà un caso, ma la vecchia zoccola non è ancora crepata.
I Turchi, però, sono stanchi di aspettare, hanno scelto il killer che metterà fine alle sofferenze di Anna Frezzante.

Nel giro si chiama proprio Iride, curiosa coincidenza.
È una bionda insospettabile, il cui vero cognome è Tagli, altra curiosa coincidenza. Si narra che i suoi fitti capelli biondi siano la collezione delle sue tante vittime.
Per Anna stavolta è davvero la fine?
![]()
![]()
di Renzo Barbieri e Salvatore Conte (2024)
È abituata a non esporsi troppo - eccezion fatta per le zinne - e a rimanere in disparte fino al momento giusto, insomma a strisciare tra l'erba alta della città; per questo nel giro la chiamano "la Biscia".

È Monica Welch, il capo del traffico di droga
nell'Organizzazione creata da Troyka, la Regina del Crimine, basata su tre
grandi attività delinquenziali: furti e rapine, prostituzione, e droga...
Adesso, però, ha una rivale pericolosa; si tratta di Janet Sorcon, la donna
temprata dalla Coda del Drago.


![]()

Troyka ha preso le sue precauzioni: nella sua borsetta c'è sempre almeno una molotov pronta per essere accesa. Wallestein è infatti sensibile solo al fuoco e lei non vuole più correre rischi.
È soddisfatta di Monica Welch e intende capire cosa farà il Mostro nella lotta che si profila con il Drago. Starà a guardare, o interverrà? E in favore di chi?

![]()
Stavolta Wallestein ha deciso di farsi i cazzi propri e di assistere allo scontro tra Monica Welch - la Campionessa di Troyka, la Regine del Crimine - e Janet Sorcon - la Campionessa di Fu Manchu, il Capo della mafia cinese.
La Welch ha un punto debole che l'astuto orientale intende sfruttare a vantaggio della sua favorita.
Benché lucida e spietata, infatti, la donna ha una sorta di complesso materno nei confronti della figlia Klasta, ragazza degenere e inconcludente.
Così Fu Manchu la fa rapire, affinché funga da esca.
«Figlio di puttana! Sono sola e disarmata! Molla mia figlia, stronzo!
Klasta, fatti sentire!».
«Mamma! Sono qui, mamma!».
Siamo nei bassifondi della Chinatown di Londra.

«Davvero non capisco perché tieni così tanto a quella puttanella...», la Sorcon esce allo scoperto.
Anche lei è sola, ma non disarmata.
«È un peccato che una di noi due debba scomparire...
Sei ancora in tiro, nonostante l'età...».
«Dacci un taglio, Sorcon: libera mia figlia e affrontami da donna».
«Mandatela fuori!».
Gli scagnozzi gialli dell'importante donna eseguono l'ordine.
«Voglio che tua figlia ti veda bene, mentre crepi... Monica...».

 Sulla
Welch comincia a grandinare piombo.
Sulla
Welch comincia a grandinare piombo.
Monica lascia fare, rimanendo in piedi; quando il revolver è scarico, si porta un braccio dietro la testa e sferra un colpo micidiale all'avversaria: un pugnale saetta nell'aria... e raggiunge la Sorcon alla gola!
«Vai via... mamma torna a casa... da sola...», sussurra la Welch alla figlia. «Vai Klasta... vai via...».
La Welch crolla a terra quando la figlia è ormai lontana.
Un'ombra nella notte torreggia su di lei.
«Almeno sei una buona madre...
Però non ne valeva la pena».
Un essere mostruoso si allontana dal vicolo con un morbido fardello sulle spalle, mentre un nugolo di cinesi si affretta intorno a una bella fica con un coltello nella gola.
Lo scontro è stato duro.
![]()
![]()
di Salvatore Conte e Bruno Marraffa (2024)
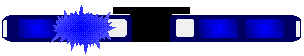


 «Fai
piano... Marco... è fragile...
«Fai
piano... Marco... è fragile...
L'ambulanza sta arrivando».
«Grazie a Dio... ohh... sono viva... ih...hh...», ma lo squarcio in pancia è enorme, dalle labbra socchiuse trabocca sangue.
«Cosa te ne frega di questa mignotta?».
«È una bella donna e all'epoca era molto giovane, non sapeva quello che faceva».

Staccata dal muro, Caterina è finita seduta per terra, la schiena contro la parete.
Stefania le preme contro un asciugamano e le tiene la mano, la cacciatrice è in fin di vita.
«Che cosa racconteremo alla Polizia?», le chiede Marco.
«L'indio dell'Amazzonia non sei tu, giusto?
Il guanto di paraffina non funziona con una lancia, giusto?», gli risponde Stefania. «Le tue impronte ci sono perché le hai tolto la lancia dalle budella; la maschera la fai a pezzi piccoli e la scarichi nel cesso; fila tutto; anzi l'indio è il tuo alibi».
«E se lei parla?».
«Non lo farai, vero, Caterina? Era suo diritto punirti».
«Va bene... va bene... oh-ohh... non parlo... non parlo... ih-hh...
Ma fate presto... oohhh... ho... una cazzo... di fretta... ahh...».
«Sì, lo sappiamo...».
«Noi... noi... rimarremo amici... uuhhh... torneremo a caccia... insieme...».
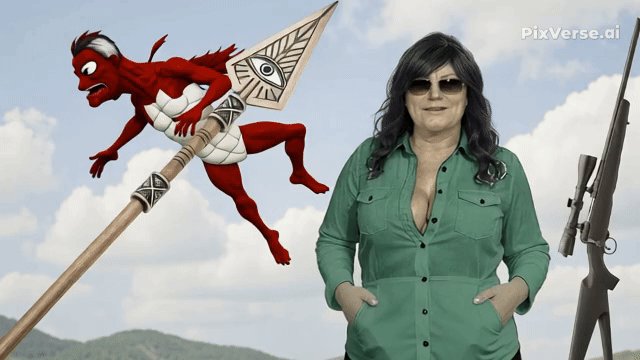
«Se è questo ciò che vuoi, per me va bene...», l'ammissione sincera di Marco, nel mentre le fissa le zinne sudate e disperate.

«Sì... guarda bene... Marco... ma... ohh...! Marco... io... io... ho paura... iihhh... capito... paura...», Caterina vede la morte.
«Ho capito, hai paura; ma le senti le sirene?
Tra poco vai in ospedale».
«No... io... ho poco tempo... oohhh!».
«Ma che dici? Il tempo c'è!», Stefania insiste a premerle un asciugamano sulla grossa ferita, ma è più spaventata di Caterina stessa.
Quando entrano i paramedici, la donna fissi gli occhi al soffitto.
Stefania scoppia a piangere, ma la cacciatrice viene caricata sull'ambulanza ancora in vita.
«È una pellaccia, Stefy; non preoccuparti...».


![]()
![]()
![]()








