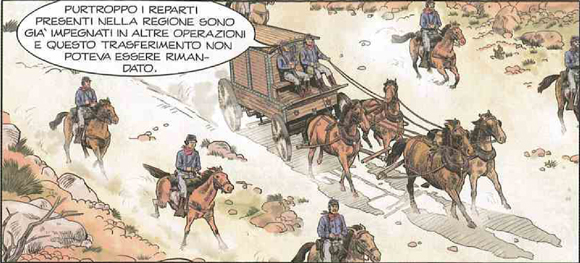![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)

«Da qui domineremo il mondo».
«Ora che ci siamo ritrovati, festeggeremo la nostra eternità».
![]()
«Ehi, ma come fai a vivere da sola in un posto come questo?».

 «La
tranquillità è un lusso, oggi».
«La
tranquillità è un lusso, oggi».
«Ma non hai paura?», i timori della donna non si addicono all'importanza del fisico e alla grinta virile.
«Di cosa?».
La chiave gira nella serratura e la porta si apre buia facendo entrare le due donne.
 «Dai... togliti il
cappotto...
«Dai... togliti il
cappotto...
Ravvivo il fuoco e vado a prepararti un caffè bollente, sei tutta intirizzita dal freddo.
Non dalla paura, spero...».
Si leva di dosso il cappotto, lasciando che la penombra, accesa da un debole lampadario, sveli il fisico imponente.
Anche la padrona di casa fa altrettanto, buttando l'impermeabile sulla sedia più vicina, e la luce ammezzata la lusinga come ha appena fatto con l'altra, rivelando un corpo appesantito dai giusti chili e perfettamente arrotondato: la pancia, le zinne, le braccia e le cosce, e di certo il culo; tutto arrotondato da gran puttana.

![]()
Una chat.
Una conversazione.
Tante conversazioni.
Poi un incontro.
Tanti incontri.
Tra lesbiche.
E stasera è il settimo.
Il primo nel casolare di lei.
Stasera facciamo l'amore nel mio rifugio nelle Valli...
L'ha invitata così, e lei non aspettava altro che quell'invito.
D'altra parte è sempre una bella donna; matura e piena di vita; prestante, grassottella, ma con quella ciccia addosso che le dà ancora di più un'aria da potente mignottona.

Forse era meglio 20 anni e 20 chili prima, ma c'è chi la preferisce adesso, più matura e prestigiosa.
Una troia ingrassata. E una lesbica. Ma non del tutto.




 C'è un uomo a cui è morbosamente legata. Quello che le
consente di essere sé stessa.
C'è un uomo a cui è morbosamente legata. Quello che le
consente di essere sé stessa.
L'ha fatto uscire di galera, scopandosi il boss per convincerlo a smuovere il giudice di sorveglianza: libertà vigilata per buona condotta; vigilata da chi, poi? Probabilmente la Giustizia intende questo: nun te cerco, ma si me capiti...
Lui è di origini romane. Dal carcere la voleva quasi ammazzare, perché in sua assenza stava facendo la mignotta.
Quando però si è visto sbattere fuori, senza nemmeno una parola dal suo avvocato, ma con lei ad aspettarlo in fondo ai tre scalini... allora ha capito tante cose.
A Nada piacciono le vecchie troie fluide come lei... sfatte e consumate come lei...
D'altra parte, Nada stessa è rimasta alla sua età la strappona che è sempre stata.
«Lo sai che sette è un numero magico?», la presenza di Layla è fatta solo di voce, il resto è nascosto nella stanza accanto. «Esoterico...».
«Te l’ho detto… non m’importa nulla di magia, esoterismo e cazzate simili… e poi cosa c'entra il numero sette?».
«Stasera è la settima volta che ci incontriamo», la voce si avvicina.
Esce dalla stanza, due tazze di caffè strette nelle mani e solo un paio di mutande addosso, col resto del corpo nudo che balzella grasso a ogni passo.
«Vieni qua...», Nada batte il palmo della mano sul cuscino del divanetto, davanti al camino. «Ho voglia di te...», poi la sposta in mezzo alle pendenze dei seni; non sono grossi come i suoi, ma di grosso prestigio.
«Aspetta... prima beviamo questo.
Se siamo calde dentro, lo siamo anche fuori...».
«Come vuoi», e butta giù la tazza di caffè bruciandosi la gola, la voglia di scopare è tanta.
«Vedrai che ti sentirai meglio adesso...», e le accarezza la fronte.
Nada ha fretta di scopare, ma certe polveri sono anche più svelte, specialmente se sciolte nei liquidi bollenti.
«Non sto bene...».
«Vieni qua, piccola».
«Mi gira la testa...», si abbandona fra i seni di Layla. «Cosa mi sta succedendo...? Aiutami... sto male...», una mano al collo come a toglierne un'altra, invisibile, che sembra soffocarla.
«Rilassati, Nada... andrà tutto bene...».
«Dio santo... ma cosa...»
È il buio a rispondere a tutte le domande.
Il buio e la morte, a volte così simili nei loro modi.
E così indissolubili, quando si chiudono gli occhi per sempre.
![]()
«Sal... è andata...
Puoi chiamare Tony».

La carica sulle spalle, non senza sforzo, e la trasporta in uno stanzone del casolare, completamente isolato dal mondo.
L'uomo scarica il suo sacco umano sopra un rettangolo di marmo e lega gli arti della donna a solidi braccialetti d'acciaio.
C'è solo da aspettare il ritorno della protagonista.
Quattro telecamere ai quattro angoli e sette coltellate.
Otto, se Tony non si tiene.
L'ultima viene lasciata dentro, fino a non quando non tira le cuoia.


E se vi è da aspettare, per i titoli di coda, si aspetta.
Il record è di 49 minuti.
Per chi dovesse superare l'ora, si è fatta l'ipotesi di concedere una sorta di grazia per eroismo, ma finora l'eventualità non si è mai realizzata. Le coltellate di Tony fanno parecchio male.
![]()
Layla si eccita in maniera forsennata, mentre Sal le strizza le zinne.
Ma il merito non è del suo uomo.
È dell'altro.
Layla è l'erede spirituale di Buono Legnani, il pittore maledetto della Bassa Padana, ossessionato dall'agonia e perciò detto "il Pittore delle Agonie".
 Protetta
dai più potenti circoli esoterici, Layla agisce pressoché indisturbata, sempre
accompagnata dall'uomo del suo destino.
Protetta
dai più potenti circoli esoterici, Layla agisce pressoché indisturbata, sempre
accompagnata dall'uomo del suo destino.
Layla è una di quelle che se anche l'ammazzano, nun se sa se pija e more...
I suoi video hanno un valore inestimabile e possono essere visti solo dai 300 Potenti della Terra.
Il lavoro è finito dal dottor Balmer, giusto per dare un tocco di esoterico alla storia.
Mentre Layla monta il video, lui smonta il corpo e lo fa stagionare 70 giorni; almeno.
Tutto è pronto per la pubblicazione.
![]()
TRE MESI DOPO,
QUESTURA DI FERRARA
Un massiccio mucchio di fogli viene sbattuto sulla scrivania senza alcun riguardo.
«L'hanno portato adesso.
Solito plico, contenente la solita documentazione...».
 «Un'altra mummia...?
Sarebbe la sesta.
«Un'altra mummia...?
Sarebbe la sesta.
Dunque vediamo...
Sette fotografie della disgraziata... scheda dettagliata della vittima... con nome, cognome, data di nascita, indirizzo, occupazione, abitudini... il solito».
«Datti da fare... Nero.
Nel solito modo...».
«Agli ordini, Signor Questore».
![]()
 «Sul
posto ci sono i Carabinieri. E i Vigili».
«Sul
posto ci sono i Carabinieri. E i Vigili».
«Tanto l'inchiesta è nostra.
Però la Frezzante non me la faccio scappare. Altro che passera di mare...
Hanno già avvertito il magistrato di turno e il medico legale?
«Sì, e se non ci sbrighiamo non troviamo neanche posto per parcheggiare».
Un'altra sirena, un altro lampeggiante.
«Finalmente sei arrivato, Commissario», un Maresciallo di mezza età si stacca dal circo dei lampeggianti. «Visti i risultati ottenuti in questi anni, pensavo ti avessero sollevato da questo caso».
 «Questa non è roba da
cugini di campagna... spiacente, Maresciallo...
«Questa non è roba da
cugini di campagna... spiacente, Maresciallo...
Né da belle signore... spiacente, Maggiore...».
«Meglio la campagna delle scartoffie tra cui sei sepolto, Commissario...».
«Qui la cucina è ottima e il pescato di qualità insuperabile...», la Frezzante ci mette tutta la sua carne sopra.
 «Sarà anche vero, ma le
scartoffie mi dicono che la vittima si chiamava Nada Giansanti, cinquantadue
anni per un metro e settanta; gestiva una piccola rivendita di auto d'epoca
d'importazione, americane per lo più; era conosciuta nella tua campagna per via
delle grosse tette.
«Sarà anche vero, ma le
scartoffie mi dicono che la vittima si chiamava Nada Giansanti, cinquantadue
anni per un metro e settanta; gestiva una piccola rivendita di auto d'epoca
d'importazione, americane per lo più; era conosciuta nella tua campagna per via
delle grosse tette.
Ritrovata nel solito modo?».

«Nel solito modo... per la solita inchiesta...
Solita bara galleggiante.
La Giansanti era qualcuno da queste parti, i suoi ammiratori non si davano pace; la storia della sua improvvisa partenza, beh... aveva lasciato molti dubbi...».
«Anche a te, Maresciallo?».
«Non era roba per me, non lo so, qui in tanti vengono e partono.
In ogni caso l'autopsia ci dirà se ha preso le solite sette coltellate.
A quante siamo, Commissario?», il Maresciallo lo sfida.
«A sei.
Che intendi per solita inchiesta?».
«Niente di particolare... dicevo per dire».
«Ascoltami bene, Maresciallo.
Questa inchiesta è molto delicata e non vorrei dover parlare di te al tuo Comandante; ti trovi bene, qui nelle Valli, giusto?».
«Giusto.
Non c'è bisogno che ti scaldi, Commissario; dicevo per dire».
«Già... dicevi per dire...».
«Allora, procediamo all'apertura?».
«Procediamo...».
![]()
 «Ma
che cavolo di scherzo è?».
«Ma
che cavolo di scherzo è?».
«Però è identica alla Giansanti, questo sì».
«Dottore, grazie, lei può andare.
Più che il medico legale, qui servirebbe il Direttore di Madame Tussauds.
Chissà che non la prendano loro...».
«Perché no, la Giansanti è qualcuno da queste parti...».
«E adesso ha pure la sua mummia di cera...».
![]()
ALTRO TEMPO DOPO,
A DIVERSI CHILOMETRI DA COMACCHIO
 Fuori piove, con questo tempo non si
va a caccia.
Fuori piove, con questo tempo non si
va a caccia.
«Vuoi un passaggio, bellezza?», ma per certi tipi la stagione è sempre aperta.
«Fottiti», lei, tuttavia, è la cacciatrice, non la preda.
E lui non è la preda che cerca.
«Fottiti tu, puttana», e se ne va senza sapere che stasera con lui il destino ha chiuso un occhio.
Un locale, una scritta calda che promette incontri di pari temperatura.
«Non sei del posto, vero...?», sa bene dove mettere le trappole. «Che ne dici se ce ne andiamo a casa mia a bere qualcosa?».
 «Veramente io...», la
preda è sempre malfidata, deve prima annusare il terreno.
«Veramente io...», la
preda è sempre malfidata, deve prima annusare il terreno.
«Ho una bella casetta sul fiume.
Intanto facciamoci un giro per scaldarci, poi se ti va andiamo».
La guarda rassicurante, ha già capito che la donna ha una serataccia, altrimenti non sarebbe seduta da sola in un locale come quello.
«Ma sì... perché no?». Si fida. L'errore più comune di ogni preda. «In fondo sono venuta qui per mettere un bel paio di corna a quel bastardo di Gianni».
«Due whisky, ragazzo», quando la preda mette la testa fuori dalla tana, bisogna sparare subito. E lei preme il grilletto all'istante.
«E se gliele mettessi con una donna, credo s'incazzerebbe anche di più».
«Lo credo pure io.
Come hai detto che ti chiami...?».
«Mi chiamo Laura... ma non te l'avevo detto...».
«È un nome importante...».
«Davvero?».
«Sì, davvero...».
![]()
Stavolta un solo incontro con la settima vittima designata.
Laura è una metallara, un donnone pieno di vita, una montagna di carne fuori controllo, che non ha paura di mostrare i rotoli di ciccia intorno alla pancia.

«Sei bellissima...», è al solito gentile, dalla voce ai movimenti. La fissa a lungo.
 «Grazie...», Laura
arrossisce, è timida senza neanche saperlo. «Sono un po’ ingrassata,
ultimamente», e si stringe fra le dita il grasso della pancia, a confermare
quello che sta dicendo.
«Grazie...», Laura
arrossisce, è timida senza neanche saperlo. «Sono un po’ ingrassata,
ultimamente», e si stringe fra le dita il grasso della pancia, a confermare
quello che sta dicendo.
«Stai benissimo, invece...
Posso toccarti?».
«Sì».
«Hai un seno stupendo, sai?».
«Ohh...», a Laura piace la mano esperta di Layla. «Mi fai sentire donna...».
«Tu sei la donna perfetta, Laura.
Potente e indistruttibile».
«Ohh...».
«Ti preparo un drink, ti scalderà...».
«Più di così?».
![]()
 «Accendo
il camino, la luce della fiamma è magica, sai?».
«Accendo
il camino, la luce della fiamma è magica, sai?».
«Però... io... ho caldo...».
«Hai caldo?
È la mia mano, Laura...».
Qualche altro secondo e poi le solite parole, già pronunciate tante volte: «Sal... è andata...».
SZOCK
«E chi sarebbe... questo Sal...?!».
Uno scatto repentino, una stoccata micidiale.
Laura afferra l'appuntito attizzatoio del camino e infuoca le budella di Layla!
«So jo, stronza!».
Sal le scarica addosso un paio di calibro 38, senza neppure innestare il silenziatore.
«Aspetta... non la finire... è una bella puttana... sa incassare... alle migliori diamo una chance...».
L'uomo chiama un numero di emergenza.
«Sal... stasera... recito io...
Tu... mi scoperai... mentre crepo... voglio dentro... anche il tuo attizzatoio... ma dopo un quarto d'ora... basta... mandiamo i titoli di coda...».
Poi sarà caccia alla settima mummia.
Oppure alla seconda imbalsamatrice.

![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
Era un sole che spaccava le pietre e la mia testa dura era a rischio.
Stavo aspettando che uscisse dal ranch, per seguirla a distanza.
Nell’attesa sorseggiai un altro goccio.
Infine, eccola…
Era scortata da un paio dei suoi cow-boy.

Lei era la Vedova Frexhen, proprietaria di un latifondo tra Tucson e Prescott, che includeva un paese in pieno sviluppo, rimasto ancora senza nome.
Per questo era anche la Sceriffa di quel posto senza nome.
Mister Frexhen era morto per un attacco di cuore poco dopo il suo matrimonio con la prestante, consumata Janet.
Lo Sceriffo aveva liquidato il fatto senza farsi troppe domande e il fisico possente di Janet aveva fatto il resto, tacitando le malelingue.
L’ambiziosa Vedova reggeva le redini dell’impero economico creato dal defunto marito; ma senza accontentarsi; altri traffici venivano celati dietro una facciata di apparente rispettabilità.
La Frexhen si era data una bella ripulita.
Il passato, però, non si può sopprimere come un marito indesiderato; ti rimane appiccicato addosso.
I figli, poi, quelli ti rimangono sul groppone: Clarita, lasciva e prepotente, dilapidava allegramente il denaro della madre ed era solita accompagnarsi ad autentici pendagli da forca; Johnny, d'altra parte, benché ormai trentenne, non era che un perdigiorno abulico e irritante.
Janet ci sapeva fare, loro no.
E ciò rischiava di metterla in seria difficoltà, calamitando su di lei e il suo impero attenzioni indesiderate.
Era per questo, in effetti, che mi trovavo sotto quel sole cocente che spaccava le pietre e le teste dure.
La Frexhen si era rivolta alla Pinkerton per recuperare credibilità e tenere a bada le grane.
Sapeva che i soldi andavano divisi con la buona società; bastava sacrificare, di tanto in tanto, qualche pesciolino.
Janet ci sapeva fare, e io, entrando nelle sue grazie, avrei potuto arrotondare la paga.
Una prima occasione mi si era presentata allorché avevo colto sul fatto un paio di cow-boy intenti ad alleggerire la cambusa del ranch.
«Cos’è… mi vuoi dimostrare che posso contare su di te…?».
La Frexhen si era sbottonata più del solito e la cosa non mi era affatto dispiaciuta. La prestante ranchera sapeva usare molto bene la sua bella presenza per tessere la tela e stringere alleanze; nonostante i 50 anni sul groppone, rimaneva un buon investimento, e lo faceva intendere chiaramente, promettendo - in qualche modo - di sapersi gestire ancora a lungo. Nell'immediato, poi, con i suoi camicioni sbottonati fino allo stomaco, non ce n'era per nessuno.
Lo status di vedova la schermava dai pettegolezzi e le lasciava mano libera nei suoi incontri d’affari. Quel che importava, comunque, era che fossi quasi entrato nel suo cerchio magico, ovvero nel novero di coloro che lei avrebbe usato per conservare il suo impero, ossia ciò che le garantiva una vita da padrona in un mondo spesso umiliante per le donne.
Se mi avesse assunto alle sue dipendenze, come capo dei suoi vigilantes, avrei mollato la Pinkerton senza starci troppo a pensare.
![]()
Intanto, però, ero lì, a cuocermi sotto il sole.
Ma almeno adesso ero a cavallo.
Una copertura di routine, fino a quel momento.
Entrati in paese, la Frexhen mi attirò da parte e mi disse ciò che dovevo fare.
Stava per commettere un grave errore, accecata da un malinteso senso della famiglia, e non c’era modo di farle cambiare idea.
La Vedova, infatti, benché fosse un donnone privo di scrupoli, era anche una madre fin troppo premurosa.
Pochi giorni prima era giunto in paese un Ranger federale noto per il suo pessimo carattere: Tek Wilker.
Era arrivato per indagare su Al Salt, un pendaglio da forca che aveva stretto una relazione con Clarita Courtney, convincendola perfino a sposarlo.
Janet, però, anziché vedere di buon occhio il lavoro di pulizia del Ranger, aveva deciso di toglierlo di mezzo, se non se ne fosse andato alla svelta dalle sue terre, lasciando in pace la figlia e il fidanzato.
Il piano prevedeva che lei stessa l’avrebbe affrontato all’interno del saloon, dove i suoi uomini l’avrebbero impiombato a tradimento, nel caso in cui non avesse desistito dalle indagini.
Io dovevo rimanere di copertura e proteggerla, ove qualcosa fosse andato storto.
Calata la sera, confidando nel suo prestigio, Janet Frexhen si alzò dal suo posto e mosse verso il tavolo di Wilker: gli stivali della Vedova tacchettavano gravi sulle assi del saloon, mentre si avvicinava al Ranger.
Le minacce del donnone iniziarono presto a volare nell’aria densa di fumo.
«Tu non hai giurisdizione in questa città, Ranger dei miei stivali.
Sono io la Sceriffa.
Se non ti sbrighi a sloggiare, ti farò cacciare via a calci».
«Non ci siamo già visti noi due?».
«Non credo proprio, Ranger ficcanaso».
«E come si chiama questa città?».
«Janetville...».
«Sono un Ranger federale, questa è la mia patacca, e ho giurisdizione su tutta l'Unione, inclusa... Janetville...».
«Vedo che non vuoi proprio capire... Tek Wilker...».
Gli avventori del locale, annusata puzza di bruciato, cominciarono a sfollare.
Wilker, dal canto suo, non si fece irretire dalla camicia scollata della consumata Vedova, e così gli uomini della Frexhen stavano per entrare in azione…
Sembrava un obiettivo facile, ma quando venne il momento, il Ranger anticipò tutti.
BANG
Wilker centrò in fronte un uomo con il fucile che lo puntava dal piano di sopra.
CRASH
Il corpo si abbatté sul tavolo di sotto, fracassandolo.
BANG
BANG
Schivato il colpo di un altro bovaro, il Ranger lo mandò ad accompagnare il socio all'inferno.
A quel punto, la Frexhen, distante pochi passi, avrebbe potuto estrarre e sorprendere Wilker; ma sembrò avere paura: la colt rimase nella fondina.
Janet era molto attenta nel preservarsi. Raramente commetteva imprudenze e la vista dei suoi uomini, stecchiti a terra, l’aveva messa sull'avviso giusto.
Forse Wilker non avrebbe sparato a una donna con altrettanta ferocia, ma non avrebbe potuto giurarci. E di sicuro non voleva giocarsi la pellaccia.
Il suo istinto l’aveva salvata, almeno per il momento.
![]()
Il Ranger la apostrofò duramente, nel mentre rinfoderava la colt.
Ma il suo "vecchia bagascia" nascondeva un desiderio represso: Janet piaceva anche a Wilker.
Adesso si stava giustificando, i suoi uomini si erano fatti prendere la mano, ma lei era pulita, bla-bla...
«Erano solo degli idioti...».
«Ma lavoravano per voi...».
«Tutti qui lavorano per me, in un modo o nell'altro...».
Da parte mia non potevo spingermi troppo lontano, facendo fuori un Ranger tanto famoso; senza contare il fatto che avevo tutto l’interesse a che lui mi levasse dai piedi il futuro genero di Janet, Al Salt, che avrebbe sicuramente messo in discussione il mio ruolo di braccio destro della piacente ereditiera.
Fu così che rimasi di copertura, attendendo gli eventi.
Il destino, però, aveva fretta quella sera, perché mentre la ricca Vedova respingeva le accuse del Ranger, vomitando sui tirapiedi caduti la responsabilità di quell’azione scellerata, fece il suo ingresso nel saloon proprio Al Salt, accompagnato da due scagnozzi.
Non c’era più nessun altro nel locale.
Prese subito a minacciare Wilker, ma poi - improvvisamente - dirottò l’attenzione verso Janet, la donna che stava per diventare sua suocera.
La fissò per un attimo negli occhi.
BANG
La fiamma di una colt divampò ancora nel saloon del paese.
Un attimo dopo gli occhi di Janet Frexhen schizzarono fuori dalle orbite: il donnone si era beccato una pallottola di piombo caldo in pieno stomaco!
«È un peccato che Ranger Wilker abbia fatto fuori la vecchia della mia Clarita…», insinuò sardonico Salt.
Io c’ero rimasto letteralmente di sale. Per qualche secondo fui bloccato dal panico. Le mie speranze andavano in fumo.
E Tek Wilker non aveva mosso un ciglio.
Forse vederla morire sotto i suoi occhi era meglio che fotterla.
Janet si portò la mano sullo stomaco, e dopo aver barcollato per un paio di passi, franò faccia in avanti su un tavolo, finendo per strisciarci sopra, spinta dalla disperazione. Cercava di rimanere aggrappata a qualcosa.
«Ora tocca a te, Wilker. Sarò io stesso a vendicare mia suocera...», con la pistola ancora fumante, Salt si sentiva sicuro di sé, forte dei complici che lo spalleggiavano.
Tuttavia, quando vidi gli stivali della Frexhen, che - a penzoloni dal tavolo - scalciavano disperati per gli spasmi dell'agonia, mi caricai di rabbia, ritrovando il coraggio perduto: dalla posizione favorevole che avevo prescelto, scatenai su Salt e soci una tale pioggia di fuoco da sommergerli di piombo, lasciando lo stesso Wilker con un palmo di naso.
Avevo fatto un buon lavoro.
Ma ormai la frittata era fatta.
![]()
Janet Frexhen, che io speravo m'avrebbe assunto - prima o poi - in pianta stabile, si era beccata - sotto i miei occhi - una pallottola nello stomaco e languiva morente su un tavolo del suo stesso saloon.
Io e Wilker la trasportammo di sopra.
«Un dottore per la Vedova Boyle, presto!», urlai dalla finestra.
«Tutto… per quella… dannata stupida…», l’aveva capito, finalmente; ora che aveva il sangue alla bocca.
Si teneva a pancia sotto, con le mani sullo stomaco, cercando di gestirsi, ma era troppo esperta per non capire che c'avrebbe lasciato la pelle.
«Doug... vieni qui... ho paura...», la Frexhen, scaltra com'era, sapeva che il danno era irreparabile; l'inferno l’attendeva, benché un donnone come lei fosse in grado di allungare la strada; prendere tempo, insomma; spremersi fino all'ultimo. «Io… io… non mi lascio andare…», sembrava avermi letto nel pensiero.
Fu allora che Wilker mi chiamò da parte: «Ora non ho più dubbi. Sono passati parecchi anni, ma una come quella non si dimentica tanto facilmente…
All’epoca si chiamava Jane Brent e dirigeva una banda di trafficanti d’oppio, con base a Galveston.
Al termine di lunghe indagini riuscii finalmente a metterle il sale sulla coda…
Tentò di fuggire, ma venne investita da una diligenza e ci rimase secca: il dottore che intervenne sul posto si accertò che fosse deceduta.
Non capisco come possa essere sopravvissuta, ma - in ogni caso - la donna sul letto è la rediviva Jane Brent.
Non so, però, se stavolta basterà un medico compiacente per tirarla fuori dai guai, Agente Wilkinson…».
Giusto in quel momento arrivò il dottore.
Il responso del segaossa non fu confortante: Janet Frexhen aveva un paio d’ore, non di più, sempre che avesse stretto i denti.
E infatti il consumato donnone sapeva di essere morto, ma non si lasciava andare.
«Doug… voglio giocarmi… l’ultima carta…».
Mi disse di prelevare una vecchia sciamana che abitava in una baracca fatiscente non lontano dal suo ranch; una baracca che un giorno lei stessa mi fece notare, durante un giro di ricognizione, riferendola a una vecchia squilibrata.
D’altra parte, aspettare al suo capezzale non sarebbe servito a niente; mi apprestai quindi a partire.
Chiesi a Wilker di ricambiarmi il triplice favore che gli avevo reso e di sostituirmi, perché qualcuno - a cominciare dalla figlia - avrebbe potuto spingerla all'inferno.
Dunque mi affrettai al massimo, la luna piena mi agevolò.
Alla sciamana spiegai che a stento l’avremmo trovata in vita.
Infatti, quando rientrai nel saloon, ero ormai convinto di rivederla cadavere.
Mentre accompagnavo di sopra l’indiana, in mezzo a una folla di curiosi, cercavo di trarre indicazioni dagli umori della gente: dal clima di sordida attesa che percepivo intorno, ne dedussi che non era ancora finita.
«Non ha ancora mollato, è una vera dura, non c’è che dire», rimarcò Wilker, con uno strano accento di implicita ammirazione.
Una maschera di sudore le imperlava il volto sbiadito, gli occhi erano puntati al soffitto, la bocca quasi spalancata, un languido rivolo di sangue colava dal labbro, le mani piantate sullo stomaco, a trattenere disperatamente la vita.
Janet non si era lasciata andare, aveva spremuto il fisico.
Sapeva soffrire e sapeva gestirsi, cercando ogni volta di assestarsi.
«Doug… io… non mi lascio andare… però… è come se... questo buco… diventasse… sempre più grande…».
Voleva essere giustificata. Non poteva fare di più.
«Doug... ti avviso... quando... è finita... non ti lascio... all'improvviso... so... che ci tieni a me... potevamo fare... grandi cose...».
«Janet, ti ho portato la sciamana».
La vecchia aveva già cominciato a lavorare.
Quando ebbe finito, la fissai negli occhi per ricevere un responso.
Ma a differenza di Janet Frexhen, l'indiana si teneva abbottonata, e senza aprire bocca, lasciò la camera.
Prima di scendere di sotto a tirarmi su con un goccio, la guardai per l’ennesima volta, scuotendo la testa: la vaccara pascolava ormai all’inferno…
![]()
Accidenti a me! Avrei dovuto imbottire di piombo quel Salt non appena la sua faccia da carogna era comparsa nel saloon…
Poi, però, che cosa avrebbe pensato l’incolume Vedova Frexhen? Avrebbe mai compreso la minaccia che la sovrastava?
In quella storia era Janet ad aver commesso un errore fatale, sottovalutando Salt che puntava a toglierla di mezzo per prendersi tutto.
Raggiunsi il bancone del saloon, dove incontrai Wilker.
Volevo far presto, perché Janet era ormai cotta a puntino.
Con lei rimanevano un paio di cow-boy, tra i più fidati.
«Come sta la Vedova, Agente Wilkinson?».
«Sta per mollare tutto, Ranger Wilker».
«Per sgonfiarla completamente ci vuole ancora tempo… non si abbatte facilmente quella…».
«È finita, Wilker, lo sapete. E lo sa anche questa marmaglia. Manca solo la cassa da morto…
La Vedova Frexhen, rimasta colpita a morte in una sparatoria da saloon, con l’intero paese al suo capezzale, si arrende nella notte dopo una disperata resistenza, che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso per ore: qualche giornalista da strapazzo ci ricamerà sopra una torbida tragedia da far-west e per un po’ di tempo non si parlerà d’altro».
«Mi sembrate coinvolto più del necessario in questa tragedia, Wilkinson».
«Galoppa-sotto-la-Luna, tu venire sopra»,
Non capii subito.
La sciamana mi stava puntando dal piano superiore.
Per fortuna mi aveva tolto dall'imbarazzo.
«Devo andare, Wilker. Forse il diavolo ha messo fretta alla Vedova».
Mi guardò perplesso.
Risalite le scale, la vecchia indiana mi precedette dentro.
La Frexhen sembrava respirare con una certa naturalezza, il volto era meno teso, lo sguardo più nitido.
Accidenti!
Era molto strano, ma la sciamana - con le sue diavolerie - era riuscita a farle riprendere un po’ di colore.
«Sono qui, Janet...».
«Sì... anch’io...».
La fitta nebbia attraverso cui mi intravedeva si era dissolta. Lo sguardo latente aveva assunto consistenza e ora si era fissato su di me.
Nei suoi occhi aveva ripreso slancio la tacita ambizione di trovare una via di scampo.
«Vedova Frexhen, vorrei parlarvi…», il Ranger ne approfittò subito. «L’Agente Wilkinson, che attualmente lavora per voi, mi ha tolto dai piedi tre pendagli da forca; pertanto chiuderò un occhio sul vostro attacco di questa sera, e anche sul vostro passato…».
«Ho problemi... più urgenti... da gestire… Wilker...».
«Per quelli non posso farci niente. Ve la siete cercata».
«Ho commesso un errore… e sto pagando... a caro prezzo... ma non mi lascio andare...», e strinse platealmente le mani sulla ferita, stirandosi la camicia addosso, quasi buttandogli in faccia le zinne.
![]()
Le due ore pronosticate dal segaossa erano scadute da un pezzo.
Fortuna semper iuvat, aliquando artis, mi aveva insegnato Allan Pinkerton.
La sciamana, nel mentre, si era riaffacciata sull’uscio.
Non parlava molto.
Dal suo silenzio si intuiva che dovevamo uscire.
Mi richiamò dopo circa mezzora, annunciandomi un discorso della Frexhen: «Stomaco-Bucato parlerà a Galoppa-sotto-la-Luna».
Janet era provata, ma vitale. Quella megera faceva miracoli.
«Nessuno... mi può fermare… Doug… nemmeno… una dannata pallottola…
Wilker... mi ha riconosciuto… ma io… non mi faccio fregare… da una stupida... diligenza…». Janet Frexhen si era ripresa anche troppo e la sua arroganza era tornata a risplendere sulla bella faccia imperlata di sudore. «Tienilo d'occhio... non mi fido di lui…
Doug... non mi lascio andare... ma non mi faccio illusioni... potrei rimanere uccisa... ho paura...», era tornata realistica.
«Hai promesso di non lasciarmi all'improvviso...».
«No... ti chiamo... ti chiamo...».
Prima che il discorso si chiudesse, le rivolsi una domanda che mi frullava nella testa da quando Wilker mi aveva raccontato la storia di Jane Brent.
«Ho saputo che hai eliminato un tale Fred Bolton, un idiota che credeva nella legge, ma anche un certo Paulo, il tuo fedele braccio destro di allora… perché lo hai eliminato?».
«Perché… perché tu… Doug… non rallenteresti... la mia fuga… se io... fossi in pericolo…
Lui… invece… si era aggrappato... alla mia barca… e io... rischiavo di finire a fondo…… insieme... a un idiota del genere…
Tu… invece... mi ubbidisci… anche se… mi ritrovo... con un buco... nello stomaco… e devo spremermi… per tenermi a galla…».
«Non ti affaticare, Janet», le tamponai il sudore.
La risposta della Frexhen aveva una sua logica e tanto mi bastò.
![]()
La mattina successiva, Wilker non fu particolarmente sorpreso di sapere che la sua vecchia nemica aveva superato la notte.
Il Ranger confermò che avrebbe chiuso un occhio, come promesso, sia sulla Vedova Frexhen che sulla rediviva Jane Brent, sempre ammesso che fosse riuscita a farla franca.
Nonostante la feroce resistenza, infatti, Janet rimaneva con una brutta pallottola nella carcassa e un'altra lunga notte l'aspettava.
Quel buco nello stomaco era in grado di sgonfiare anche la più grossa vacca dell’Arizona.
Prima di congedarsi, Wilker mi rinfrescò la memoria su quanto capitò a Fred Bolton, un suo collega che si era invaghito di Jane Brent, nonché a lui stesso, quando per molto poco la bella Jane non lo aveva spedito sotto un buon metro di terra fresca.
Il Ranger aveva di certo capito che tra me e la Vedova c’era qualcosa di più di un semplice rapporto professionale, e in qualche modo ne sembrava perfino invidioso.
Quanto al fatto che la Frexhen fosse dannatamente pericolosa, lo sapevo benissimo da me stesso, e tuttavia avevo deciso di accettare il rischio per dare una svolta alla mia vita.
«Però c’è qualcosa che voglio chiederle prima di andarmene».
I due furono di nuovo l’uno di fronte all’altra.
«Toglietemi una curiosità, Vedova Frexhen: come ve la cavaste da quella diligenza?».
«Protessi d’istinto la testa… ero soltanto stordita... fu così che… mi risvegliai dal becchino… dentro una bara... fu là che mi raggiunse il dottore… aveva capito subito… che stavo fuggendo… ed ebbe la prontezza… non solo... di darmi per morta… ma anche... di somministrarmi un forte sedativo... perché in molti… fumavano il mio oppio… Wilker…».
Il Ranger rimase pensieroso, come a scavare nel passato.
«Una sentenza di morte che vi scagionò da qualunque pendenza terrena…».
«Spero che… non mi serbiate rancore… per quel buco nel braccio… volevo solo impedirvi… di spararmi nella schiena…».
«Storia vecchia, comunque. L’importante è che da adesso in poi non mi diate più grattacapi.
Su di voi vigilerà l'Agente Wilkinson. E di tanto in tanto verrò a controllare io stesso...».
Fu così che fui assunto da Janet Frexhen quale sovrastante generale, e fu così che quel paese ebbe finalmente un nome: Phoenix.
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
«Io…! Sono io... la più grossa troia dell'Impero, dopo Enea!».
Frexa aveva attinto a Bacco e perciò sapeva bene quello che diceva.

Il Troiano aveva infatti spalancato la Porta del Cavallo ai nemici greci, in cambio della propria salvezza. Omero aveva drammatizzato la cosa, ma nulla sfuggiva al venticello dei lupanari.

«Guardate quanti cesari cago dalla fregna...!», aveva raccolto le monete della serata e si stava toccando là sotto, insaziabile.
Frexa, la potentissima zoccola del Piceno, parecchio famosa nei bassifondi di Roma, era un piacere che andava sempre di moda tra i clienti del Thyrsus Invictus, il lupanare gestito da Quintus Lentulus Batiatus.
Era una donna libera e dopo anni di attività anche abbastanza ricca da smettere, ma ormai era una questione di potere e prestigio.
La sua ascesa era continua e potenzialmente inarrestabile; andando avanti così, avrebbe sposato qualche pezzo grosso rimasto vedovo, oppure - scelta la vittima - l'avrebbe spinta a ripudiare la moglie.
Forse avrebbe puntato lo stesso Batiatus, che aveva accumulato grandi ricchezze.
Frexa stava diventando sempre più potente, forse troppo per una prostituta. Figure influenti si erano invaghite della sua carne grassa, delle mitiche zinne e del subdolo carisma; e delle sue caratteristiche tuniche munite di borchioncini centrali, sempre allentati fino allo stomaco.
I concorrenti erano pronti a fare una grossa offerta a Batiatus, e a scatenare un'asta per portarla a servire nei loro lupanari.
In ogni caso Frexa era il pezzo forte della ditta e un esempio di eccellenza professionale per le colleghe.
A dispetto di un'età importante per una zoccola, per ambizione e spavalderia sembrava destinata a una carriera ancora lunga; perciò Batiatus l'aveva messa sotto contratto per altri cinque anni, ritoccando l'ingaggio in alto.
L'inarrestabile potenza solleticava la sua smisurata ambizione.
«A me un ferro nella panza mi fa una sega…!», non era la prima volta che la picena se ne vantava, dopo aver bevuto.
Il gladio di Roma aveva vinto su tutti i maschi del mondo, sventrando leghe infinite di budella, che se annodate tra loro avrebbero potuto allungarsi su tutte le strade dell'Impero, non una ma almeno mille volte; e tuttavia lei si sentiva invincibile.
Superba della possanza giunonica e della bellezza matura, giunta a perfezione, era sicura del fatto suo e ne aveva ben donde: sembrava infatti portatrice di un retaggio ancestrale, magnifico, aristocratico.
![]()
Nel lupanare venivano a sfogarsi molti legionari, che sia pure in licenza, si mostravano in perfetta uniforme: la vista delle loro luccicanti armi, e del gladio soprattutto, i racconti delle loro imprese, l’immagine latente dei tanti nemici abbattuti, eccitavano la fantasia degli avventori e delle stesse puttane.
Quella notte la fantasia si fece follia.
Così avvenne che l’animo di un cliente venisse eccitato dalla seducente arroganza contenuta nelle parole della potente Frexa…
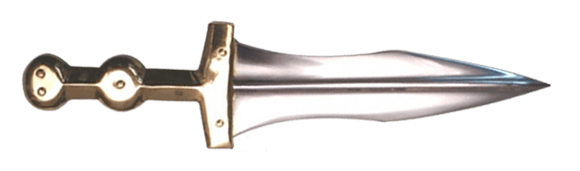
Tirò fuori dalla borsa una daga a lama larga, molto simile a un pugio da legionario, la occultò tra i lembi della tunica e andò incontro alla picena, inginocchiata sul giaciglio, in attesa di un nuovo cliente, con le tette che le penzolavano quasi fuori dalla tunica.
«Voglio proprio vedere!».
SZOCK
Gliela piantò nel ventre con gesto repentino, senza che la prostituta potesse accennare la minima reazione.
«Adesso cagati le budella...!».
E prese a masturbarsi altrettanto repentinamente, invasato dall'eccitazione di vederla morire sotto i suoi occhi.
La picena si ritrovò d’un tratto con il ferro nella pancia, rimanendo a fissarlo sbalordita, impalata.
«Ah-ah-ah…», ancora incredula, reagì con una risata isterica.
Stordita dalla lacerante sorpresa, vergognandosi di aver trovato la morte in maniera così stupida, commise l'errore fatale di stendersi a pancia sotto sul giaciglio, incubando di fatto il ferro, come avveniva in certi casi deliberatamente.
«Urghh...».
Per effetto del suo stesso peso, con quell’infausto movimento, Frexa fece affondare ulteriormente la lama.
La puttana cercò di riprendersi, scivolando su un fianco, ma la daga era ormai dentro fino al manico.
«Ma che fai… me l'hai ammazzata, idiota!», tuonò il gestore del lupanare, che la teneva sempre d'occhio.
Intorno a lei si formò un capannello di curiosi. Volevano osservarla da vicino, e guardarla mentre moriva.
La picena aveva soddisfatto gran parte dei presenti, era stata un caldo piacere per molti di loro.
Ma il piacere più grande poteva offrirlo soltanto adesso.
«Maledizione! Questa puttana vale un patrimonio! È un pezzo unico! Tu devi risarcirmi, Lucius!», Batiatus protestò vibratamente.
«Prima chiedi al tuo troione… se mi fa una sega… eh-eh…», anche il cliente aveva bevuto.
E le spruzzò addosso il seme.
«Stupido idiota… il tuo ferro... non mi fa niente… niente…», sorretta da Bacco e dal suo fisico imponente, Frexa insisteva nel tragico gioco.
Era pazza a scherzare della sua ferita. Era chiaro a tutti che le sarebbe risultata fatale.
«Questo è mio e me lo riprendo!», l'assassino accennò a riprendersi il pugnale dalla pancia della picena; sembrava uno scontro tra titani: la possanza del gladio contro quella di Frexa.
«Eh no!», Batiatus lo bloccò. «Questa diventa mia! È la daga che ha ucciso Frexa, la picena! Chi offre di più per quest'arma fatale?».
Il gestore aveva trovato il modo di rifarsi.
Le offerte impazzarono subito.
Diversi clienti erano molto facoltosi.
«Aggiudicata per 10.000 sesterzi al Se... cough... a Settimio, il calvo!
Eccola, è tua...».
«Oohh!», gemette Frexa; quando il ferro esce fa più male di quando entra.
 La prostituta sgranò gli
occhi e spalancò la bocca, conscia di essere ormai un relitto, sebbene Batiatus
stesso le tamponasse il ventre con una grossa spugna accomodata da un servo.
La prostituta sgranò gli
occhi e spalancò la bocca, conscia di essere ormai un relitto, sebbene Batiatus
stesso le tamponasse il ventre con una grossa spugna accomodata da un servo.
Il Senatore, anche lui in braccio a Bacco, mostrò a tutti il ferro appena estratto dalla pancia della famosa prostituta, ancora grondante sangue, carne e umori: «Ecco… questo è il gladio che ha tolto la vita a Frexa, la più grande tra le puttane di Roma!».
Lucius, intanto, con il volto sbiancato, si accalcò insieme agli altri per osservare da vicino la fine della prostituta.
![]()
![]()
ll gestore cercò di riportare l’ordine: «Cari amici, l'amore a volte si confonde col sangue! È la tragedia della vita! Ma ora proseguite nei vostri piaceri... avanti!», Batiatus non perdeva un colpo e volgeva gli eventi a proprio favore, innaffiando col sangue di Frexa la lussuria dei propri clienti.
Ma nessuno si muoveva da lì.
«Frexa è ferita a morte…!».
«Vogliamo sapere se dirà qualcosa...».
«Non possiamo perderci la sua fine!».
Le voci si sovrapponevano.
La picena, d’altronde, era la principale attrazione del bordello.
Lo spettacolo aveva bisogno di interpreti all’altezza per andare avanti.
Gli avventori del lupanare tributavano il loro addio all'infelice Frexa, rimanendo in ansia accanto a lei, incitandola a tirare i freni al massimo.
Al protrarsi della tribolata agonia, però, il gestore li convinse ad andarsene, facendoli allontanare dai servi.
«Si chiude! A domani, cari amici!».
Rimasero soltanto Batiatus e la collega Sextilia, impietosita dalla fine della compagna.
«Frexa... te l'avevo detto... sogno spesso di finire sventrata... forse era l'immagine di questo... ma un giorno toccherà anche a me... e vorrei avere la tua forza in quel momento...».
«Sextilia… ascolta… voglio dirti… dove tengo... il mio denaro…», la picena, smaltito Bacco, sapeva di avere poco tempo.
Poi si rivolse al gestore.
«Quintus... bagna il mio trapasso… con il tuo tirso…».
E allargò le cosce, pronta ad accogliere il fallo del padrone, non ancora spenta.
«Frexa... ho fatto chiamare il chirurgo... hai ancora cinque anni con me...».
«Sbrigati… non ho molto tempo... ».
«E allora non pensarci, Frexa. Vivi il momento.
Ecco il mio tirso…! Prendi...! Prendi, puttana!», il gestore - superata ogni esitazione - se la godeva fino in fondo.
Sextilia avvisò che il chirurgo era arrivato.
Questi, tuttavia, dopo la visita dell’infelice, scosse il capo e offrì una dose di veleno per rendere veloce il trapasso.
Batiatus la rifiutò.
«Aveva ragione Catone. Buoni a nulla e pure costosi».
«Quintus... perché... non mi finisci...».
«Nessuno può finirti, Frexa. Un ferro che possa ucciderti non è stato ancora forgiato», replicò pomposo Batiatus, lusingato dalla resistenza della sua puttana numero uno. «Un ferro nella pancia ti fa veramente una sega, Frexa…».
«Tutti sanno… della mia morte… vero…?».
«Naturalmente… la notizia è pubblica. La fama lavora anche di notte.
Frexa, la potente picena, spenta da un colpo di gladio. Nessuno scampo per la bella prostituta, nonostante la visita del chirurgo e una disperata resistenza.
Credo si diranno più o meno queste cose».

«La Didone… del Piceno... si è piegata... sul ferro… ma poi… lusingata di vivere… ha pregato l'inferno... di premergli... una spugna... sulla piaga... accorrono dalla città... per vederla morire... mentre lei... abbassa gli occhi... a terra... e prega l'inferno...».
«Chi hai avuto tra i tuoi clienti? L'Ombra di Ovidio? O Virgilio stesso?
Sei stata una stupida, Frexa».
«Avevo bevuto… ma tu… dov'eri…».
«Non ho avuto il tempo di fare niente, lo sai…».
«Il gladio… è l’unghia di Dite…».
A queste parole, quasi suggestionata da sé stessa, la puttana andò in crisi: gli occhi si dilatarono e la bocca si spalancò.
«Frexa…!», Batiatus appoggiò una mano sulla ferita.
La picena fu scossa da spasmi.
Nonostante la feroce volontà di resistere, la prostituta era agli sgoccioli.
«Frexa!».
«È finita, padrone. Forse era la donna del vostro destino, ma prima di questa notte non ve n’eravate accorto…», così gli parlò Sextilia, resa lucida dalla solennità del momento.
Ma lui non l’ascoltava nemmeno.
![]()
«Siete voi il padrone? Ho fatto il prima possibile…», in effetti era sudato.
«E tu chi sei?».
«Sono il chirurgo che avete fatto chiamare».
Batiatus rivolse lo sguardo a Sextilia.
La prostituta confermò con un cenno.
«Visto che è qua… fagliela vedere… se fa in tempo…».
Ancor prima che il secondo medico potesse visitare la morente, infuriava morbosa la notizia della tragedia: Frexa si era fatalmente aggravata, e adesso si attendeva solo l'intervento di Iride, per la Didone del Piceno.
I servi e la fama non perdevano tempo.
Molti avventori decisero di fare ritorno al bordello per cogliere l’attimo fatale della tragedia.
Alcuni di loro la incontrarono per la strada, distesa su una barella, mentre veniva trasportata non si sapeva dove: il volto stinto, gli occhi sbarrati e un braccio a penzoloni nel vuoto.
Dietro di lei, via-via, si formò un'autentica processione.
«È crepata! Frexa è crepata!».
«No! Muove la mano!».
«Maledetto sia quel Lucius! Andiamolo ad ammazzare! Nessuno sa dove si trovi?».
Gli animi a Roma si infiammavano facilmente. Anche per una prostituta. L’indignazione latina era universale.
«Sì! L'ho visto! Ammazziamolo!».
«Calma, amici! Calma!
Frexa è ancora viva, anche se molto vicina all'Orco!
Ma niente vendette! Ho già ottenuto il risarcimento!», Batiatus, giunto alle porte del medico, parlava alla folla con tono alto.
«Tu, sì! Noi, no!», un folto gruppo si avviò a prelevare Lucius, le cui sorti erano ormai legate a quelle della prostituta.
«No, fermi! Basta violenza per stanotte!
Ho saputo che Lucius è sinceramente pentito! Egli condivide con voi l'ansia per la sorte di Frexa!
Ma c'è di più, amici!
Frexa riceverà la droga del Minotauro!».

Un brusio di meraviglia serpeggiò tra gli astanti.
Fu così che, per una notte, mezza Roma rimase in piedi con il fiato sospeso per la morte di Didone.
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
 New
York, ai tempi dell’ISIS.
New
York, ai tempi dell’ISIS.
Janet Frexhen è al telefono, su una linea protetta.
Cinquant’anni sfondati, imbolsita al punto giusto, corpo e vita da bagascia di lusso.
«Allora… sputa il rospo, John».
«So che hai bisogno di soldi, Janet».
«E a chi non servono i maledetti soldi?».
«Però a te servono parecchio. Devi rientrare da un grosso buco.
Oppure i buchi li faranno a te».
«Sei bene informato, come sempre.
Vai avanti».
«Hai già fatto qualche buon lavoretto, hai l’esperienza giusta per il salto di qualità».
«Tu chi rappresenti in questo momento?».
«Nessuno. Come sempre. Solo me stesso. Sono un free-lance. Uno che lavora sodo e che sta potenziando la propria rete».
«Puoi risparmiarmi queste cazzate».
«Quello che ti propongo non è una cazzata».
«E cosa mi proponi, dunque?».
«Tra una fottuta e l’altra, avrai sentito parlare dell’ISIS».
«ISIS… non si parla d’altro…».
«C’è qualche limitato rischio da gestire, ma la paga è buona: 50.000 dollari al mese, esentasse, più le mance. Conto svizzero cifrato a doppio beneficiario. Lo intesti a chi vuoi tu».
«Così se ci rimetto la pelle…».
«Il rischio fa parte del mestiere, ma è un rischio calcolato e tenuto sotto controllo».
«Dovrò usare armi?».
«Solo il tuo corpo, Janet.
Entrerai nell’ISIS e lavorerai per loro, nella loro intelligence, con uso limitato di armi convenzionali e uso massiccio di te stessa».
«Se tu pensassi davvero quello che dici, saresti venuto a trovarmi in questi mesi…».
«Ero fuori, come lo sono tuttora».
«Tu sei sempre fuori…
Però… una donna occidentale come me… come fa a entrare nell’ISIS?».
«Tu non ti preoccupare. Una donna come te entra bene dappertutto.
Farai un lavoro sporco, Janet.
Allora… ci stai?».
«Molla l’anticipo e ci sto».
«Niente buchi, bella. Avrai i primi soldi a Palmira, da uno dei miei. Noi ci vedremo fra tre mesi, alla tua prima licenza. C’è da lavorare sodo».
«Parli come un militare».
«Non mi chiedi dov’è Palmira?».
«E che importanza ha? Sarà sicuramente un buco di merda».
«Non c'è posto più bello al mondo, ma tu lavorerai in un buco di merda, su questo hai ragione».
«Bando alle stronzate, quando si parte?».
«Adesso. Chiamati un taxi e raggiungi l’aeroporto. Non portarti niente, non dire niente a nessuno».
«Abbiamo tutta questa fretta?».
«Il tempo è denaro, Janet. E per te è anche vita.
Ti consiglio di muoverti, se non vuoi ritrovarti con un’indigestione di piombo nello stomaco».
«Non sono a questo punto».
«Tu lo credi. Lo credono tutti prima di ritrovarsi con un’indigestione di piombo nello stomaco».
«Sei il solito stronzo, John. Se attacchi, chiamo un fottuto taxi».
![]()
Palmira, la città di Zenobia, ai tempi dell’ISIS.
Janet Frexhen è al telefono, su una linea protetta.
Una squallida baracca della periferia, “da Zenobia, drink imperiali”, scritto in arabo con una bomboletta spray.
«Allora, hai capito?».
«Ma Dio Santo! Non potresti venire qui a farmelo vedere?».
«Non bestemmiare... sei dell'ISIS.
Piacerebbe anche a me fartelo vedere, lo sai. Però adesso non posso, sono fuori, arrangiati da sola, non è complicato».
«Sì, come no. Almeno possiamo ripetere?».
«Devi assumere l’antidoto, boccetta verde di colluttorio per la gola, non prima di 72 ore, non dopo 72 ore».
«Non si può dire tre giorni?».
«Come vuoi. Non prima di 120 minuti, ti cospargi le labbra di veleno, flacone rosso di disinfettante. Inodore, incolore. Questo ti evita di invitarlo a bere, cosa che suscita sempre qualche sospetto».
«Quelle labbra?».
«Quelle, certo, non penserai che venga lì per baciarti in bocca, no?».
«No, certo. E questo veleno è tanto potente da…».
«Basta il minimo contatto e penetra nei tessuti e poi nel sangue e infine arriva al cuore. Senza antidoto è fatale».
«So che te l'ho già chiesto, ma sei proprio sicuro che l'antidoto funzioni?
Non vorrai perdermi, spero...».
«È la tua migliore garanzia, Janet.
Se non sei stupida, e non lo sei, lo sai».
Una breve pausa.
«E se mi crepa a letto?».
«Non è possibile, a meno che non muoia d’altro.
L’obiettivo non morirà subito. Il decesso interviene tra i quattro e i sei giorni. Sembrerà un normale infarto, prodotto dallo stress o da fattori imponderabili».
«Ora ripassiamo come non sbagliare obiettivo. Dovermi ripetere sarebbe molto pericoloso».
«Hai ragione, brava. Gli ufficiali di Assad, ma tutti i siriani in genere, sono molto sospettosi, e in qualche caso si fanno sostituire dai loro sosia. Ora, nel nostro caso, ciò lo priverebbe di un piacere insostituibile, quindi la ritengo un'eventualità improbabile. Comunque, per non sbagliare, devi prestare attenzione a un particolare tic dell'obiettivo: si tocca spesso l’orologio. Le anomalie del comportamento sono gli aspetti più caratteristici di un individuo. Nessun sosia sarebbe così meticoloso da imitare un dettaglio di questo tipo, neanche se lo conoscesse; inoltre il sosia stesso non ha interesse nel ricercare un'identificazione troppo perfetta, perché chi rischia la pelle è lui».
«Per me queste cose sono troppo complicate, John. Io fotto e basta, lo sai. L'obiettivo si tocca spesso l'orologio. Solo questo ho capito.
Okay, ripassata la lezione».
![]()
Sette giorni dopo, o forse quindici, in nessun luogo certo, non si sa come.
«Avanti».
«Sono Ragno, perso contatto con Zenobia, chiedo ausilio».
«Ausilio concesso. Zenobia terminata.
C’è rimasta secca...».
«Immaginarsela secca… è piuttosto difficile.
Modalità della liquidazione disponibili?».
«Indigestione di piombo. Liquidata da operazione di livello superiore».
«Stronzate! Era il mio agente di punta…».
«Non ti scaldare, Ragno. La tua tela è fragile, lo sai».
«Il corpo?».
«Da crocifiggere alla consegna».
«Ci pensa UPS?».
«Negativo. Corriere interno. Consegna in ritardo».
«Uno sciopero?».
«Negativo. Merce non dichiarata alla dogana».
«Ispettori doganali ostili?».
«Positivo».
«La carcassa se l'è presa Assad?».
«Verifiche in corso».
«Dogana?».
«Palmira, M20».
«Paggetti di Zenobia?».
«Terminati».
«Sono in zona, Olimpo. Disponibile a facilitare consegna corpi da crocifiggere. La bagascia e i due ladroni».
«Disponibilità autorizzata, Ragno. Codice Z2».
![]()
Tre ore prima, o forse tre ore e otto giorni.
La bagascia sembra inquieta, il camicione sbottonato fino allo stomaco, le tette che sciacquano libere all'interno. Cammina intorno alla branda, nella sua baracca, come se qualcosa non andasse.


Spera che la sua serata sia ormai finita: il lavoro che contava davvero è stato eseguito a regola d’arte e ha dato i frutti sperati.
Fuori ci sono i due uomini d’appoggio forniti dalla rete.
Un sibilo sinistro seguito da un rumore sordo attira la sua attenzione.
Qualcosa non va.
Stavolta il sibilo sinistro e il rumore sordo sono intervallati da un grido soffocato.
Qualcosa non va davvero.
La bagascia spegne la luce e si nasconde dietro un telo di nylon, uso doccia, che appeso a un filo volante insieme ad altri panni e stracci bisunti, forma un rozzo separé nella sua topaia alla periferia di Palmira.
Abbranca il mitra e si prepara a usarlo.
Se sono banditi comuni, vedranno che c'è poco da prendere.
Se sono dei ficcanaso, non si farà prendere tanto facilmente.
Le luci esterne, però, filtrano nella baracca e la sua silhouette, non proprio filiforme, tradisce la sua massiccia presenza.
Uno degli intrusi fissa l’arma del compagno in un punto specifico e questi cambia posizione al selettore di tiro.
PFTUM
PFTUM
PFTUM
Non sono banditi comuni.
Non sono semplici ficcanaso.
Il kalashnikov ha sparato a colpi singoli: forse un segno di galanteria, forse perché il corpo dell’obiettivo serve il più possibile integro, per una seconda morte spettacolare da offrire al pubblico.
Tre colpi di kalashnikov, comunque, sono tanta roba anche per una come lei.
È una doccia di piombo, Janet Frexhen...
RAT-RAT-RAT
Lei il selettore, non essendo una gran tiratrice, ce l'ha sui colpi multipli.
Parte una raffica, ma il mitra si è già staccato dalla mano: con tre palle in corpo è diventato troppo pesante.
La Frexhen si aggrappa disperatamente al telo e ci barcolla invischiata dentro, intonando un lugubre mugolio.
La situazione precipita in pochi attimi: avvolta nel telo come in un sudario, il volto impresso nel nylon, lo trascina di peso con sé, staccandolo dal filo volante e finendo a terra...
La bocca spalancata per lo shock e la sorpresa, gli occhi fissi sugli scarponi dei sicari.
Fissi e immobili...
Le mani ancora aggrappate al telo, serrate strette, come ad attaccarsi all’ultimo spasimo di vita.
«Più facile del previsto: non se l'aspettava, ce l'ha scritto in faccia», dice l’intruso che ha sparato.
«Una puttana pensa di tenere tutti per le palle.
Portala via con tutto il telo, sporcherà di meno».
«Gran donna, però…».
«Niente commenti», c'è del malcelato orgoglio femminile nella risposta.
«Okay, okay…».
I tre corpi vengono caricati su un pick-up.
Due membri del commando salgono davanti.
Il terzo, quello che ha stroncato la bagascia, sale dietro, accanto a un M60, occultato sul fondo del cassone.

![]()
Tutto fila liscio fino all’imbocco della M20, la strada per Sukhnah.

Qui spunta un posto di blocco dell’esercito regolare.
I documenti sono a posto, le armi potrebbero essere giustificate, ma i tre cadaveri non hanno la bolla d’accompagnamento.
C’è anche un autoblindo, non si può forzare la mano.
Testacoda e via, si ritorna verso Palmira.
Urla concitate e pochi attimi dopo le prime raffiche.
Due jeep dell’esercito di Assad vanno dietro al pick-up.
«Taglia per gli scavi», dice il capo all’autista.
Gli scavi sono quelli della città antica, la Palmira romana dell'Imperatrice Zenobia.
Si va sullo sterrato adesso.
Issato sulla sponda posteriore del pick-up, l'M60 è un'ira di dio: la prima jeep di Assad va fuori controllo e si ribalta.
Il secondo fuoristrada si stacca, poi si rifà sotto... anche il kalashnikov fa male: una pallottola prende in fronte il terzo uomo del commando, che si accascia a peso morto sulla sponda posteriore, sbragandola e rotolando a terra.
«Fanculo! Hanno fottuto Mike…».
Il capo del terzetto, che è una bella donna, infila il suo kalashnikov nel lunotto del pick-up.
E spara.
Le gomme stridono, l’inseguimento procede a folle velocità tra le colonne romane.
«Attento adesso... buttati dentro la colonnata!».
Con una curva quasi ad angolo retto, l’autista del pick-up riesce a passare senza danni sotto l’arco trionfale che apre l’imponente via colonnata, maestoso resto della città morta.
Ma poco dopo è di nuovo a tiro.
Ha una ruota a terra e la jeep accorcia le distanze.
Al comando c'è un ufficiale di Assad, con il grado di tenente.
Il parabrezza del fuoristrada è piegato sul cofano, il kalashnikov dell'ufficiale ci vede benissimo.
«Ahhh-ahhh-ahhh…!!», un lamento impressionante ed estenuato dal cassone del pick-up.
Il cadavere di Janet Frexhen raccoglie il piombo del tenente e impreca di rabbia e disperazione.
La bagascia aveva riassaporato un barlume di vita, evidentemente.
Gli scossoni prodotti dall'inseguimento a tutta velocità l'avevano rianimata.
Ma solo per passare di male in peggio...
Serata maledetta per Janet Frexhen...
«Che cazzo…?!», esclama il capo del commando in fuga.
Quando realizza, esplode in faccia al compagno: «La bagascia non era morta!
Se sei viva, spara, dannata puttana!», la donna al comando afferra il kalashnikov dell'autista e allungandosi dietro, attraverso il lunotto, lo mette sottobraccio alla rediviva bagascia.
E Zenobia - mentre maledice John - spara davvero. Non se lo fa ripetere. Coglie l'attimo. Nonostante la situazione disperata e gli altri colpi incassati, la voglia di reagire e di salvarsi è troppo forte. Il cuore regge, i polmoni pure, non vuole nemmeno pensare di rimanere uccisa.
Adesso sono due kalashnikov contro uno. E in più c'è la rabbia di Janet.
Gli effetti sono devastanti.
Il tenente sembra rimbalzare più volte contro lo schienale del sedile, raggiunto da diversi colpi; l'autista si accascia sul volante.
La jeep parte per la tangente, ma l'ufficiale è ancora reattivo: raddrizza la guida appena in tempo e si impadronisce del volante.
Il fuoristrada è passato indenne in mezzo ai ruderi, come guidato da una mano invisibile.
L'ufficiale, come una belva ferita, moltiplica le forze e si rifà sotto.
Anche il pick-up sbanda paurosamente; l’autista, infatti, guida con la testa dentro il volante.
È andato, ha un proiettile nella nuca.
Il capo scarica l'autista: con un calcione lo sbatte contro lo sportello, che cede per l’urto, evacuando il corpo; poi si butta sul volante e raddrizza il mezzo appena in tempo per evitare l'irreparabile.
Intanto Janet spara ancora.
La jeep di Assad non ha più un autista.
Il tenente si è accasciato sul sedile, colpito ancora, o nell'intento di sottrarsi ai colpi.
Fatto sta che il fuoristrada è fuori controllo, sbanda, si perde nella notte.
Non c’è più bisogno di correre.
C’è il tempo di passare dietro e congratulare la non-morta, dopo averle tolto il kalashnikov...
«Sei una fottuta troia… non eri morta…?».
«As...pet...ta…», balbetta la bagascia, temendo di essere liquidata.
«Tranquilla... ti sei conquistata il diritto a morire delle tue ferite, Zenobia, Janet, o come diavolo ti chiami. Sei stata brava, hai fatto fuori quella iena...».
La mette seduta contro l'angolo del cassone e le conta i buchi.
«Sono otto...».
Tutti di kalashnikov e tutti finiti in pancia.
«Hai una resistenza bestiale, Janet.
Io e te non siamo molto diverse. Ci sono soltanto otto buchi di differenza...».
«Chi è stato… a fregarmi…?».
«Adesso vuoi sapere troppo».
«Portami… al tuo livello…».
«Ti aspettano per crocifiggerti, Janet».
«Ammazzane un’altra… al posto mio… intanto… i due ladroni… li hai trovati…».
«È una battuta facile, vecchia troia; ma la prescelta sei proprio tu».
«Non mi lasci... scampo... allora...».
«È il piombo che non te lo lascia».
Quasi per caso, a quella battuta la Frexhen comincia a tremare.
«Se ti abbottoni... sentirai meno freddo».
«Anche tu... non scherzi...», le scollature sono molto profonde.
«Sei stata brava con quel kalashnikov.
Sei un puttanone, Janet.
Sono rimasta delusa quando ti ho visto cadere giù, stecchita, addosso a quel telo schifoso. Credevo non sarebbe stato così facile».
«Lo shock… lo shock... è stato enorme…».
«Forse c'è dell'altro… una pallottola deve aver raggiunto la spina dorsale e ti ha gelato… le gambe, le muovi?».
«No... non le sento...».
«Te l’ho detto».
«Io non capisco… perché… mi abbiano... fatto fuori…».
«Neanch’io, se può consolarti».
La bagascia abbassa lo sguardo sul camicione sbottonato, inzuppato di sangue.
Come fosse uno spettacolo sconcio, incrocia gli avambracci sulla pancia, a nascondere i buchi che la condannano.
«Non posso fare molto per te, Janet.
Solo chiedere una sospensione.
Ma intanto cerca di assestarti, respira con calma...
E adesso reggiti…».
La donna torna alla guida e muove il pick-up fino a un'antica costruzione, praticamente integra.
Forza l’ingresso e scarica la bagascia all’interno, mettendola seduta contro la parete.
«Mi vuoi fregare… vero…?», la Frexhen non si fida.
«Niente affatto. Non c’è posto migliore di questo per far calmare le acque: qui non si può bombardare e nemmeno sparare troppo, a meno che non si sia autorizzati molto in alto.
Qui siamo nel gran frullatore della storia: sembra l’Egitto, ma anche Pompei, e c’è perfino un castello medievale appollaiato su una rocca, degno di Conan il Barbaro.
Non manca davvero nulla.
Questo è il Tempio di Baal. E solo un dio, ormai, può salvarti».
«Ci verranno… a cercare…».
«Buona…
Non dopo questo messaggio, fottuta troia».
![]()
Altrove, ma non troppo.
Ragno si muove in fretta. Ha portato con sé delle fiale, lui è un esperto di fiale e boccette.
Due in particolare: una di ReaniMAX e una di AlmoD.
La prima contiene plutonio, che in concorso con un defibrillatore potenziato, non omologato, è in grado, sotto circostanze favorevoli, di rianimare cadaveri “freschi di giornata” (fino a 24 ore dall’avvento della morte), pur dovendo considerare che la contaminazione radioattiva da plutonio sfocia inevitabilmente in tumori aggressivi entro tre mesi dall'applicazione.
L’altra fiala nelle zampe del Ragno contiene AlmoD, una complessa sostanza che riduce al minimo le funzioni vitali, consentendo di differire fino a 72 ore la risoluzione di lesioni a effetto mortale.
Le due terapie possono essere combinate tra loro, nell'ordine necessario.
![]()
 Tempio
di Baal, a Palmira.
Tempio
di Baal, a Palmira.
«Scusate…», la donna del commando scatta con il kalashnikov in mano.
Ma è solo un barbone.
«Io non sono di questo mondo… ho portato una coperta alla signora…».
«Sei un brav’uomo, però dimentica tutto e prega il tuo dio».
«Sono qui per questo…», e come è venuto, se ne va.
«Qua intorno è pieno di vagabondi.
Però questa ti fa comodo…».
«Ha detto… che è qui… per pregare…».
«È solo un barbone, Janet».
«Guarda… anche quello… è un barbone…».
Sulla parete di fondo del tempio, la luna - che filtra da una finestra laterale - illumina la statua barbuta del dio, seduto sul trono. Una copia, naturalmente.
«All’epoca voleva dire saggezza, oggi incuria. Il nostro è un fottuto mondo al contrario, Janet. E tu dovresti saperlo.
Comunque… se non fosse di pietra… proverebbe anche lui ciò che provo io».
«E… cioè…?».
«Sei una vacca, Janet. Un donnone. Solo a guardarti mi sento maschia.
Vorrei mi spuntasse il pisello per entrarti dentro e allargarti il buco».
«Quale...».
«Tra poco riceveremo visite, ti daranno qualcosa per tirare avanti».
«Intanto… scaldami tu… John…».
«John chi, John Doe?».
«John… è il mio uomo…».
«Tu ne hai tanti, Janet», e intanto la prende in parola, calando una mano dentro il camicione, sul seno…
«E che male c’è… la senti… quanta carne… agli uomini piace…».
«Anche alle donne maschie: te l’ho detto, sei una vacca, la più potente.
Non molli nemmeno con otto buchi in pancia».
 «Non ricordarmi... il
mio record...
«Non ricordarmi... il
mio record...
Posso mollare John... ed essere… la tua donna…».
«Adesso non montarti la testa, Janet. Rimani comunque una puttana, anche se di prima classe. E per giunta ti ritrovi con la pelliccia bucata. Non sei più un grande investimento. Qualche anno fa, forse...».
 «Però... ti piaccio...
io piaccio... ».
«Però... ti piaccio...
io piaccio... ».
«Nessuno te lo toglie».
«Mary...!», il tono si è fatto pressante.
«Mary? Mi chiamo Leila».
«Io… non m’aspettavo di… rimanere… uccisa…», non è una frase come le altre, il petto si ferma, gli occhi si rivoltano all’insù, mostrando solo la parte bianca.
«Janet…!».
La bagascia è in crisi. Il kalashnikov non perdona.
Leila cerca di rianimarla, con dei buffetti sulle guance.
È inutile.
Janet boccheggia. È finita. Ha nascosto fino all’ultimo l’aggravarsi delle sue condizioni, temendo di essere liquidata, ma non le è servito a molto.
FLAP-FLAP-FLAP
«Le pale… le senti…?», cerca di lusingarla con le ultime speranze.
I soccorsi arrivano soltanto adesso. Con la Frexhen ormai cadavere.
«È crollata quasi all’improvviso. Non se la passava tanto male fino a cinque minuti fa».
Il medico per prima cosa le somministra anfetamina concentrata e l’attacca al respiratore; poi comincia a visitarla.
La bagascia si riprende.
Il dottore la stacca dalla maschera.
«Che cazzo…».
«Hai avuto una crisi, Janet».
«Fanculo... stavo per crepare...».
«Non sei messa bene, lo sai. Adesso parlo con il medico e poi ti dico».
Si sposta in disparte.
«Vale la pena di portarla via?».
«Ha mezzora di vita».
«E se arriva in un centro attrezzato?».
«Non c'arriva. Il soggetto è al collasso. Ha emorragie interne gravi e il fegato spappolato da tre pallottole. Resiste solo perché molto forte».
«Ho capito. Adesso lo spiego anche a lei. Lasciami il respiratore e vai pure».
L’operativa le ritorna vicino.
«Ascolta, Janet. Il medico ha fatto il menagramo».
FLAP-FLAP-FLAP
Quelle parole e le pale che troncano l’aria librandosi in volo sono una sentenza di morte per lei.
La guarda delusa, sconfortata. Ancora una volta si è ripresa soltanto per sprofondare in un abisso senza fondo.
«Che cosa… ha detto…».
«Devi prepararti al peggio, ma non rimarrai sola e non ho intenzione di fregarti, te l’ho promesso. Hai l'ossigeno».
«Lo sapevo… io… fottuta…», guarda lontano. «Io... ci stavo... per credere... la puttana... più potente... con tanta carne…».
«Lo sei davvero. Sei una grande combattente».
«Non manca molto… sto scoppiando…».
«Ora calmati... e respira pulito...».
Leila l'attacca alla maschera dell'ossigeno per un paio di minuti.
«John… dillo a John… che sono morta… pensando a lui… sono una bagascia… ma lui… era speciale… per me…».
«Glielo farò sapere. C’è altro che devi dirmi?».
«Che... che Zenobia… le ha... le... ha provate tutte… prima di arrendersi…».
«Per questo sei una combattente».
Leila guarda l'orologio, la mezzora è passata, il tempo è scaduto.
«Forse... vado… per le lunghe… ti annoio...».
«Sei una bella donna, Janet. Nessuno si annoierebbe guardandoti».
«John è il Ragno... tu chi sei...».
«Io sono la Vipera».
«Vipera... quanto… m’ha dato... il dottore...».
«Mezzora».
«È passata...».
«Da poco».
«Non sono... puntuale... allora...».
«Tu sei una che non molla, Janet. È più forte di te».
«Anche tu... ci sai fare... con quest'aggeggio...».
«Finché posso ti tengo, Janet. Ma questo non basterà», e la riattacca di nuovo al respiratore.
«Lo so... però... adesso... ogni respiro... è una fottuta...».
«Che fai... provi a battere il record dell'ora?».
«Perché no... dimmi… il mio corpo... finirà in croce...?».
«Sì, il programma è confermato: la bagascia e i due ladroni».
«Cristo...».
«Ormai puoi fregartene».
«L'ho superata... l'ora...».
«Mancano cinque minuti».
«Tu stai pronta... con l'aggeggio...».
«È qui, stai tranquilla».
«La vecchia Janet... è dura... cosa ne sa... il dottore...», ma proprio in quel momento serra le dita intorno alla coperta, come non aveva fatto mai, o forse soltanto con quel telo di nylon nella sua baracca, quando aveva cercato un qualunque appiglio, prima di crollare.
Il petto va su e ricade pesante un paio di volte.
«Janet!», la Vipera chiama, le fa mordere la maschera.
Lo sguardo si distende, la crisi è superata.
«L'ora è passata, Janet».
L'estenuante agonia della Frexhen incuriosisce anche una dura come la Vipera.
A 90 minuti dalla prognosi ostile del dottore, la partita non è ancora chiusa.
«Sei una gran puttana, Janet».
«Anche tu non sei niente male.
Adesso, però, scansati, e senza fare cazzate».
«Okay, okay! È tutta tua...».
«Mi ha... trattato… bene…».
«Non mi sembra, Janet».
«John… ce l’hai… quelle robe…», con gli occhi che brillano di una luce sinistra.
«Sì, ce l'ho, ma è roba con cui non si scherza, Janet. E poi c’è il problema di questa stronza: come si chiama?».
«Leila…».
«La Vipera è venuta a terminarti, Janet. Anche se qualcosa di te la irretisce, e io so cosa, ti ha fottuto lo stesso. Il piombo che hai preso non perdona, mi dispiace. Ma se la facessimo fuori, non avremmo scampo: appartiene a un livello superiore al nostro».
«Allora… cosa...».
«Dobbiamo trovare un accordo, Vipera».
«Che genere di accordo? Non sei nelle condizioni di trattare, l’hai detto tu stesso».
«John…», Janet si lamenta; vorrebbe attenzione; sta crepando, in fondo.
«Non parlo di una trattativa vera e propria. Dico solo che se non l’hai ancora ammazzata e se stavi qui a pomparla con questo arnese, allora i nostri obiettivi possono coesistere. A me questa bagascia serve ancora, per altre missioni nel mio livello. A te per una crocifissione nel tuo. Io ho un sistema per metterla in croce e poi, a dio piacendo, farla resuscitare; il terzo giorno, naturalmente».
«E come faresti, Ragno? Sei forse uno dei Re Magi?».
«John… sto scoppiando… fa' qualcosa… o per la tua puttana… è finita…».
Il Ragno la zittisce con la maschera dell'ossigeno.
«Un rischio calcolato... tenuto sotto controllo... vaffanculo... John...», quando riprende a parlare non fa sconti; l'ossigeno, si sa, schiarisce il cervello.
«Erano tutte cazzate, Janet. Ti ho infognato in un grosso guaio, ma non immaginavo così grosso.
Allora… Vipera… gliela vogliamo dare un’ultima chance a questa troia?
Tra poco ti addormenterai dolcemente, Janet. E probabilmente avrai dei sogni. Ricordati che attraverso questi sogni rimarrai collegata con questa realtà: quindi datti da fare anche nel sogno e non farti fregare, okay?».
«Certo… io… non mi faccio... fregare…».
«Allora, ci stai, Vipera?», e le mostra allusivamente una boccetta tirata fuori dal taschino.
«Procedi».
«John… addormentami… con un bacio…».
«Sei sempre la mia troia, Janet...», e la bacia quasi strappandole il labbro.
 «Proprio una bella
coppia…».
«Proprio una bella
coppia…».
Un’entrata da teatro.
Il tenente di Assad, con una Makarov calibro 9, otto colpi, nella mano; la figura leggermente ingobbita in avanti, deve avere addosso almeno tre o quattro pallottole.
La guarda duro.
 «No!», ha appena il
tempo di capire.
«No!», ha appena il
tempo di capire.
POW
POW
Subito due colpi alla Vipera, per diminuire i rischi di una reazione.
Ben piazzati, sullo stomaco, dove finisce la profonda scollatura della camicetta verde militare.
Dapprima rimane in piedi come nulla fosse, un rapido sguardo interrogativo al Ragno.
Poi le gambe si allargano improvvisamente e frana a terra, faccia in avanti, gli occhi impietriti dall'orrore.
Ora sa come si è sentita Janet quando è stata abbattuta.
Una forza irrazionale e misteriosa la spinge a strisciare verso il suo avversario, entrambe le mani sotto la pancia a premere sui buchi, con le gambe a spingere e la testa protesa in avanti.
Si spinge fino agli stivali del siriano.
Con la bocca spalancata, impegnata a cercare aria e a compensare con la forza della disperazione gli effetti dei buchi mortali nello stomaco - il sangue già salito al labbro - chiede pietà al nemico che l'ha freddata senza lasciarle scampo.
Non usa le parole, ma gli occhi.
Vuole almeno il tempo di lottare e soffrire come ha visto fare a Janet.
Il siriano potrebbe schiacciarle la testa.
«Va' da lui...», si volta in direzione di Baal.
Non infierisce.
La Vipera riprende a strisciare in quella direzione.
Ha ottenuto qualcosa, un po' di tempo, e cercherà di sfruttarlo, in un qualche modo che ancora non conosce.
La sihlouette della possente agente operativa si snoda verso Baal, lasciando dietro di sé una scia di sangue; la vista annebbiata, il panico che la scuote dalla testa alla coda, l'intimo presagio di avere incassato colpi fatali; eppure la voglia di vivere è tale che la spinge ad andare avanti, fino all'ultimo.
Si volta viscidamente indietro, chiamando con gli occhi il Ragno. Solo lui può aiutarla, ormai; a parte Baal.
«È morta?», il tenente si riferisce a Janet.
«Quasi...».
«Tu sei l’unico... che non eri nel commando... perciò ti risparmio... per adesso...
Però attento... a non fare scherzi...».
«D’accordo, io me ne sto buono. Però ascolta, tenente. Perché sei da solo? Perché non hai ricevuto rinforzi? Ti sei ficcato dentro un’operazione molto grossa, e se vuoi uscirne, sarebbe meglio che io e te collaborassimo».
«Non sono una stupido... americano...
So come funziona...
Per me... la partita finisce qui..
Ma alla scrofa... il piombo glielo dovevo...
Zeno…!».
Il barbone di prima appare sulla soglia.
«Aiutami...».
Il siriano scompare nella notte.
![]()
Il Ragno raggiunge la Vipera, giunta strisciando ai piedi di Baal.
È rimasta con la bocca spalancata davanti al barbone.
Gli occhi fissi di chi ha cercato un'ultima illusione.
L'attacca alla maschera e parte con un massaggio cardiaco.
Gli occhi vagheggiano come relitti alla deriva.
La tiene ancora un po', poi la stacca.
«Leila…».
Un flebile alito.
«Ho un'altra fiala, ma devi lottare. Non è facile, non è uno scherzo.
Tira i freni... mi hai capito?».
Annuisce debolmente. Ha capito.
La situazione si è molto complicata.
Se porta a termine la missione della Vipera, lui, il Ragno, passerebbe di livello.
Janet è da crocifiggere, o da quella storia non se ne esce più.
![]()
Janet è morta.
Qualunque medico la darebbe per morta.
E anche lui, il Ragno, deve soggiacere al dubbio.
Per scioglierlo ha un solo modo: chiedere il parere di un analizzatore di frequenza cardiaca, con precisione al quarzo atomico.
Dopo tre minuti, trattiene a stento un sorriso.
Tanti ce ne vogliono per ritrovare un battito.
![]()
Ai piedi della croce, a volto coperto.
Ha ottenuto di consegnare personalmente il cadavere, di mantenerlo in buone condizioni per le riprese e di accelerare la crocifissione per chiudere al meglio l'operazione.
La sua abnegazione è stata scambiata per zelo, smodata ambizione di salire di livello.
Mani e piedi sono legati senza l’impiego di chiodi.
Solo un particolare va decisamente storto.
Per eccessivo realismo, o perché provocato dal camicione sbottonato da cui penzolano nel vuoto le molli tette della bagascia in croce, un miliziano non sa resistere alla tentazione e innestata la baionetta sul suo kalashnikov, prova a ficcarne la punta in mezzo ai seni; fortunatamente per il cadavere, però, il novello centurione non c’arriva bene, nemmeno in punta di piedi.
La crocifissa se la cava con una scorticata al costato.
La notizia dilaga in fretta, forte dei moderni sistemi di informazione.
Il canale all-news ABCD la racconta così: “Sdegno in tutto il mondo civile, dopo il video-shock della barbara crocifissione, da parte dell’ISIS, di tre cittadini americani, tra i quali - al centro - una donna; i tre connazionali, come reso noto dalle autorità, erano appassionati cultori di archeologia, e sono stati sequestrati durante una visita agli scavi di Palmira, in Siria; purtroppo, nemmeno i corpi saranno restituiti, fa sapere l’ISIS: verranno sepolti nei pressi delle croci; restate all'ascolto, ritorniamo dopo la pubblicità.
“I am Janet” è lo slogan che si è diffuso in tutto il mondo, sull’onda della commozione per la morte in croce di Janet Frexhen, l’avvenente cinquantenne sequestrata in Siria da agenti dell’ISIS e poi barbaramente giustiziata - insieme a due compagni - dopo un sommario processo, sotto la fantasiosa accusa di essersi proclamata erede di Zenobia di Palmira, Imperatrice pagana del III Sec. d.C.; ai due compagni crocifissi con lei, invece, è stata contestata l’accusa di aver sottratto importanti reperti storici dagli scavi dell’antica città, benché la distruzione della città stessa sia già stata decisa dall’ISIS e verrà eseguita non appena la zona passerà sotto il controllo dello Stato Islamico.
“Se n’è lavato le mani”: questa l’accusa lanciata da alcuni attivisti per i diritti umani nei confronti del Segretario di Stato, che avrebbe snobbato la possibilità di intervenire nella questione; secondo fonti non ufficiali, lo Stato Islamico avrebbe chiesto 30 milioni di dollari per il rilascio della donna".
![]()
Tre ore dopo.
30.000 dollari al miliziano dell'ISIS di guardia all'antica tomba, da dividere con i compagni, e quello sparisce.
Il Ragno, pronto con il ReaniMAX, misura la frequenza cardiaca e sorride.
Stavolta il bacio è un auspicio di risveglio.
Dopo pochi minuti il sepolcro è vuoto.
Una resurrezione rapida, in linea con i nuovi tempi.
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
 Povera
di famiglia, aveva deciso di arruolarsi nell’esercito sfruttando la deroga
concessa in via straordinaria nel 1865 per compensare le perdite della
sanguinosa Guerra combattuta contro i Confederati, approfittando anche dei buoni
uffici del cugino, il rude caporale Wallace, poi rimasto tale, a differenza
della cugina che da allora ha fatto una discreta carriera.
Povera
di famiglia, aveva deciso di arruolarsi nell’esercito sfruttando la deroga
concessa in via straordinaria nel 1865 per compensare le perdite della
sanguinosa Guerra combattuta contro i Confederati, approfittando anche dei buoni
uffici del cugino, il rude caporale Wallace, poi rimasto tale, a differenza
della cugina che da allora ha fatto una discreta carriera.
 Il sergente
Wallace
adesso ha quasi 50 anni, ma - senza dubbio - è ancora una bella donna, benché
abbrutita dalla convivenza con la soldataglia.
Il sergente
Wallace
adesso ha quasi 50 anni, ma - senza dubbio - è ancora una bella donna, benché
abbrutita dalla convivenza con la soldataglia.
Se da una parte rappresenta una piacevole curiosità per la popolazione civile, dall’altra non è molto apprezzata dai commilitoni, visto che in un paio di occasioni è risultata l’unica superstite di pattuglie a cavallo poste al suo comando, attaccate e massacrate dagli indiani.
Lo status naturale di donna, di bella donna, l’ha in qualche modo protetta, ma ai suoi compagni non va molto a genio la prospettiva di giocarsi la pelle con qualcuno che può godere di un trattamento di favore in simili circostanze.
La Wallace, dal canto suo, fa tesoro del suo status, avendo cura di portare sempre profondamente sbottonata la sua camicia blu.
In qualche modo è il suo amuleto, e finora ha sempre funzionato.
Gli ufficiali la tollerano volentieri, mentre sono inflessibili con gli altri subalterni, dai quali pretendono il massimo ordine nell’uniforme.
Dei numerosi bottoni d’ordinanza, ne lascia sciolti più della metà, se non addirittura quasi tutti, quando si sente particolarmente nervosa oppure esposta a qualche pericolo.
Le reclute fanno a gara per avere lei come istruttore.
Ma devono sbrigarsi, perché la Wallace, molto esperta, con quasi 20 anni di servizio (5 in meno degli uomini), è ormai vicina alla pensione.
Le manca poco più di un mese, per l’esattezza.
![]()

In un momento di pausa, durante l’addestramento, il caporale Stanton l'avvicina.
«Hai già deciso dove goderti la pensione, sergente?».
«In un piccolo ranch di mia proprietà».
«Da sola?».
«Da sola. Sono troppo vecchia per mettermi con un uomo.
Ma non troppo decrepita per mandare avanti una fattoria».
«Che ne dici di fare società, allora?».
«Se non cerchi complicazioni, un buon cow-boy potrebbe servirmi.
Con il tuo lavoro, però, come la metteresti? Tu ne hai di strada da fare, ancora…».
«Sono stanco di questa vita».
«La scelta spetta a te. Ma ricordati, niente complicazioni».
![]()
Jack Stanton viene a sua volta avvicinato.
«Attento a non metterti nei guai per un bisonte simile», lo avvisa il parigrado Wilkinson. «Ne ha rovinati parecchi, quella».
«È una che si fa gli affari propri, come tutti noi».
«Ti dico che è una che crede di essere ancora quella di venti anni fa».
«Perché, cos’era venti anni fa?».
«Adesso è un bisonte arruolato nell'esercito dell'Unione, una montagna di carne.
Ma per chi c'era, venti anni fa era uno schianto».
«A me sembra ancora una bella donna. Se ha retto per 20 anni, vuol dire che ha classe».
«È solo apparenza; in realtà è sempre più cattiva, rancorosa, perché vorrebbe dominare la scena, ma il potere che aveva sugli uomini è agli sgoccioli e lei ha difficoltà ad ammetterlo».
«A te cosa ha fatto?».
«Te l’ho detto, lasciala perdere, o ti rovini».
«Per me può andare al diavolo, se è tanto ambiziosa, finirà male».
![]()
Qualche giorno dopo, il tenente Walker viene incaricato di scortare il convoglio – composto da due carri chiusi – destinato a trasportare le paghe in oro delle guarnigioni militari.
Può scegliere dodici uomini.
Alla fine, ne sceglie undici.
Il tenente Frederick Walker, benché molto più giovane, ha messo gli occhi addosso al sergente Wallace e l’ha perciò incluso nella scorta, come suo luogotenente.
Ci sono anche Stanton e Wilkinson.
C'è qualche lamentela, perché la scorta appare insufficiente, rispetto al valore del trasporto, ma la penuria di uomini non consente alternative.
![]()
«Mi hanno detto che vai in pensione, Layla.
A me non sembri una donna da pensione».
«È il Sergente che va in pensione, Fred...», pesante sulla sella, con diversi bottoni sciolti e il seno che saltella al piccolo trotto.
«Potrei passare a trovarti, che ne dici?».
«Se hai tempo da passare con una vecchia, perché no, Fred?».
«Non mi sembri tanto vecchia, dopotutto».
«Mi sento tante miglia addosso, e anche il mio cavallo, Black, non ce la fa più a portarmi in giro…».
L’animale risponde con un nitrito.
«La tua bestia non sembra scontenta, Layla.
Secondo me, lui ama farsi cavalcare da te…».
Ancora un nitrito, stavolta stridulo, però.
«Che c’è, Black?».
BANG BANG BANG
L’amabile conversazione viene bruscamente interrotta.
Ecco cosa c’è.
Sparano!
Colpi di winchester dall’altura a sinistra.
E anche da quella destra...
«Ahh...!», il caporale Stanton viene disarcionato in un amen da un proiettile fatale che lo seppellisce con la faccia nella polvere, senza nemmeno il tempo di sputacchiare al prete i suoi peccati, primo fra tutti quello di aver sognato, e molte volte, di scoparsi il sergente Wallace.
«Un’imboscata! Al riparo!», il tenente Walker urla i suoi ordini, senza rendersi conto che lì l'unico riparo è la fuga, il galoppo oltre la gittata delle pallottole, intrappolati come sono in una stretta gola rocciosa: chi ha organizzato l'agguato ha scelto con cura questo punto.
BANG BANG BANG
«Ahh!», un altro punto morto.
Per due giovani soldati del drappello.
«Via da qui, maledizione!», la Wallace sa bene di doversi togliere alla svelta da quel casino, se vuole arrivare davvero alla pensione, e piantando gli speroni nei fianchi del suo cavallo, lo sprona a galoppare veloce verso l’uscita della gola, fuori dalla portata di quei fucili che continuano a sparare precisi, con la sola canna fumante a far capolino dalle rocce.
«Yaaa, yaaa!», Black risponde subito alle fitte procurate dagli stivaloni della padrona, occhi di fuoco e bava alla bocca, in quel momento la donna e l'animale hanno le stesse sembianze.
Nonché lo stesso fottutissimo scopo.
Salvarsi la pelle.
BANG BANG BANG
Il drappello di scorta, mortalmente penalizzato dalla sorpresa e dalla pessima posizione, si è già più che dimezzato: rimangono soltanto il tenente Walker, il caporale Wilkinson e due soldati.
Sono riusciti a rotolarsi nella polvere, cercando scampo sotto i due carri, ma gli avvoltoi, già richiamati dagli spari e dall’odore di morte, sanno che è solo una questione di pazienza.
Per il momento si limitano a volteggiare sopra l'inatteso banchetto, la tavola non è ancora pronta.
Mancano quattro portate.
Più il dolce.
Il sergente sbottonato.
«Non potremo resistere a lungo, accidenti!».
«Uhh…!», Wilkinson è buon profeta e si becca una pallottola di rimbalzo in piena fronte, un bel buco che si potrebbe scambiare per il terzo occhio, se non fosse che il suo sguardo è ora più morto che mai.
Gli altri tre, Walker in testa, tentano di rimandare il destino il più possibile, scaricando tutti i proiettili che hanno nelle pistole e nei fucili, ma alla fine le uniche pallottole che rimangono loro sono quelle che si ritrovano in corpo.
Il tenente rimane a bocca aperta – forse per aver cercato l'ultimo respiro di vita, forse rimpiangendo di non aver seguito la Wallace quando ancora poteva – gli occhi sbarrati a vedere eternamente il niente.
Il primo avvoltoio, quello meno dotato di pazienza, plana sul cimitero senza croci e inizia a guardarsi attorno, scattando con il capo a destra e sinistra, nervosamente.
Nervoso per l'imbarazzo della scelta.
«Ottimo lavoro, sergente Wallace...», un uomo con una vecchia divisa sudista si para con il suo cavallo davanti a lei.
«Sono passati alcuni anni dal nostro ultimo affare, ma i risultati sono sempre ottimi. E non solo i risultati...», le butta un’occhiata volutamente insistita sull'ultimo dei bottoni slacciati, dove fanno invitante mostra di sé le tette sudate per il gran caldo e la fatale tensione.
«Lascia stare il mio seno... e ricordati che la mia colt è ancora carica...
Ho sparato soltanto due colpi a casaccio, quel che bastava per non insospettire quei poveracci...», lei invece butta il suo sguardo sui cadaveri dei soldati.
«Non dirmi che il sergente Wallace adesso è diventato anche sentimentale...», e ride scompostamente, sputando a terra la cicca per farlo appieno.
«Andiamo...».
Insieme si muovono verso i carri.
«Controllate che ci sia tutto!», il bandito si rivolge ai suoi uomini, ai quattro cecchini che hanno sparato protetti dalle rocce.
«Non ti fidi, lurido maiale?», la Wallace sa spazientirsi alla svelta, con la mano che le scivola di riflesso sul manico della colt.
«Di te, mai», e la guarda duro, copiandole pari-pari il gesto.
«Tieni a bada le mani, Garrett...», anche se le sue sono ancora più nervose, quasi speranzose che l'uomo faccia la prima mossa.
Dopo che il copione di quella recita le ha imposto di sparare un paio di colpi all'aria, adesso sente salire l'eccitazione per una sfida che può divenire tragicamente concreta anche per lei.
Poi, lentamente, con la sinistra si sbottona l'ennesimo tassello, forse per darsi la carica, forse per intimidire l'avversario, forse per lanciare un segnale convenuto.
L'uomo accusa il colpo.
«Layla...».
«Un carro per uno, Garrett.
E niente extra...».
«E va bene... i patti erano questi.
E poi... ti sei fatta troppo grassa per i miei gusti.
Allora, ragazzi... se tutto è a posto, ce ne andiamo!
La signora ha fretta di lasciarci...», Garrett pare divertirsi e lo conferma accennando la sua solita, sguaiata risata.
BANG BANG
Ma è appunto soltanto un cenno, la paresi improvvisa prodotta da due pallottole in pancia, gli blocca l'espressione così com'è, decisamente incompiuta.
«Uhhh...», il tempo solo di un rantolo strozzato e si affloscia sulla schiena del cavallo, rotolando a terra.
BANG BANG BANG
Altri colpi, sparati dallo stesso invisibile fucile.
BANG BANG BANG
A cui si aggiungono quelli della colt di Layla, il seno che quasi le balzella fuori dalla camicia, a ogni colpo.
È presto finita.
I cecchini sono diventati bersagli, in queste zone il vento fatale cambia facilmente.
«Oggi è il vostro giorno fortunato», il sergente sbottonato – la lingua a umettarsi le labbra per l'eccitazione del successo – mostra il suo volto crudele e sembra godere di quel via-vai di uccellacci tenebrosi, orgogliosa di avere contribuito attivamente al loro abbondante pasto.
È illesa e vittoriosa. E si è procacciata una liquidazione adeguata ai suoi 20 anni di onorato servizio nell'esercito dell'Unione.
«John... sei sempre il migliore quando si tratta di sparare alla schiena...», scende da cavallo e gli va incontro, dopo aver chiuso un bottone e ricomposto le tette. È finita, ce l'ha fatta.
John Strutton, ex pugile, ex cacciatore di taglie, ex truffatore, ex di tutto.
Anche di lei.
«Ho fatto il mio dovere, puttana... non lamentarti.
Anche tu non scherzi, a quanto ho visto», ci va giù duro, è tipo di poche parole e non certo raffinate.
«Difatti ti ho appena detto che sei il migliore nel tuo campo...», lo guarda dal basso verso l'alto, lei piantata con gli speroni a terra, lui in sella al cavallo, postazione ideale per sbirciarle il seno da mignottona che affiora dalla camicia blu.
«Povero Garrett... ha pagato con la pelle l'errore di arruolarti nella sua banda...
Ma quello che lo ha fregato davvero è stato il nostro incontro...».
«Non c'è soldato o bandito che possa dirsi innocente, John. Uccidere in divisa è sempre uccidere. E io, visto che sono già dannata, preferisco presentarmi ricca davanti a Satana».
«Non avevo dubbi».
«Un carro per uno, John, come nei patti.
Meglio filare, adesso».
«Non c'è tempo per un extra...?».
«E niente extra...», lo stava giusto per dire.
«Un carro per uno...
Poteva anche andar bene», un lampo rapido come una folata di vento gli attraversa gli occhi. «Ma la vita da queste parti è sempre più cara e pericolosa...».
«Che cazzo significa, bastardo?!», si ritrova faccia a faccia con la colt di Strutton, che la guarda dall'alto verso il basso, con la canna a fare ombra al sudore delle sue tette.
«Che sono il migliore nel mio campo», e muove la pistola più in basso, andandole a piantare l'ombra della canna sull'ultimo dei bottoni in quel momento agganciati, all'altezza dello stomaco.
«Ma con te faccio un'eccezione».
Click!
«Non ti sparo alla schiena».
«No!».
BANG
«Uhhh...!», un colpo le fa saltare il bottone chiuso sullo stomaco.
«Lurido... bastardo...», cala lo sguardo sul buco lasciato dal piombo, un bottone di carne sanguinolenta, poi lo rialza - ancora incredulo - verso il suo assassino...
Si è lasciata sorprendere! Ha perso il controllo della situazione!
Quindi uno sbuffo di polvere alzato dalle ginocchia pesantemente cadute sulla terra.
«Due carri... pieni d'oro... uhh... bastavano... per tutti e due... ohh...», lo sguardo fisso in avanti, vuoto, disperato...
«Troppo non è mai troppo».
 BANG BANG
BANG BANG
«Ahhh!», Strutton somiglia d'improvviso a Garrett, stessa espressione e stessi occhi a sporgersi disperatamente oltre i confini delle orbite.
Un attimo dopo, crolla a terra fulminato, finendo lungo a braccia larghe, con un bottone sul cuore.
Aveva una derringer sotto la camicia, l'abbondante ciccia della pancia come fondina.
«Ora... è tutto mio...», e aggrappandosi a sé stessa, alla propria stazza, riesce a rimettersi in piedi, in dolorosa posizione eretta.
Ma la fiera posizione è subito persa: Layla deve incurvarsi, quasi piegata in due, in una postura più consona a chi si è appena beccato una pallottola nello stomaco.
Gli stivaloni di cuoio che si trascinano sulla sabbia alzano più polvere che passi, i carri sono lì che aspettano, eppure sembrano lontani.
Si è fatta sorprendere! Ha rovinato tutto!
Ma è lei ad avere ancora il controllo della situazione!
Almeno così crede il sergente sbottonato.
«Maledetto... uhh...», ha il fiato per imprecare contro Strutton, mentre tira giù dalla cassetta, con una sola mano, un soldato della scorta.
«Ohh...», una salita dolorosa ed è sul carro, piegata sulla sua ferita, pensierosa, allarmata, inquieta.
Il sergente Wallace si impone di rimanere calmo.
Con il fazzoletto giallo d'ordinanza si tampona il buco. Ha deciso di non mollare. L'oro è tutto suo. I programmi non cambiano. Anzi raddoppiano.
«Yaaa... yaaa!», sblocca il freno e lascia andare i ronzini attaccati al carro, che inizia pesantemente a muoversi, insieme alle sue casse.
BANG BANG
L'altro freno è sbloccato a suon di piombo.
Poi una pacca al suo cavallo che le marcia a fianco.
«Corri Black... vai al ranch... corri...».
BANG BANG
Un paio di colpi per dargli lo start.
Un nitrito selvaggio e la possente bestia parte al galoppo.
«Il ranch... non è lontano...», dice a sé stessa, cercando di convincersi, mentre le ruote si muovono lentamente, portando adagio il carro fuori dalla gola, seguite - con militare disciplina - dalle altre quattro.
La sua pensione in fondo è lì, a portata di ronzino, qualche miglio più a sud, al di là del confine.
Però c'è un bottone di sangue che la divide dal suo ranch, nonostante tenti di nasconderlo con ostinazione sotto il palmo di una mano.
«Sono grossa... robusta... io... posso cavarmela...», prova a nasconderlo soprattutto a sé stessa, ma non può fare altrettanto con gli avvoltoi, gli unici animali che diagnosticano le ferite meglio dei dottori.
Due di loro hanno difatti lasciato il banchetto per seguirla, restando a farle ombra una decina di metri sopra il suo carro, silenziosi come la morte.
Di solito volteggiano a cerchi concentrici sopra l’obiettivo designato, e ogni cerchio che chiudono è un minuto in meno che resta al condannato, prima di crepare.
Brutto segno, sergente Wallace.
La pista che si curva a sinistra, per tornare subito rettilinea e aprirsi al panorama di un’ampia distesa, una pianura recintata in lontananza dalle montagne, abbellita da piccole macchie verdi, fino a lì assenti.
E prima delle montagne, il suo ranch.
La sua pensione.
«Non posso... crepare... proprio... adesso...», a volte è l'ostinazione a far restare tale un moribondo.
«Non voglio... crepare... Satana... è con me... sono ricca...», a volte basta credersi potenti.
Eppure l’ombra degli avvoltoi sembra divenire sempre più grande.
«Maledizione...», è costretta a piegarsi in due, le tette sudate sono libere a penzoloni sul ventre, cadenti quanto lei adesso: Layla toglie il fazzoletto e si guarda il buco che ha sullo stomaco.
È più grande di quello che ricordava e continua a buttare sangue.
«Quel bastardo... m’ha fottuto...», mormora stizzita.
Ma intanto rimette a posto il fazzoletto e lo tiene premuto con ambo gli avambracci, piegata in due, quasi a coccolare una creaturina, forse la sua ultima illusione.
Capisce subito, comunque, che è più importante provare a tamponare quel poco di sangue che le resta, che non stare a imprecare contro un morto.
È così che, se non altro, riesce a guadare il fiume, quasi in secca, che le interessava oltrepassare.
«Satana... aiutami...», spaventata a morte dalla gigantesca ombra degli avvoltoi, con la testa che le gira e il mondo che si sdoppia: un altro fiume, altri ronzini dalla lingua di fuoco, un altro carro guidato da Caronte, che la chiama per nome e – acciuffata con un lazo – la carica a forza sul suo traghetto a 4 ruote.
Nella testa della Wallace c’è ormai un polverone infernale.
Il sergente sbottonato, prima di mollare, cerca di mettere a fuoco la realtà: ma vede ancora un polverone.
Un polverone che si avvicina.
Ormai impazzita, impugna la colt e si prepara a ricevere l’infernale postiglione. Se non è già morta, morirà con le armi in pugno.
![]()
La paura di Layla è tanta. Eppure, chiunque fosse emerso da quel nugolo di polvere, fosse il destriero nero di Satana o il suo Black, per lei sarebbe stato solo un dettaglio.
Proprio come il bottone di sangue: un dettaglio che avrebbe portato con sé, alla stregua di un tatuaggio sullo stomaco.
Forse la cosa interessa di più a quei due avvoltoi: le bestiacce cominciano a rimpiangere il banchetto, forse era meglio procedere per gradi, anziché puntare subito al dolce.
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
Nella banda di Luciana Mendez c’ero entrato più per divertirmi e sparare che per fare soldi.
Ma da quando s'era messa d'accordo con Anna Fernandez, un altro pezzo da 90, eleggendola suo braccio destro, il divertimento si era fatto esagerato.

Anna era una vecchia puttana che aveva fatto fortuna con la sua camiciona sbottonata.
A 50 anni, spremuta e imbolsita, credeva di essere ancora la migliore, e questo mi metteva la febbre addosso.
 La Mendez l'aveva cercata
soprattutto per mantenere in tiro i suoi uomini: sapeva di non prendere una grande
pistolera, ma come vacca da spremere sarebbe stata imbattibile.
La Mendez l'aveva cercata
soprattutto per mantenere in tiro i suoi uomini: sapeva di non prendere una grande
pistolera, ma come vacca da spremere sarebbe stata imbattibile.
Anna aveva sempre caldo e il suo camicione era sbottonato in maniera arrogante fino all'ombelico; come se non bastasse, insinuava spesso la mano all'interno della profonda scollatura... tirava fuori un fazzoletto e si asciugava il sudore intorno alle zinne...
La Fernandez sapeva di avere presa su di me: mi era fatto sorprendere più volte, mentre la guardavo con occhi sbarrati; però non con il solito sguardo; e lei doveva averlo capito.
Il suo volto, la sua figura e il suo modo di fare mi erano in qualche maniera famigliari. Forse l'avevo riconosciuta.
Ma lei no. Era solo l'immagine di Anna.
"E ti sembra niente?", mi sussurrava una vocina nel cervello.
Tuttavia dovevo tenermi e stare attento a Luciana.
Era un demonio. Nella sua banda le palle erano quasi superflue: poteva prestarle a tutti.
Sapeva capire un uomo come solo una donna sa fare, ma aveva la forza, l'abilità e la durezza di un guerriero apache.
Se solo avessero imparato a usare i fucili...
Lei però lo aveva fatto (!).
Perciò dovevo badare al mio scalpo.
![]()
Un breve sconfinamento e un colpo grosso alla Redshield Bank di Tombstone: tutto liscio come l'olio.
Eravamo arrivati un po' alla volta, mischiandoci alla folla della Main Street.
E adesso eravamo a cavallo, pronti a ripartire insieme, per scoraggiare eventuali inseguitori.
Lo Sceriffo, però, non seppe farsi gli affari propri.
«Puttana...!».
Era anche uno sceriffo maschilista, perché se la prese con una donna.
Le possibilità erano due.
«Bastardo!».
La voce era di Anna. Era lei quella chiamata in causa. Il riferimento era preciso.
BANG
BANG
Si scambiarono i colpi.
Lì per lì la Fernandez non lo diede a vedere, quasi vergognandosene. Si fece paonazza in volto, ma si trattenne da qualunque reazione - ben piantata su sé stessa, forte della sua stazza - spronando il cavallo come niente fosse, anticipando anche Luciana.
BANG
BANG
Finimmo lo Sceriffo e spronammo al seguito.
Luciana era stata chiara: nessuna pietà per questo genere di stronzi che chiamano puttane le donne.
Tanto la corda, ormai, non ce la levava nessuno.
L'incidente sembrò subito dimenticato, gli altri festeggiavano il colpo sparando in aria.
«Basta, idioti!», ogni volta era la stessa storia.
La Mendez fu costretta a urlare: la pista per la Sierra era lunga e avevamo ammazzato lo Sceriffo di Tombstone; uno stronzo, certo, ma con la stella di latta sul petto.
L'unica che non festeggiava, a parte Luciana, era la Fernandez.
Affiancai il cavallo al suo e mi accorsi subito che qualcosa non andava.
Anna aveva perso qualcosa per strada, forse la sua aria strafottente; lo sguardo si era fatto perplesso, insicuro; e come se non bastasse, avrei giurato di intravedere uno spurgo di sangue dalla bocca, a stento trattenuto dentro, come uno sputo che si rimanda giù.
Teneva le redini un po' goffamente, con l'avambraccio attaccato al corpo.
Anna mi lanciò uno sguardo sospettoso: sapeva che io sapevo.
Le donne di razza hanno questo tipo di intuito.
Il piano prevedeva, come sempre, di raggiungere la Sierra e far perdere le tracce.
In mezzo a quei canyon, nessuno avrebbe potuto stanarci.
![]()
Cavalcavamo da ore.
Mi tenevo dietro alla Fernandez per controllarla da vicino ed essere pronto a intervenire.
Ne studiavo ogni mossa, ogni piega del volto e ballonzolio del seno.
Non aveva mostrato segni di cedimento, era forte come una bestia selvaggia, nonostante l'età. Aveva una gran voglia di vivere.
Finalmente Luciana alzò il braccio e giunse la prima sosta.
Anna smontò da cavallo tenendosi in disparte.
«Tre volontari», la Mendez distolse la mia attenzione.
Nessuno rispose, si attendevano spiegazioni.
«Tre volontari per fare da tappo».
Eravamo alle prime pendici della Sierra.
Nessuno rispose, era un incarico pericoloso.
Stava cominciando a spazientirsi.
Tra poco avrebbe scelto lei.
«Tre volontari al comando di Anna».
Alzai il braccio per primo, imitato poco dopo da Pedro.
La Mendez mi lanciò un rapido sguardo: apprezzava chi sapeva morire per una donna.
Juanito completò il trittico dei volontari.
Senza neanche avvicinarsi, aveva capito tutto.
Perciò era il capo.
Anna non poteva proseguire a lungo.
Tanto valeva spenderla.
«Vamonos... cabrones!», esaurita la sosta, Luciana riprese la pista.
«Muchachos...», Anna riunì gli uomini. «Ho preso una pallottola... ma non rimarrò fottuta... la vecchia Anna ha voglia di vivere».
Si sciolse il foulard dal collo e se lo schiacciò sulla ferita in pancia.
«Sparate per uccidere... non devono passare...», con un filo di sangue alla bocca che cercava goffamente di rimangiarsi.
Che qualcuno ci inseguisse era chiaro dalla polvere sollevata in lontananza.
Ma che fossero una ventina non lo potevamo certo immaginare!
A meno che il demonio di Luciana non pesasse pure la polvere...
La Fernandez mi lanciò uno sguardo fulminante: anche lei aveva paura; voleva giocarsi le sue carte con un po' di tranquillità intorno, non così.
E io dovevo suicidarmi insieme a una moribonda: non era affatto equo.
Anna aveva poco da perdere, ma io ero ancora intero e volevo rimanerlo.
Avrei potuto mollare tutto e andarmene. Ci avrei rimesso i soldi del colpo e quelli della cassa comune, ma non la vita.
«Non voglio morire... rimaniamo vicini...», Anna preferì non fare la presuntuosa, lo apprezzai molto.
Ciò che mi trattenne non furono i soldi.
Maledetta!
Stavano arrivando, il rimbombo degli zoccoli incalzava.
Andavano al piccolo trotto, la velocità giusta per stenderne subito un paio.
Mi concentrai sulle stelle di latta.
BANG
BANG
Era il fucile che aveva fatto il West e io me ne volevo godere un pezzetto.
C’erano già una mezza dozzina di corpi a terra, prima che riuscissero a smontare e a ripararsi.
BANG
BANG
Ne finii un paio che ancora si agitavano, soprattutto per intimorire gli altri.
Nella posse ci si faceva forti del numero, ma i coraggiosi erano pochi.
E poi erano dei criminali come noi, se non peggio.
Noi le banche le attaccavamo, loro le difendevano.
Adesso, però, dovevamo stare attenti, perché i superstiti avrebbero tentato di accerchiarci.
BANG
BANG
Pedro e Juanito li avevano già beccati.
Guardai in direzione di Anna.
Anche lei era d'accordo.
Il nostro lavoro l'avevamo fatto.
Prima che fosse troppo tardi, sgattaiolammo verso i cavalli.
Ero pronto ad aiutarla, ma riuscì a montare da sola; quindi spronammo ventre a terra.
BANG
BANG
Ci spararono dietro, ma con un po' di fortuna riuscimmo a filarcela.
Gli inseguitori avevano il morale e i compagni a terra.
Forse avrebbero mollato.
Sapevano che da adesso in poi sarebbe andata anche peggio.
Le strette gole che si insinuavano nel ventre della Sierra erano facili da difendere.
Anna alzò il braccio, avevamo spremuto i cavalli, dovevano riposare.
Smontò con difficoltà e andò a sedersi contro uno sperone di roccia.
Masticava amaro, con le mani nervosamente premute sulle cosce.
«Controlla... se vedi polvere...».
«Bueno».
Mi arrampicai su un poggio per vedere in lontananza.
«Hanno mollato.
Su... bevi qualcosa...», le passai la fiaschetta.
«Li abbiamo fermati…», ma non c'era soddisfazione nelle sue parole.
La vacca spremuta di Anna Fernandez se la faceva sotto dalla paura, anche se aveva ancora il controllo.
Anch'io, come tanti, la chiamavo così, fra me; ma non intendevo quel genere di vacca.
Per me era un complimento alla sua forza, alla sua voglia di dominare, alla sua capacità di rimanere attraente anche con tanti anni addosso. Non solo carne e zinne, insomma.
Sapendo di irretirmi, si asciugò il sudore che le colava nel seno, passandosi il mio fazzoletto sulle tette.
«Conosco questo genere di ferite... cough... e le conosci anche tu... Jack...
Ho tanta voglia di piangere...».
«Non rimarrai uccisa, Anna.
Una come te può farcela».
«Non voglio morire... non voglio nemmeno pensarci... cough... cough...».
La capivo, si piaceva, era contenta di sé.
Come non capirla?
![]()
Raggiungemmo gli altri ad Agua Maldita, un misero pueblo quasi disabitato.

Anna, ormai, si reggeva a stento sulla sella.
Il covo era ancora lontano e occorreva fare una tappa.
I peones non creavano problemi e per un pugno di spiccioli si spaccavano in quattro.
Luciana le procurò un alloggio per farla morire in pace.
Al villaggio non c'erano segaossa; non c'era praticamente niente.
«Rimani...», sussurrò.
Aveva bisogno di sostegno.
«Jack... chiamami se...», Luciana alludeva ad Anna.
La Fernandez smaniava sul giaciglio: un lusso da regina in quel buco di posto.
Le mani pressate sulla pancia le davano un po' di sollievo.
«Stella maldita...», doveva riferirsi al defunto Sceriffo di Tombstone.
Allungò una mano verso di me. Gliela presi.
«Te lo ricordi... Sancho... cough...
Sembrava un gigante...», ricordava con occhi sbarrati, immedesimandosi. «Però... non ci mise molto... cough... a crepare...».
«Non ci pensare troppo, Anna. Ogni ferita è diversa dalle altre».
«Dov'è Luciana... perché non è qui... cough... ho paura...».
«È andata a fare un lavoro».
«Che lavoro...».
«È andata ad accendere un fuoco.
L'ultima carta che puoi giocarti è quella di uno stregone indio.
Ce ne sono da queste parti, ma vivono isolati.
Ci vorrà un po' di tempo».
![]()
 BANG
BANG
BANG
Spari...
E non erano festeggiamenti.
Sentii Luciana urlare ordini.
Il pueblo era sotto attacco.
Ma da parte di chi?
Dalla finestrella della casetta riconobbi qualche sombrero...
Era la banda del Puerco.
«Forza, Anna... sono in tanti, serve anche la tua pistola».
«No... ho paura... non combatto più...».
«Avanti... non fare storie. Ti metto seduta su questa cassa: sparerai dalla finestra, senza correre rischi.
Se il Puerco ha la meglio, ti ucciderebbe comunque...».
«No... a me no...», e mi sorrise perfidamente, stirandosi addosso la camiciona...
Aveva ragione, d'altronde.
Ero più moribondo di lei.
Non potevo contare sul suo aiuto.
Anzi, dovevo stare attento.
La pistola ce l'aveva a portata di mano, come sempre, e per ingraziarsi el Puerco, la Fernandez non avrebbe certo esitato a spararmi una pallottola nella schiena.
«Fa' come ti pare, ma sta' attenta a non fare sciocchezze...
Claro?», la guardai fisso negli occhi sfuggenti.
L'avevo avvertita.
![]()
BANG
BANG
La sparatoria andava avanti.
E partecipavo anch'io, dalla finestrella della casupola.
«Jack...», la vacca spremuta mi chiamava. Era in difficoltà.
Le fui accanto.
«Sto morendo... pensa a me... cough...».
Rinforzai la porta con qualche masserizia e sospesi il fuoco.
«Anna... cerca di stare calma...», non potevo abbandonarla.
«Jack... aiutami... cough... non voglio morire...».
«Lo stregone arriverà presto».
«Ne ho per poco... lo sento...», a guardarla in faccia sembrava avere ragione.
«Non ci credo... cerca di andare avanti...».
La Fernandez stava per sputare il rospo.
Aveva gli occhi fissi al soffitto della fatiscente casupola.
«Il sudore... maledetto...», stava divagando. «Asciuga... avanti... le zinne...», la voce era sfinita, disperata; sapeva di avere pochissimo tempo.
E lo passava provocandomi fino all'ultimo.
Mi sciolsi il fazzoletto dal collo e glielo passai all'interno della scollatura, facendo come mi aveva detto.
Neanche il tempo di rialzare gli occhi e la testa le cadde all'indietro, la bocca spalancata e gli occhi gelati.
Si era spremuta a fondo per tirarla alle lunghe.
Le asciugai i seni per l'ultima volta, sudando freddo anch'io.
Infine, presi il suo sombrero e glielo poggiai delicatamente sul volto.
Non mi ero nemmeno accorto che gli spari erano cessati.
Presto avrei conosciuto il mio destino.
TOC-TOC
Bussavano alla porta.
Da una sanguinosa sparatoria a un atto di buone maniere: era tutto molto strano.
«Chi è?».
«Apri la porta, imbecille!», era la voce di Luciana...
Accompagnava lo stregone indio giunto al villaggio.
«Anna!», la Mendez, stizzita, le spazzò via il sombrero dalla faccia.
Fece un cenno all'indio e quello le infilò subito una lunga penna di corvo in gola.
Il corpo, dopo qualche attimo, sembrò avere dei sussulti...!
«Tu soffiare dentro».
Guardai inebetito lo stregone.
Ce l'aveva proprio con me.
«Jack... devi soffiarle in gola.
Muoviti... o vuoi farla crepare?».
«Io?», non capivo.
«Tu, sì! Sei il compagno che ha avuto l'ultimo contatto con lei.
Soffia forte e cerca di ripetere quello che stavi facendo quando è venuta a mancare», Luciana sembrava più esperta dello stregone.
Le soffiai in bocca e tornai ad asciugarle il sudore fra i seni.
«Sei un bastardo, Jack».
«Me l'ha chiesto lei, te lo giuro».
«Glielo chiederemo...
Ora basta... non vedi che respira da sola?».
Lo stregone le fece trangugiare una pozione.
«Se tu parlare, parlare adesso».
«Anna... sono Luciana... hai chiesto tu a Jack di palparti il seno?».
«Non di palparlo... ma di asciugarle il sudore fra i seni!», precisai immediatamente.
Ecco... stava muovendo le labbra...
«No...».
«Non vorrai crederle! Non è lucida!».
Luciana mi guardò fisso, con durezza.
«Sei perdonato...
Perché hai rischiato la vita, pur di rifare l'ultima cosa che hai fatto.
Ma se ti ribecco, ti sotterro ad Agua Maldita, claro?».
Era viva.
Solo questo contava.
Ed ero vivo anch'io. Almeno per il momento.
E pure questo aveva il suo valore.
Forse Anna con il suo "no" si era riferita al momento in cui le avevo asciugato le zinne, pensando fosse morta. Era cosciente anche in quel momento, allora. Oppure m'aveva guardato dall'inferno.
In ogni caso, lasciai mezzo dollaro a uno di quei peones per una bella lapide di legno marcio nel loro piccolo cimitero.
A certe cose bisogna pensarci per tempo.
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
Le 08.00, guardo il mio Rolex d'oro allacciato sopra il polsino della camicia, uno dei tanti vizi inutili con cui l'Occidente mi ha imbastardito, e tremo.
Apro le due ante di vetro facendole scorrere una opposta all'altra ed esco sul grande balcone, lasciando che la fresca aria di quest'ora mi porti sulla faccia un mattino che da domani sarà scritto sui libri di storia.
Mi accendo una sigaretta e guardo il Manhattan Skyline e le Torri sono lì come ogni giorno, inconsapevoli che oggi crolleranno insieme alla colonna portante dell'Occidente.
Cinque anni fa sono uscito dal mio Paese, ma senza scappare, senza macchiarmi di nessuna vile fuga, me ne sono andato con una laurea in scienze matematiche con lo scopo di arrivare qui e diventare uno di loro. Imparare a pensare, agire, mangiare, dormire, ridere, piangere, fingere e specialmente imparare a scopare come loro, per poi aprire il portellone di legno e colpire Troia dall'interno.
Troia, come Anna Coen, donna fascinosa e dalle rotondità sensualmente accentuate dai suoi chili di troppo, ma soprattutto figlia dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, pregio che mi ha fatto innamorare perdutamente di lei.
Con una sola mossa sono penetrato in due troie: una l'ho sposata e l'altra l'avrei colpita molto presto.
Prendo dal pacchetto un'altra sigaretta, la prima si è bruciata più veloce del solito, e riporto lo sguardo sul Manhattan Skyline, pensando alla coincidenza che accomuna Anna alle Torri: anche lei ha una gemella, Rebecca, stessi modi e solite curve eccessivamente ingrassate.
Le troie gemelle.
![]()
È successo, è successo davvero!
Mi giro per posare la bottiglia con cui sto brindando e lo sguardo mi finisce sulle serrande ancora abbassate della camera da letto, solo adesso mi rendo conto che Anna non è venuta sulla terrazza.
Possibile che nemmeno l'inferno in terra sia riuscito a svegliarla?
Entro in sala, tenendo sempre sott'occhio l'orologio, e vado in camera, mi rimane ancora qualche minuto prima di tornare sul terrazzo e godermi il secondo aereo.
Apro la porta senza troppi riguardi: come fa questa troia a dormire ancora?
«Anna!
Non senti che fuori è scoppiato l'inferno?», accendo la luce e il moderno lampadario che pare incastrato sul soffitto illumina al contempo Anna e una realtà insospettata.
«Anna...», mi avvicino al letto, incredulo.
«Che cazzo...», la guardo e vedo la sua abbondante camicia da notte bianca macchiata da una grossa chiazza rossa all'altezza dello stomaco. E nel centro della macchia un pugnale ben piantato.
«Che cazzo...», lo ripeto come se non conoscessi altre parole.
«Anna...», mi piego sulle ginocchia e accucciandomi mi metto all'altezza della sua testa.
«Anna, rispondimi!», guardo il pugnale che le sta ritto dentro allo stomaco e lo riconosco subito, è uno dei miei pugnali da collezione, quelli che tengo custoditi nella teca di legno sistemata ai piedi del letto.
«Ma chi cazzo è stato...», e stringo istintivamente le mie dita sul manico per sfilarlo via dal suo corpo grasso, ma gli occhi sbarrati che guardano fissi quello che non vedono più e il grosso seno che non si alza nemmeno di mezzo millimetro, mi fanno capire che sarebbe un gesto inutile.
«Chi è stato a fotterti così, Anna?», la guardo senza rendermi conto che mi sono appena fottuto anch'io, con le mie stesse mani...
Ho passato la notte accanto a lei, nel nostro letto, come cazzo è possibile che qualcuno le abbia piantato un pugnale nello stomaco?
«Cazzo!».
Mi alzo di scatto e mi rendo conto che se sto ancora lì rischio di perdermi l'impatto dell'altro aereo contro la seconda Torre.
Esco dalla camera, sono affannato, vedere l'aereo aprire la prima Torre e subito dopo Anna crepata sul letto sta destabilizzando anche uno come me.
La testa mi gira all'improvviso e tutto diventa un girotondo di pareti e quadri, di divani e mobili e vasi colorati.
Un giramento di testa così violento da non lasciarmi quasi accorgere del dolore che l'ha preceduto.
Il dolore di una botta.
![]()
DUE ANNI DOPO
«Forza, entra dentro!», la cesta rettangolare è stretta e bassa, ma riesco lo stesso a nascondermi sotto i panni e a infilarmi nel sacco di juta lasciato apposta per me.
Sento il carrello andare per i corridoi, fermandosi davanti ogni porta.
«Bella giornata, vero?».
«Giornata di merda, come tutte qui dentro», sento il sibilo di un portellone che si apre elettricamente.
«Arrivederci, capo».
«Vaffanculo, lavandaio...».
Sento l'aria sopra di me e la respiro tutta, immagino che stiamo attraversando l'ampio piazzale dove ho passato ogni schifoso pomeriggio da quando sono entrato qui.
Sento togliere da sopra i panni puzzolenti che mi hanno riparato finora e finalmente viene preso anche il mio sacco, con me dentro.
«Uno!
Due!
E tre!», vengo scaraventato dentro il furgone e bestemmio mentre picchio la schiena sul pavimento, ma in fondo sono un sacco... non posso aspettarmi riguardi particolari davanti all'ultima guardia.
Perché diavolo non si muove questo cazzo di furgone?
Poi si scuote d'improvviso, chi è al posto di guida ha acceso il motore.
Finalmente ci muoviamo, ma così lentamente che mi pare debbano trascorrere altri due anni prima che il furgone riesca ad uscire dal carcere e ad imboccare la strada.
Dopo qualche chilometro il furgone rallenta per poi fermarsi e subito il portellone si apre rumoroso, mentre io aspetto già in piedi.
«Fattah! Fratello mio!», è Aban, il mio fedele amico.
«Fatti abbracciare, Aban», lo stringo a me, se lo merita. Ha fatto un buon lavoro.
«Vieni anche tu, Hafez», faccio cenno al secondo uomo e lo abbraccio allo stesso modo, anche lui ha fatto un buon lavoro.
«Saprò come ricompensarvi», abbraccio un'altra volta tutti e due e salgo su una vecchia Ford che mi aspetta parcheggiata all'angolo della strada.
«Tutto a posto», faccio subito una chiamata con il cellulare, che come da indicazioni ho trovato nel cruscotto.
Stasera saprò chi mi ha fregato, schiaccio sull'acceleratore immaginandomi di schiacciare quel verme senza nome che mi ha fottuto.
Senza nome, ma solamente fino a stasera.
![]()
Mi trovo al Guggenheim Museum e l'ora stabilita scatterà alle 22.00, sono in anticipo di venti minuti quando entro nella struttura.
Questa sera il museo è aperto eccezionalmente oltre il consueto orario, per un’esposizione altrettanto eccezionale di un fottuto artista europeo.
Mi guardo nel primo specchio che mi trovo davanti e faccio fatica a riconoscermi: del bel David è rimasto ben poco, ma è meglio che la mia vecchia faccia non si mostri troppo in giro.
Salgo la rampa a spirale per arrivare al piano giusto, quello dell'incontro.
Sono appoggiato al davanzale del secondo piano, quando vedo che il mio contatto sta salendo a sua volta lungo la spirale, riconosco subito la sua silhouette, nonostante siano passati diversi anni dall'ultima volta che l'ho vista.
«Ciao, Layla».
Si gira verso di me, incerta.
«Non è facile riconoscermi, vero?», ho fatto davvero un buon lavoro.
«Sono io, Fattah...».
Lei invece è sempre la stessa, forse un po' appesantita, ma ancora bella.

È Layla Dakmak, quarantotto anni, venti dei quali nei servizi deviati, e da dieci preziosissimo e insostituibile Jolly della nostra organizzazione: non c'è niente che lei non sappia, e spesso lo sa in anticipo su tutti.
È lei che ha pianificato la mia evasione.
«Fattah... non avrei mai potuto riconoscerti», mi guarda come a cercare conferme.
«Ma ti ho riconosciuto io.
Sei sempre maledettamente bella», dimentico apposta di dirle che è ingrassata, alle donne vanno ricordati solo i complimenti.
«Ti ringrazio, Fattah...», è lusingata e pare quasi che possa arrossire, ma non lo fa, una donna come lei non può permetterselo.
Sì, Layla, sei sempre bella, forse il massimo che possa vedere un uomo; sei senza età, senza epoca.
«Dimmi chi mi ha fottuto», mi giro verso un quadro fingendo di guardarlo, il tempo per i complimenti è finito.
«Vuoi davvero saperlo?».
«Che cazzo stai dicendo, Layla?», stringo la mascella. «Mi sono fatto due anni di galera.
E questo è stato il male minore.
Per saperlo sono qui a rischiare la pelle».
«Allora ti accontento», mi guarda da puttana.
«Parla, cazzo...».
Un momento di silenzio che non finisce mai, poi finalmente si decide.
«È stata tua moglie a fregarti», lo dice tutto d'un fiato, come fosse una sola, unica e fottuta parola.
Sorrido involontario, di riflesso, come quando da bambini il dottore tira il suo martelletto contro il ginocchio, facendo alzare da sé la gamba.
«Layla...
Sei venuta qui a rischiare il tuo culo solamente per dirmi cazzate?!», la guardo deciso e cattivo, il sorriso mi è sparito.
«Fattah...», mi mette una mano sul braccio. «È stata la tua Anna a fregarti», insiste e il suo sguardo mi sembra maledettamente sincero. «Sediamoci là», mi indica con il capo un tavolinetto chiaro sistemato a un paio di metri da noi.
Sediamoci, Kelly, voglio sentire fin dove riesci ad arrivare con le tue cazzate.
«Riesci ad ascoltarmi, Fattah?».
«Parla», penso di star perdendo tempo e questo mi fa diventare nervoso e cattivo, vorrei tirare fuori la pistola e piantarle subito un paio di pallottole in pancia da sotto il tavolino, e farla finita un volta per tutte con questa vecchia cessa, ma mi trattengo.
«Ricordi la mattina in cui hai trovato Anna morta sul letto con il pugnale piantato nello stomaco?».
«Layla... finiscila di prendermi per il culo o giuro che ti ammazzo qui davanti a tutti».
«Quella che trovasti morta sul letto non era tua moglie», va avanti spedita, per niente intimorita dalla mia minaccia; forse sa che non mi disferei di lei.
«Era Rebecca, la gemella di tua moglie».
La guardo e mi sento le pupille fisse e inespressive di uno squalo appena infilato da dieci arpioni.
«Vai avanti», sono impaziente di ascoltare il seguito della favola.
«Però non interrompermi».
«Vai avanti, ti ho detto», e spero per te che la favola abbia un lieto fine.
«Adesso ascoltami.
Quella mattina, mentre stavi aspettando che venisse colpita la prima Torre, Anna ha colpito te.
Approfittando del fatto che eri sulla terrazza, Anna uscì dalla camera e andò ad aprire a due complici, che entrarono nel vostro appartamento trasportando Rebecca già morta.
La piazzarono in camera e dopo averla sdraiata sul letto, Anna, munita di guanti, le piantò il pugnale nello stomaco, un’arma prelevata dalla tua collezione.
Poi aspettarono che rientrassi nell'appartamento e ti colpirono in testa, e volle essere proprio Anna a colpirti. Una volta svenuto sul pavimento, se ne andarono, facendo una telefonata anonima alla polizia e dicendo che nell'appartamento era stato commesso un omicidio».
Cazzo...
«E tu, Fattah, non ti accorgesti di nulla. Ma non fartene una colpa. Sapere che stava per arrivare un Boeing contro la Torre Nord fu un elemento di distrazione più che giustificato.
E Anna ha sempre approfittato delle tue distrazioni».
Cazzo, parola dopo parola la favola comincia ad appassionarmi.
«Quella poveretta, Rebecca, l'avevano strangolata qualche ora prima.
E una volta arrivata la salma all'obitorio, per Anna non fu certo difficile mischiare le carte e nascondere la vera causa del decesso.
L'organizzazione ha uomini dovunque e il Coroner non fa certo eccezione».
Layla fa volutamente una pausa, capisce che deve rallentare il racconto per darmi il tempo di metabolizzarlo.
Per un attimo rivedo quel corpo sdraiato sul letto, con il mio maledetto pugnale da collezione in pancia.
«Perché Anna avrebbe fatto tutto questo?», visto che Layla ha aperto il Vaso di Pandora, voglio che faccia uscire tutto il male che c'è dentro.
«Per prendere il tuo posto.
Anna, a tua insaputa, ha sempre fatto parte dell'organizzazione.
Per la società era Anna Coen, figlia dell'ambasciatore israeliano e attivissima promotrice di eventi benefici in aiuto del disgraziato di turno».
Maledetta troia.
«Te l'ho detto, Fattah, ha sempre approfittato delle tue troppe distrazioni.
Sapeva degli attentati dell'undici settembre e sapeva che dopo quella data il mondo sarebbe cambiato.
E sapeva che quello era il momento giusto per fare il salto di qualità e prendere il tuo posto all'interno dell'organizzazione».
Mi sento arrossire il viso, il sangue mi arriva fino alla testa e devo allentare il nodo della cravatta, sto iniziando a sudare di rabbia.
«Anna, dopo l'omicidio, è diventata Rebecca Coen, ma solamente per la società».
«Mentre è rimasta Anna Coen all'interno dell'organizzazione, prendendo il mio posto», la riga finale della favola voglio leggerla io.
«Mi credi, dunque, adesso?».
«Ho altre scelte?».
«Non si hanno mai altre scelte davanti alla verità».
Ho voglia di fumarmi una sigaretta, ma qui non si può.
«Adesso cosa farai?», mi guarda preoccupata.
«Adesso farò che bisogna andare via da qui.
E alla svelta».
«Cosa significa, Fattah?», il suo sguardo ora è preoccupato anche per sé stessa.
«Non voltarti, dietro di te ho riconosciuto due tirapiedi dell'organizzazione.
Come cazzo hanno fatto quei bastardi a trovarmi subito e a riconoscermi?».
«Non ti hanno riconosciuto», Layla prende la borsetta appoggiata sul tavolo e se la infila in spalla. «Loro hanno seguito me.
Non sono stata abbastanza attenta».
«Alziamoci e avviamoci verso l'uscita. Con calma», mi stacco dalla sedia e le porgo la mano.
Scendiamo lungo la spirale dell’edificio e dopo aver percorso l'ampio ingresso ci ritroviamo fuori, con i due uomini dietro ad allungarci le ombre.
«Hai una pistola, Layla?».
«Certo. Nella borsetta».
«Stai pronta a tirarla fuori, allora», mi guarda senza spaventarsi, è addestrata per situazioni come questa e se necessario sa anche come si fa ad uccidere.
È venuta al museo in taxi e la mia macchina è parcheggiata a circa 100 metri, troppi se i due decidono di entrare in azione.
Mi volto facendo finta di chiamare un taxi e vedendo che infilano le mani sotto i cappotti, capisco che non ci rimane più neanche mezzo metro di tempo...
«Tira fuori la pistola, Layla!».
BANG
BANG
BANG
BANG
I colpi vengono esplosi da tutti e tutti insieme, quasi ci fossimo mortalmente sincronizzati.
«Ahhh!», quello più alto è già fottuto, una palla in pancia e l'altra sotto la gola.
BANG
BANG
«Uhhh...», il gemito stavolta è più vicino a me e troppo maledettamente femminile.
«Sono stata colpita... ohhh...», Layla si appoggia con la schiena al muro, portandosi entrambe le mani sullo stomaco.
«Maledetto bastardo!», gli scarico addosso tutti i colpi che mi rimangono, mandandolo subito al Creatore.
«Layla...», le sono subito accanto.
«Sono... fottuta... ohhh...».
«Fammi vedere», le sposto le mani e vedendo i due buchi che le pallottole le hanno lasciato sul trench nero, capisco che è messa molto male.
«Vattene… Fattah... fra poco… qui... uhhh... sarà pieno… di sbirri...», si rimette una mano a tapparsi le ferite, mentre mi mette l'altra sul braccio.
«Non... preoccuparti… per me... ohhh... finché… rimango… in piedi… non... non crepo...», mi guarda riuscendo a sorridere. «Non ho... uhhh... mai visto... morire… qualcuno… ahhh... in piedi...», piega la testa all'indietro, adesso è completamente appoggiata al muro, come a puntellarsi disperatamente alla vita.
Forse hai ragione, Layla, nemmeno io ho mai visto qualcuno morire in piedi.
Ma c'è sempre una prima volta...
UEEEE
UEEEE
Le sirene di almeno un paio di auto della polizia stanno già entrandomi fastidiose nelle orecchie.
«Prendi questo... uhhh...», mette una mano nella borsetta rimasta infilata nella spalla e la ritira fuori con un biglietto stretto fra le dita. «Fermala... uhhh... prima che... ohhh... sia troppo tardi...
Vai...», con una forza inaspettata riesce a spingermi indietro.
«Layla...».
«Vai... maledizione... ohhh...», quasi mi implora.
Corro verso la macchina e prima di salire guardo per l'ultima volta dietro di me, la polizia è arrivata e il rosso lampeggia in tutta la zona.
E lei è sempre maledettamente in piedi, con le mani occupate a premere sullo stomaco, non si appiglia a niente, forse i muscoli dell'addome perforati dalle due pallottole si sono irrigiditi al punto da aiutarla a restare in tensione.
Solo Layla può permettersi di rimanere ritta e fiera, nonostante sia ferita a morte.
Gran peccato non rivederla più... si era fatta vecchia, ma non abbastanza da lasciare indifferenti.
Parto con la mia Ford e mi immetto nell'Avenue evitando stridii di gomme.
Percorro un paio di isolati e mi fermo in un raro tratto di strada rimasto immune al neon dei locali, pochi metri di penombra che mi sono sufficienti per leggere il biglietto che mi ha passato Layla.
Dott. John Lesmond, #129, 142a Strada, Harlem River.
Lo giro sul retro e sullo sfondo bianco, macchiato dal sangue della libanese, c'è scritto qualcos'altro, a penna.
Lui sa dove si trova Anna...
È la calligrafia di Layla, la riconoscerei fra mille.
142a Strada, Harlem River... prendo dal vano portaoggetti una manciata di pallottole e comincio a metterle una dopo l'altra nella pistola, ricaricando il tamburo che ho appena svuotato addosso ai due bastardi che hanno fottuto Layla.
La caccia è aperta, vecchia troia.
![]()
DUE GIORNI DOPO
Ho appena fermato la Ford sulla 142a Strada, di fronte a me una palazzina grigia di sei piani e al secondo c'è lo studio del Dottor Lesmond, specialista in malattie cardiovascolari, così c'è scritto sulla targa attaccata alla porta.
Click, la porta scatta mentre ho ancora il dito sul campanello, è una di quelle che si aprono automaticamente, entro e mi ritrovo in un corto corridoio con le tipiche pareti bianche di uno studio medico con appesi diplomi e attestati.
In fondo un'altra porta.
«Salve...», esce quella che dovrebbe essere l'assistente del Dottor Lesmond.
Cazzo...
«Ha un appuntamento con il Dottore?», mi guarda e abbassa subito gli occhi sull'agenda per controllare.
Preferirei averlo con te l'appuntamento...
Sui 50/55, grassa, morbida, gonfia; molto matura, ma ancora promettente, ancora in tiro; questa tipa è da prendere sul serio.
Le tette sono contenute a stento in un ristretto camice bianco, che lascia intravedere almeno una quinta di seno e la sua inclinazione a fare la mignotta.
«Purtroppo non ho nessun appuntamento», la deludo subito. «Ho solo bisogno di fare qualche domanda al Dottor Lesmond».
«Domande di che tipo?», la solerte assistente si insospettisce subito, neanche fosse una sbirra.
«Domande».
«Prima deve prendere un appuntamento», è una dura, benché molto morbida.
«Basta questa per prenderlo?
Adesso».
Le metto la pistola davanti alle tette.
«Ma... cosa...?», si ammorbidisce subito, ritrovando la sua vera natura.
«Se fai la brava non ti succederà niente.
Dov'è il Dottore?».
«Sta arrivando...», fa un cenno verso la porta d'ingresso che si sta aprendo.
«Benarrivato, Dottor Lesmond...», anche se con la pistola lo saluto subito, sono un tipo educato io.
«Romina... cosa sta succedendo...?».
«Non so chi sia, Dottore... è appena entrato puntandomi contro la pistola».
«L'avverto, se cerca soldi, qui non troverà nemmeno un dollaro», il Dottore sa come mantenere il sangue freddo.
«Non cerco soldi», lo rassicuro. «Cerco un'informazione.
Entri nello studio», gli indico la strada con la canna della pistola. «Anche tu, Romina...».
Appena dentro, lo faccio sedere al suo posto.
«Guardi questo, Dottore», gli butto sulla scrivania il biglietto che mi ha dato Layla. «Allora... dov'è Anna Coen?».
«Ma... non so... di c-cosa parla...», il balbettio insieme al sudore improvviso non si addicono alla risposta.
«Non ho tempo da perdere, Lesmond.
Dov'è Anna? Non glielo ripeterò una terza volta», la pistola mira all'altezza del cuore.
«Buttala, bastardo».
Cazzo...
Un'altra delle mie distrazioni, l'avrebbe chiamata Layla.
«Butta la pistola, cazzo!», Romina è tornata dura.
Adesso ci sono due pistole puntate, una contro il Dottore e l'altra contro la mia schiena.
Rovinare un corpo così morbido...
Uno...
Un po' mi dispiace...
Due...
Ma non ho scelta...
Tre!
BANG
BANG
Mi scaravento a terra e rigirandomi sparo un paio di colpi contro l'assistente.
«Ahhh!!».
BANG
«Ohhh...», si porta entrambe le mani sulle grosse tette e si siede precisa sulla poltrona, senza più essere un problema.
Mi rialzo aggrappandomi alla scrivania e vedo che adesso ho un altro problema e questo di difficile soluzione.
Il Dottore si è beccato in piena fronte la pallottola di risposta della sua assistente, gli tiro su la testa rimasta reclinata sul petto, ma ottengo solamente l'effetto di far colare ancora più sangue lungo il viso.
È andato, il problema adesso da difficile è diventato insolubile.
Il mio unico informatore per arrivare ad Anna è appena crepato, la giornata procede male.
«Uhhh...», l'infermiera però è sempre viva.
Anche se per poco.
«Ohhh… a momenti... mi ammazzi...», le tiro via le mani dal petto e mi accorgo di averle piantato una pallottola per tetta: l'infermiera, molto professionale, allude al proiettile che le ha sfiorato il cuore.
«Te la sei cercata, bellezza...».
«L'importante... ohhh... è che... non mi hai... uhhh... fulminato...», crede ancora di salvarsi. «Io.. ho molti... uhhh... soldi... da parte...», ci credo, con il corpo che ti ritrovavi devi averne fatti di bigliettoni.
«I soldi non mi interessano adesso. Ho bisogno d'altro», è la mia occasione. «Conosci Anna Coen...?», ci provo, magari ho fortuna.
«Non so... uhhh... chi... cazzo… sia... ohhh...», non ce l'ho. «Tienimi... la mano... uhhh...».
Te la tengo, certo, mi dispiace tanto aver rovinato il tuo bel decolleté.
«Ohhh... uhhh… ohhh… uhhh…», alza e abbassa convulsamente le grosse tette e sento che la sua mano si stacca dalla mia andando a penzolare pericolosamente oltre il bracciolo della poltrona.
Cazzo…
Se non è andata, ci manca poco.
Il primo braccio è caduto. Se crolla anche il secondo, è finita.
Gli occhi di Romina guardano inespressivi oltre questa realtà, la mascella è serrata come a trattenere un conato di vomito, con il sangue che le sfugge ai lati della bocca.
Dopo la sua mano quasi morta, capisco che adesso devo stringere la cornetta del telefono.
«Mandate con la massima urgenza un'ambulanza al #129 della 142a, studio del Dottor John Lesmond.
Tieni duro, Romina, sta arrivando l'ambulanza», spararti due palle nel petto era l'ultima cosa che avrei voluto farti...
«Mi bruciano… ohhh… da… morire... uhhh...», si guarda nell'ampia scollatura con una smorfia di dolore e scuote lievemente il capo. È ancora perfettamente lucida. «Però... non mi hai... ahhh... fulminato...», magra consolazione, Romina. Avresti fatto prima.
La lascio lì seduta a guardarsi le tette, sempre più immobili. Se si alzano, si alzano ancora di uno o due millimetri.
Sto per uscire nel corridoio, ma mi sento chiamare.
«Aspetta... ahhh... aiutami...», la voce dell'infermiera è carica di disperazione; intuisce che è finita, ma vuole trascinarsi a tutti i costi.
Sono costretto... a rimanere.
«Le senti le sirene? L'ambulanza sta già arrivando...».
Ma non è vero.
«Io devo andare, tu provaci...», se l’attaccano subito a un respiratore, forse può trascinarsi in ospedale e crepare lì, avendo tempo di rassegnarsi.
È già segnata, ma ho una certa passione per chi lotta contro il proprio destino.
È
solo una schifosa puttana, ma è tosta e sta tentando di prolungarsi la vita:
scommetto che sta tirando fuori il meglio di sé proprio adesso che deve crepare.
È per questo che mi ritrovo a seguirne con ansia gli ultimi respiri.
Arrivare all’ospedale sarà un bel problema, ma almeno deve partire a sirene
spiegate.
Se la caricassero cadavere, sarebbe una delusione.
«Addio, Romina… magari ci rivediamo quando ti rimetti in forma...».
Annuisce con la morte in faccia, è dura a slegarsi.
Esco nel corridoio, ma prima di arrivare alla porta d’ingresso, mi fermo al tavolinetto dove sono sistemate le riviste e l'occhio mi cade sul New York Times.
Sparatoria davanti al Guggenheim Museum... due uomini morti... una donna in fin di vita...
Mi accorgo solamente adesso di essere rimasto isolato dal mondo per due giorni.
La donna è stata ricoverata al Queens Hospital... indotta in coma farmacologico...
Layla...
Allora sei sempre in piedi!
Maledetta puttana... non riesco a trattenere un sorriso.
Non mi rimane che farmelo dire direttamente da lei dove sia Anna…
Sei la mia unica possibilità, Layla, continua a restare in piedi almeno finché non arrivo.
A questo punto, senza farmi vedere, controllo se è finita.
«Mmh… erghh… mmmhh…», quasi.
Romina sta raschiando il fondo del barile.
È una cagna che non vuole uscire di scena. Io invece sì.
Mi ritrovo in strada e stavolta le sirene le sento davvero.
Forse le senti anche tu, bellezza: l'ambulanza sta arrivando sul serio.
![]()
«Entro da sola.
Tu resta nei corridoi e tieni gli occhi bene aperti».
La donna entra dentro la stanza 119, mentre l'uomo inizia a trascinarsi per i lunghi corridoi che puzzano di disinfettanti ospedalieri.
![]()
«Mi scusi, un'informazione», mi fermo alla reception del Queens Hospital. «Vorrei sapere il numero di stanza dov'è ricoverata la signora Dakmak.
Layla Dakmak...».
La giovane infermiera mi guarda da sotto gli occhiali.
«È un parente?».
«Sono un caro amico».
Prende il registro e comincia a far scorrere il dito sulla pagina, fino a fermarlo sul nome di Layla.
«Mi dispiace, le condizioni della paziente non le consentono di ricevere visite».
«Voglio solo vederla.
Entro nella stanza e me ne vado subito», modero la voce, usando il tono più remissivo che conosca.
«Mi dispiace, ma non posso contravvenire alle disposizioni».
Mi infilo una mano nella tasca della giacca e le metto cento dollari sopra il bancone.
«Entro ed esco.
Promesso», copro i cento dollari con altri cento, non è il momento di badare a spese.
«Stanza 119», allunga la mano e fa sparire immediatamente i bigliettoni.
«Faccia attenzione a non farsi vedere.
Io non le ho detto nulla».
![]()
Stanza 119, spingo la porta ed entro, la penombra della camera mi consente di notare una figura in piedi accanto al letto, senza però farmela distinguere.
Pigio l'interruttore, c'è bisogno di più luce per vedere e capire bene.
«David...
Sapevo che saresti venuto anche tu...», la voce femminile gioca d'anticipo, approfittando del mio smarrimento.
«Anna...?!», dopo due anni me la ritrovo davanti, viva e più che vegeta. «Maledetta troia bastarda...», sono i primi scontati complimenti che qualunque gentiluomo al mio posto le rivolgerebbe. «Mi hai fregato proprio bene», glielo riconosco subito.
«Era solamente arrivato il momento di fotterti».
È ingrassata ancora e l'enorme seno buttato quasi fuori dalla maglietta rossa non lascia nessun dubbio: è sempre Anna Coen, il più grosso troione che avrei mai potuto sposare.
«Niente di personale, David», anche lo sguardo è sempre da puttana.
«Che cazzo ci fai qui?», vado dritto al presente, ci sarà tempo per fare i conti col passato.
«Mi accerto che la nostra cara amica finisca di soffrire», solamente adesso mi accorgo che ha una siringa in mano. «Considerami una specie di angelo della morte. Gli ospedali ultimamente ne sono pieni, li leggi i giornali?», mette in verticale la siringa e spruzza via un po' di liquido.
«Fermati, maledetta!», faccio per prendere la pistola dalla tasca della giacca, ma mi fermo prima.
«Fossi in te non lo farei», la voce mi arriva da dietro. «Tocca la pistola e sei morto».
Oggi è la seconda volta che mi faccio sorprendere da una pistola alle spalle, forse sto invecchiando.
Lascio cadere il revolver sul pavimento e come da istruzioni mi giro lentamente, e con delusione vedo che a puntarmi una pistola questa volta non c'è nessuna tettona...
«Aziz... anche tu qui...», al posto della faccia da troia di Romina c'è la brutta grinta di un membro della Forza Quds, un fedelissimo del regime iraniano.
E anche di Anna, a quanto pare...
«Sei molto peggiorata nei gusti, Anna...», Aziz è un mezzo uomo sessantenne, storpiato dalla nascita dalla poliomelite.
«Zitto, bastardo!», lo storpio trova energia nella pistola stretta in mano, che riesce anche nel mezzo miracolo di raddrizzarlo in una postura quasi umana. «Lo ammazzo?», ha fretta.
«Al tempo, Aziz», Anna non mette ancora il suo pollicione a testa in giù.
«Ohhh...», Layla lancia un gemito improvviso, quasi un S.O.S.
«Che cazzo fa quella troia? Si sta svegliando?», Aziz si rivolge ad Anna, distogliendo per un attimo l'attenzione rivolta su di me.
«Stai calmo, idiota.
Si sta solo lamentando», Anna la guarda, abbassando gli occhi su di lei.
Devo agire subito.
Adesso!
Con un salto sono subito addosso ad Aziz e buttarlo in terra con me sopra non è difficile.
«Ammazzalo, Aziz!», il pollicione di Anna cambia immediatamente posizione.
Lo storpio si difende bene, si vede che è stato addestrato a dovere dai servizi segreti iraniani.
PFTT
PFTT
«Ahhh!», dalla pistola partono un paio di colpi silenziosi ed entrambi vanno al bersaglio grosso...
È ora di finirla, storpio maledetto...
Riesco a piegargli la mano verso il suo stesso petto.
PFTT
PFTT
PFTT
«Uhhh...», l'iraniano è fatto.
«Ohhh... cazzo...», Anna è seduta sulla sedia accanto al letto di Layla, le mani unite sullo stomaco. «Idiota... sapevo… che avresti fatto… qualche cazzata... uhhh...», ma Aziz non può più giustificarsi, è rimasto steso sul pavimento, a pancia in su, con gli occhi sbarrati che guardano il nulla.
Mi avvicino a lei e le sposto un ciuffo di capelli che un sudore mortale le ha già appiccicato sulla fronte.
«Fai vedere...
Sei fottuta, Anna…».
«Portami via… da qui... uhhh...».
«È meglio se rimani qui, se vuoi avere anche una sola possibilità di cavartela».
«No... portami… a casa nostra... ohhh...», mi butta tutte e due le braccia al collo, ignorando per un momento i buchi che si ritrova nello stomaco. «Le chiavi… dell'appartamento… uhhh… sono... nella borsa... ohhh...». È pazza, lo è sempre stata. «Non lasciarmi qui... David...», esco dalla stanza e guardo se vicino alla parete del corridoio c'è ancora la sedia a rotelle che avevo visto prima di entrare.
È sempre lì, la prendo e rientro nella camera.
Sono pazzo, lo sono sempre stato.
«Vieni... siediti qui», la prendo sotto le braccia e la tiro su a fatica.
«Ohhh... piano... mi fa male...», è impossibile mettere una donna grossa come lei sopra una sedia a rotelle senza farle del male, soprattutto se si ritrova due pallottole nello stomaco.
Intanto Layla muove leggermente le dita della mano, come volesse farmi capire che se la caverà anche questa volta.
Quando tornerò, ti ritroverò di nuovo in piedi, dannata puttana...
Metto una coperta sopra ad Anna, a nasconderle le ferite, ed esco spingendo la sedia a rotelle fino alla porta del primo ascensore.
«Cerca di non lamentarti troppo».
«Ci proverò...», e facendo una smorfia inclina il capo su di un lato.
Riesco ad arrivare all'uscita dell'ospedale senza problemi e dopo aver sistemato Anna sul sedile della Ford, lascio la carrozzina insanguinata sul marciapiede, andando via il più velocemente possibile dal parcheggio del Queens Hospital.
«Fai presto... ohhh... sto crepando...», giro la chiave nella toppa dell'appartamento ed entro con lei attaccata a me, è la prima volta che ritorno qui dall'undici settembre.
La porto in camera e la sdraio sul letto, tutto è rimasto uguale a due anni fa.
«Se ti lasciavo all'ospedale, potevi avere una possibilità di cavartela», la guardo crepare, sentendomi un po' in colpa per non averlo fatto.
Se ripenso alla fatica di Romina per cercare di farsi trovare viva all’appuntamento con l’ambulanza…
«Adesso… scopami... David... ohhh…».
Decido di assecondarla e appena le tiro via la tuta elastica, lei d'istinto allarga subito le grasse cosce.
«Ohhh... ohhh…», vado su e giù una decina di volte, stringendole con entrambe le mani l'enorme seno tutto sudato.
«Ohhh... ohhhh… oh...h...h...h...».
Le tette adesso non si alzano e non si abbassano più, sono rimaste afflosciate lungo il corpo, fin quasi a ricoprirle i buchi sullo stomaco.
La scuoto, ma non ce la fa più.
«Anna...».
Forse respira ancora, non lo so, non mi va neanche di saperlo.
Alzo la cornetta del telefono e digito tre cifre.
9, 1, 1.
«Chiamo dalla Lower Manhattan... venite all'appartamento 182...
Troverete un cadavere... o qualcosa di molto simile... le macerie di una troia...».
Esco dal palazzo e respiro l'aria di New York, fatta di smog e di complotti, pensando che mentre le Torri Gemelle sono crollate a mezz'ora di distanza l'una dall'altra, le Gemelle Coen ci hanno messo due anni prima di crollare entrambe.
Spie, doppiogiochiste, e soprattutto troie.
Sì, erano proprio le Troie Gemelle...
![]()
Adesso che mi sono tolto diversi pensieri, voglio sapere se l'infermiera tettona è morta nel suo studio, sull'ambulanza, o all'ospedale.
In fondo, io le sono entrato nei polmoni, lei nel cuore.
Con una puttana del genere mi sarei messo a posto. Peccato. Mi sarei messo al sicuro. Peccato davvero.
«Romina Lopez, 54 anni, due colpi d'arma da fuoco: terapia intensiva, giunta all'ospedale in arresto cardiaco».
Lo sapevo: troppo mignotta per crepare facile.
![]()
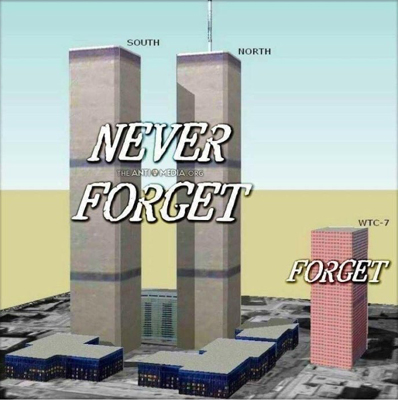 NEVER FORGET
NEVER FORGET
Eh
già…
Figuriamoci se
me la dimentico.
Anna... Layla... d'accordo, belle donne...
Ma la vecchia Romina... con le zinne a borraccia e la sua pazza voglia di vivere...
Arrivata cadavere in ospedale, ma rianimata nel reparto di terapia intensiva...
Venti giorni di coma profondo, dieci per tetta.
Mi sono informato su tutto.
Un lungo tunnel con un'uscita molto stretta.
Forse è per questo che adesso predilige la luce e si fa spingere intorno al lago, che le riflette in faccia i raggi del sole.
La vecchia troia s'è tenuta stretta la pelle.
C'è una certa differenza d'età, ma a me va bene così.
Sarà la mia punta di diamante.
«Mi fanno rientrare nel giro, ad acque calme», ho avuto la conferma.
«Calme quanto?».
«Come quelle di questo laghetto».
«Dopo due botti del genere... come faranno a calmarsi le acque?».
«Tutto si calma, prima o poi.
 Riprenderò
a lavorare e tu mi seguirai sempre», sono proprio ossessionato da questa grossa
puttana.
Riprenderò
a lavorare e tu mi seguirai sempre», sono proprio ossessionato da questa grossa
puttana.
Se continua così, me la sposo.
Tra non molto la carrozzella sarà un lontano ricordo.
Non ci sono danni permanenti.
La bambola peruviana tornerà perfetta.
«Con te vicino diventerò sempre più potente, non è vero?
Nessuno oserà toccarmi...».
«Ti farai toccare solo quando ci farà comodo...
Nessuna è al tuo livello, Romina.
E io di donne ne ho avute tante...».
Certo, se l'è vista brutta. Non ero sicuro che potesse trovare una via scampo. Sarebbe stato uno spreco enorme. Ma non ero riuscito a trattenermi. Quel grosso petto non si rialzava più.
«So quanto valgo, ma ho avuto paura di non farcela...
La disperata voglia di godermi le mie tette... mi ha dato tanta forza in quel momento...».
«Ricordo bene come ti guardavi: non ci stavi a perderle.
E avevi ragione...».
«Nessuno può fottermi, l'ho dimostrato.
Con me sei a posto per sempre».
Ha fottutamente ragione, la gran puttana. Mi fa impazzire.

E sarà presto mia moglie.
Nessuno può fotterla.
Eccetto me.

E per cederla, non bastano sei milioni di dollari...
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
«Adesso voglio vedere in che condizioni sta la Signora...».
«Non sarà un bello spettacolo, contrariamente al solito...
Ammesso che sia ancora viva... però le zinne erano intatte, si possono sempre imbalsamare...».
Alain Velon è in vena di battute macabre.
«Non si scherza su queste cose, mister Velon!».
«Avete ragione, andremo insieme a far visita alla Signora».
![]()
![]()
![]()