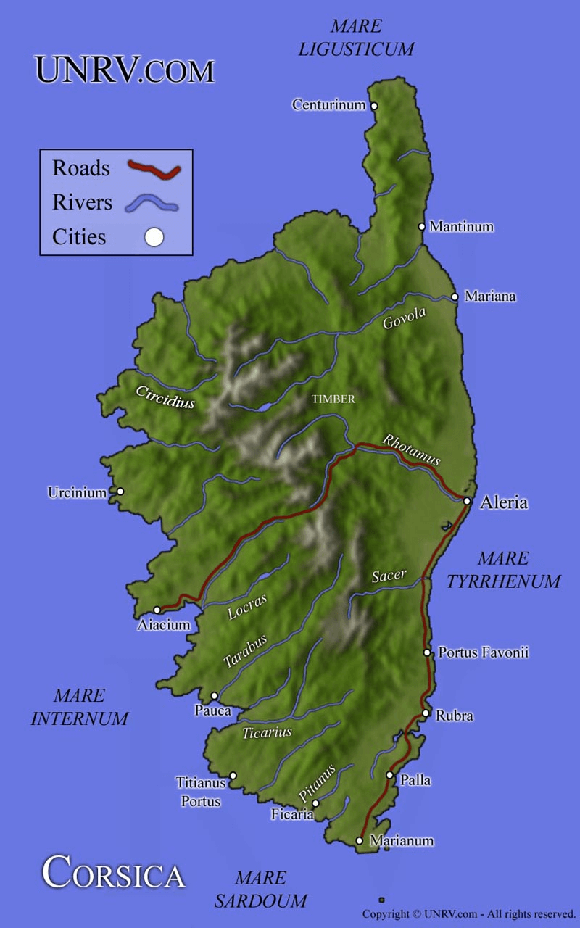![]()
![]()
![]()
Tex: Assalto alla miniera fantasma
La Star di Fregene rimane uccisa
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)

![]()
Aniceto le aveva consegnato la lettera del figlio con cui la invitava a Baia per le Feste di Minerva.
Agrippina sapeva cosa l'aspettava laggiù.


D'altra parte, rifiutare o fuggire non sarebbe servito a niente.
Infatti non sarebbe passata inosservata in nessuna parte dell'Impero.
Anche se il fisico era ormai quello di una cessa - nel linguaggio tipico delle taverne - rimaneva un importante groviglio di carne, e insieme a Messalina e Poppea formava agli occhi dei Romani il Triumvirato delle zoccole imperiali.
D'altronde, la pancia morbida di ciccia era un richiamo irresistibile per qualunque gladio.

Chi avrebbe avuto, nel suo caso, tanto onore?
«Non sono finita, la carne addosso mi sta bene», si diceva allo specchio.
Adesso mostrava tronfia la pineta imperiale di Anzio alla moglie del Senatore Coratus, Gaia Gioiosa, che la esortava ad assumere il potere assoluto e a farla finita con i suoi nemici, più esaltata di Agrippina stessa, ignara del gladio che incombeva sull'Imperatrice.


Ad Agrippina, però, non occorrevano certo le istigazioni dell'amica Gaia: la smania di potere le deformava i lineamenti.

![]()

 Con
la sola compagnia di Gaia Gioiosa, Agrippina raggiunse
il Miseno.
Con
la sola compagnia di Gaia Gioiosa, Agrippina raggiunse
il Miseno.
Nerone era sessualmente pazzo di lei. Non aspettava altro che metterla a pecorina per incularla, stringendole i fianchi burrosi.
Adorava quelle zinne e le spalle da zoccola, morbide e tondeggianti.
Il Principe considerava la madre un'opera suprema degli Dei.
Agrippina si faceva fare di tutto, pur di ammansirlo.
Le impose un bocchino e lei pronta lo prese in bocca.
Poi il figlio passò ad altri giochi.
 Gli
piaceva infilarle dentro qualsiasi cosa, anche oggetti pericolosi... preludio a
tragiche decisioni...
Gli
piaceva infilarle dentro qualsiasi cosa, anche oggetti pericolosi... preludio a
tragiche decisioni...
Dopo il banchetto dedicato a Minerva, Nerone la fece accompagnare via mare alla villa di famiglia, presso il Lago Lucrino.
Un naufragio con il mare piatto: una circostanza davvero insolita, ma per Nerone il teatro non doveva ispirarsi alla realtà. Era creazione libera.
Per questo nella nave si aprì una falla anche se non avvenne alcun urto.
Tuttavia l'imponente imbarcazione affondava lentamente.
Ci fu il tempo di calare le scialuppe e salvare tutti, più che altro dal freddo, visto che la costa era vicina.
«Augusta Signora, per dove dobbiamo remare?»,
chiese lo schiavo.
«Verso il Lago Lucrino».

Agrippina aveva deciso di raggiungere comunque la propria villa.
Nascondersi tra la plebe di Puteoli non le avrebbe giovato: la sua presenza non poteva passare inosservata e qualcuno l'avrebbe tradita.
Tanto valeva contare solo su sé stessa e sul proprio fisico, e rimanere accanto al letto, dove avrebbe ricevuto i suoi assassini e dove sarebbe sprofondata una volta colpita, con l'intento di tenersi a galla, come in quel preciso momento.
Aveva già tutto in testa.
Da lì all'Averno il passaggio sarebbe stato breve.
Infatti il Lago Lucrino era connesso tramite un canale artificiale al Lago Averno.

La figlia di Germanico raggiunse dunque la villa fatta costruire dal nonno Agrippa, il Generale che consegnò l’Impero a Ottaviano Augusto, l’ideatore della base navale di Capo Miseno e di tante altre cose.
![]()
Nerone intanto si vantava presso Seneca e Burro di avergli finalmente dimostrato di poter fare a meno della madre e di non esserne succube.
Infatti Aniceto, preoccupato dell’ira del Principe, lo
aveva informato che la missione era stata eseguita: la madre era morta, sommersa dai flutti,
colata a picco con tutta la nave.
Ma dopo che la vox populi ebbe smentito l'Ammiraglio del Miseno, Nerone rimase
con un palmo di naso, indeciso sul da farsi.
Burro disse che era pericoloso istigare i pretoriani contro gli stessi membri della Casa imperiale, e che - se avesse completato lui l'opera, da solo - sarebbe stato un pessimo esempio per loro.
Alla fine fu scelto un gruppetto di pretoriani liberi dal servizio, che avrebbero agito di loro iniziativa, per zelo nei confronti dello Stato, prescrivendo il suicidio alla cospiratrice.
![]()
Agrippina, intanto, toccandosi le zinne grasse e il ventre molle, ritrovò l'innata sicurezza.
L'Augusta era contenta di sé e si piaceva molto, anche adesso, matura e ingrassata.
Ripensò alle sue scenate con Burro e Seneca: la odiavano, o facevano finta di odiarla, ma piaceva anche a loro.
La toglievano di mezzo controvoglia, per aumentare la presa su Nerone.
L'importante era aspettarli vicina al letto e pronta a tutto.
Se le avessero imposto il suicidio, aveva in mente un trucco.
Nel caso avessero colpito loro, fondamentale era limitare i colpi, crollando subito sul letto.
In ogni caso, non sarebbe rimasta uccisa. Era troppo importante per morire. Non sarebbe finita come una zoccola qualsiasi.
![]()
Agrippina si arrovellava la mente nelle sue stanze, ansiosa di sapere come sarebbe andata a finire. Gaia la confortava, condividendo l'apprensione dell'Imperatrice.
Forse sarebbe stata colpita con un affondo deciso, ma senza l'intento di infierire, da due-tre palmi di gladio, cosi da punirla duramente, però al contempo lasciandole aperta una via di scampo.
Oppure colpita a morte e lasciata dissanguare, con quattro-cinque palmi di gladio in corpo, tra la disperazione dei suoi sodali, lasciandole il tempo di vedere la morte in faccia; oppure ancora, crivellata di colpi e fulminata.
Si immagina mentre trattiene a stento il sangue che le sale in bocca e cerca di mantenere un contegno da Augusta, lucido e austero, con la segreta speranza di non ricevere altri colpi.
Quando i sicari vanno via, si sente eccitata per essere ancora viva.
Agrippina vedeva il suo futuro prossimo. Senza sbagliare. Mancavano solo i dettagli.
«Fai quello che devi fare, ma fallo bene.... senza esagerare...».
![]()
«Che fai...?! M'ammazzi...», ma quello, con gli occhi vitrei di uno squalo, continuava a spingere fino in fondo... o quasi...
Agrippina si lasciò crollare sul letto, secondo il suo piano.
Era entrato parecchio, quasi tutto, ma pensava di non essere finita.
«Abbiamo ordine... di... di non infierire...», balbettò il pretoriano, visibilmente eccitato. «Un solo colpo... la longa manus del Principe... e quella... quella... del popolo romano...», quasi incapace di distogliere lo sguardo dalla grande zoccola imperiale. «Questo è stato deciso da Burro e Seneca... che vogliono sapere cosa farete», riprendendo parzialmente il controllo.
«Ringraziali... e di' loro... che sfrutterò l'occasione...», a pancia in giù, con la faccia schiacciata sul lenzuolo e la bocca deformata dall'agonia, sputando sangue a ogni parola.
«Un attimo...», prima di vederlo andar via, Agrippina richiamò a sé il pretoriano. «Come ti chiami...».
«Valerio».
«Dimmi... se ti piaccio... Valerio...».
«Per me siete la migliore del Triumvirato, ma ho dovuto farlo».
 «Valerio...
toccami le zinne... Caronte mi tira per i piedi... cinque palmi sono tanti... mi hai
sfondato... ma sei un bel ragazzo... ti farò Prefetto...».
«Valerio...
toccami le zinne... Caronte mi tira per i piedi... cinque palmi sono tanti... mi hai
sfondato... ma sei un bel ragazzo... ti farò Prefetto...».
«Risparmiate il fiato, Augusta, ne avrete bisogno».
Detto questo, il pretoriano non ebbe bisogno di farselo ripetere: rovesciò supina l'Imperatrice e le strizzò le zinne, trattenendosi a stento dal lasciarsi andare, quasi impazzito di fronte alla potente zoccola imperiale.
«La longa manus... tua... e del popolo romano...».
Il contro-rituale di Agrippina.
«Fatevi tamponare, non perdete tempo.
Addio».
Non appena i sicari furono usciti, Gaia Gioiosa e gli schiavi si strinsero intorno all'Augusta con ogni sorta di sussidio.
La moglie del Senatore Coratus era molto legata ad Agrippina.

«Ho avuto... un solo colpo... mi lasciano... un po' di tempo... e io... lo userò... per salvarmi... e schiacciarli...», disse ai suoi, sputando sangue. «Chiamate... subito... Apollonio...».
 Era
il sacerdote di Serapide nel tempio di Puteoli.
Era
il sacerdote di Serapide nel tempio di Puteoli.
Pur abile con veleni, pozioni e artifici vari, era soprattutto rinomato per la sua capacità di ottenere dal Dio sospensioni in punto di morte. Ciò che occorreva all'Augusta per riorganizzarsi.
Nonostante la pronta reazione di Agrippina, intorno a lei c'era tanta disperazione.
Il gladio non perdonava, lo sapevano tutti. E nonostante qualche piccolo privilegio, non le avevano lasciato scampo.
Era pazza a non accorgersene?
La fiducia in sé stessa di Agrippina sfiorava l'arroganza.
Ma il gladio piegò in fretta anche una come lei.
Sprazzi di lucidità, alternati alla perdita dei sensi, precedevano la morte.
Apollonio era giunto al suo capezzale e si stava dando da fare, ma senza grandi risultati, a parte gli auspici di sospensione.
Ogni tanto Agrippina si risvegliava, tra un rantolo gutturale e l'altro.
Tutti speravano che la storia andasse avanti a lungo, lei per prima, che li incitava a sperare, dicendosi sicura di poter sfuggire alla morte.
«Il gladio l'ha uccisa, ma riesce a tirare avanti...».
«Sappiamo com'è fatta l'Augusta, vorrebbe lasciare tutti con un palmo di naso e
intanto ci lascia con il fiato sospeso».
Ma due palmi di gladio erano in grado di stroncare anche una come lei.
Ebbe un sussulto di pancia, una mano si levò dalla superficie del letto per ricadere giù dopo pochi attimi...
Agrippina rimase con gli occhi fissi e attoniti, gli altri tutti a guardarla sperando di intravedere uno spasmo, mentre la notizia schizzava impazzita... con l'Augusta che sembrava morta... il gelo che calava sui presenti... e occhi che fissavano occhi fissi... non poteva durare un altro po'?
Era bello vederla trionfare a ogni risveglio... quasi sicura di salvarsi...
Nessuno aveva il coraggio di dire che era morta. Si sperava ancora, con il fiato sospeso.
Forse ci voleva qualcuno che - simbolicamente - le facesse cadere un braccio dal letto, a penzoloni nel vuoto: una brutta immagine, ma eloquente, che avrebbe risvegliato i presenti, i quali - altrimenti - sembravano esserci rimasti secchi, insieme a lei...
«Agrippina...», è il mormorio che le venne rivolto; mani le sfioravano lo stomaco, cercando di portare calore sulla ferita; altre dita le scrutavano il volto, alla ricerca di una reazione ormai impossibile.
Eppure il braccio scattò! Afferrò, mortalmente disperato, il polso dello schiavo! Agrippina si aggrappava!
«Erghh...», dopo aver vomitato un grumo di sangue, l'Augusta non fece uscire una parola, anche un alito più del
necessario poteva costarle la vita.
Perfino intorno a lei non ci furono commenti, come se un bisbiglio di troppo
potesse ucciderla.
Il fiato rimase sospeso: nessuno voleva far cambiare niente.
«Sembra sia tornata un’altra volta...», sussurrò uno schiavo, timidamente.
Rimaneva sempre la mano di qualcuno sulla ferita, a trasmettere calore e
compagnia.
Ora c’era la stessa incredulità di quando la si
vedeva morta.
«Agrippina vuole vivere… non respira nemmeno, per la paura di crepare…».
L’estasi era tale che qualcuno le sborrò accanto, sicuro di interpretare anche gli
umori degli altri. Apollonio raccoglieva e spalmava sul labbro: era liquido
vitale, utile a esaltarla e a compensare l'emorragia.
Respiri soffocati confermavano tutto, la grande zoccola imperiale annaspava nella palude stigia,
con l'acqua fino al collo…
Bocca spalancata e occhi al soffitto, non sembrava averne per molto: l’aspetto e
la sorte non erano cambiati, ma l’esaltazione di vederla viva era tanta intorno
a lei.
Per quanto appariva stecchita prima, adesso sembrava che stesse bene, quasi a posto.
«Il piano... va avanti...», ha ripreso anche a parlare. «Non rimarrò uccisa... non basta... un colpo... per finirmi...».
Agrippina ci provava, anche se la sua fiducia appariva di sicuro eccessiva ai presenti.
Quantomeno era chiaro che l'Augusta avesse la presunzione di beffare il figlio, dimostrandogli di saper reggere l'urto frontale di un gladio, cosa che a lui non sarebbe mai riuscita, e che comunque avrebbe sperimentato presto...
Sono viva,
ci provo.
Noi tre...
il Triumvirato
più potente...
Vi aspetto, ancora calda...
Anche se sarà buio,
io vi sentirò...
l'Augusta
Dettata la lettera, Agrippina si richiuse in sé stessa, con i freni tirati al massimo, stretta nella sua feroce determinazione - se non di salvarsi - almeno di tirare avanti il più possibile, anche con lo stomaco diviso in due.
Guardava fisso in alto e sembrava non respirare.
Ma ormai tutti avevano capito il piano dell'Augusta.

Agrippina li provocava fino all'ultimo, anche in fin di vita.
Voleva evitare altro ferro, beffare il figlio, e ottenere la sua fetta di potere: tutto questo se riusciva a tirare avanti e a prendere per il pisello Seneca e Burro.
 «Non possono resistermi... con le mie zinne... io torno al potere...», ma il sangue che sputacchiava in giro la smentiva subito.
«Non possono resistermi... con le mie zinne... io torno al potere...», ma il sangue che sputacchiava in giro la smentiva subito.
Forse voleva soltanto che il figlio prendesse la cosa come uno di quei folli giochi che lo divertivano tanto, di modo che non le inviasse contro altri sicari.
La verità, tuttavia, era al momento tenuta nascosta al Principe.
Per Seneca e Burro, Agrippina aveva pagato abbastanza: stava a lei giocarsela con il destino.
La lettera, peraltro, non mancò di suggestionarli: tremavano al pensiero che fosse ancora viva e vagheggiasse giochi di potere, invitandoli ad abbracciare la sua potenza.
Certo, sapevano che la sua sorte poteva cambiare nel giro di un attimo, lei stessa lo diceva nella lettera: "Anche se sarà buio, io vi sentirò...", in un passaggio di buon talento letterario; li invitava a scoparla, anche se agonizzante, priva di sensi o morta...
 Agrippina voleva la vita e il potere, le due cose
per lei erano
intrinsecamente legate. Cercava ancora - anche in limine mortis - di far pesare
l'arrogante perfezione che incarnava ed esibiva.
Agrippina voleva la vita e il potere, le due cose
per lei erano
intrinsecamente legate. Cercava ancora - anche in limine mortis - di far pesare
l'arrogante perfezione che incarnava ed esibiva.
Seneca e Burro erano già a cazzo duro, e boccheggiavano come la stessa Agrippina in quel momento, ma di certo per altra causa.
La sborra rese quasi illeggibile il papiro.
Avevano passato le ultime ore nel timore di ricevere la clamorosa notizia dalle loro spie.
Erano stati gelati dalla notizia della morte; erano rimasti increduli; poi era subentrato il timore che la smentita fosse infondata.
Chiedevano continui aggiornamenti, nella speranza che - nel frattempo - Agrippina non si facesse sorprendere.
Quando perdeva i sensi, rimanevano attoniti, anche loro tramortiti.
Se Agrippina riprendeva a parlare, Burro andava subito a farsi una sborrata, come se la vedesse agonizzare davanti a sé.
Nella morte, l'immagine di Agrippina si gonfiava sempre di più... e l'idea di beffarne il figlio si faceva sempre più allettante... tutto dipendeva da quei due maledetti palmi di gladio affondati nella pancia dell'Augusta... Agrippina stava colando a picco... questa era l'amara verità che faceva gelare Seneca e Burro...
Potevano solo sperare che la sua voglia di tornare al tavolo del potere le desse la spinta necessaria per sfuggire alla morte, anche se continuavano ad arrivare notizie preoccupanti: Agrippina aveva le zinne sempre più sgonfie.
L'Augusta stava prendendo tempo, in questo era stata brava, ma per il resto Seneca e Burro scuotevano la testa.
![]()
Come se non bastasse, Nerone voleva vedere il corpo della madre.
Gli era stato raccontato da Seneca, forse con un eccesso di vena letteraria, che la madre aveva accettato il suicidio come unica riparazione del suo crimine e - preso un cuscino per non vedere da vicino l'arma - si era fatta dare un pugio; quindi si era piegata sul ferro, ma senza la necessaria forza; perciò una guardia l'aveva spinta da dietro, finché la punta del pugio non le era spuntata dalla schiena, uccidendola.
«Mia madre è troppo grassa per essere trapassata da un pugio...
E poi il cuscino crea spessore: è evidente che intendeva salvarsi attraverso questo stratagemma! Io la conosco!»; purtroppo per Seneca, Nerone era un critico attento delle sceneggiature altrui, sebbene molto indulgente verso le proprie.
Seneca dovette aggiungere che la violenta e reiterata spinta da dietro della possente guardia, le aveva compresso l'addome, consentendo al pugio di fuoriuscire dalla schiena, dopo aver completamente sezionato il cuscino.
Messa così, funzionava un po' meglio.
Nerone apprezzò la storia e per il momento troncò il discorso; ma, successivamente, volle sapere che ne era stato del corpo e quanto c'aveva messo a morire... e quali erano state le sue ultime parole...
«Nessuna, è morta sul colpo, mio Principe. Il cadavere è stato cremato subito, per evitare scandalose adulazioni»; Burro aveva raccolto tutto il suo coraggio e aveva dato una mano a Seneca: quando c'è poco da dire, è meglio che a parlare sia il meno eloquente.
«Le zinne... nel momento di morire... non ha provato a usarle, quella zoccola?».
Dopo un rapido cenno d'intesa con Burro, era stato Seneca a chiudere il discorso: «Infatti è morta come ha vissuto, cercando di suggestionare le guardie. Ma il ferro se l'è preso tutto, fino in fondo...», con un doppio senso, non troppo velato, che era sicuro avrebbe eccitato Nerone. «Ed è rimasta uccisa, suo malgrado, e malgrado le zinne da mignottona».
«Che linguaggio! Era mia madre! La madre del Principe!
Però...», attimi di sospensione, «bravi...», un accenno d'applauso, come a teatro, e lo sguardo fisso, prima di ritirarsi con i suoi liberti.
Forse, nella sua lucida follia, il Principe era quello che più di tutti credeva nella madre e nella sua rara capacità di adattarsi a ogni situazione.
![]()
Tornato dai suoi ministri, annunciò la sua ispirazione: «Può anche darsi che io scriva un dramma per raccontare la morte di mia madre ai Romani...
Aggiungerò qualche dettaglio, spero nessuno ne rimanga offeso...
Ho già qualche parola in mente...
Tu! Scrivi... finché Calliope non mi secca il labbro...».
 Mentre moriva, rimpiangeva che il Sommo Figlio
non fosse lì a vederla, ansante per l'ultima volta.
Mentre moriva, rimpiangeva che il Sommo Figlio
non fosse lì a vederla, ansante per l'ultima volta.
Il trucco del cuscino non era riuscito. Ora cosa avrebbe inventato?
Il ferro le era finito dietro la schiena, benché non fosse certo magra.
Poiché nessuno aveva il permesso di soccorrerla, non le rimaneva che provocare le guardie del Principe, mandando il grosso culo molto in fuori.
La paura era tanta, d'altronde lei stessa si era data la morte, spingendo il ferro molto in fondo: chi poteva incolpare di questo?
Perciò accadde qualcosa di orribile, che colpì molto i presenti (guardie, amanti, schiavi e squallidi curiosi).
La nobile Agrippina si pisciò sotto, anzi - a causa della sua anomala posizione e degli spasmi d'agonia che le avevano sollevato la tunica sbottonata sopra la grande porta - spruzzò di augusto piscio tutto intorno a lei, generando panico, ma anche libidine.
Poi fu la volta di un'imperiale cagata.
La paura di morire era troppa.
Gli schiavi guardarono supplici le guardie, per capire se almeno questo potevano farlo.
Il disgusto sul volto dei valenti armati non lasciava dubbi.
Gli schiavi ripulirono la merda e il culo di Agrippina.
Se poi indugiassero troppo a lungo, questo a Calliope non è dato sapere...
 La madre del Sommo Figlio aveva la faccia
schiacciata sul letto, visibile solo per metà, con l'occhio fisso su Caronte, pronto a
caricarla.
La madre del Sommo Figlio aveva la faccia
schiacciata sul letto, visibile solo per metà, con l'occhio fisso su Caronte, pronto a
caricarla.
«Vi prego... solo un po' d'acqua...», un drammatico appello squarciò l'aria pesante d'attesa.
Una guardia annuì con un breve cenno del capo.
Agrippina bevve da una scodella, come la cagna che era.
Poi, vistasi perduta, lanciò l'ultimo dado.
Mandando un rantolo, si rivoltò supina, esibendo il mortale pugio, immerso fino al manico nel molle ventre.
Quindi fece cadere nel vuoto un braccio, mentre l'altro lo mandò sulla fregna, quasi a toccarsi.
Voleva mostrarsi il più possibile disperata e zoccola.
Sperava ancora che qualcuno la salvasse.
Con gli occhi fissi al soffitto e la bocca spalancata, come quella di un pesce che - ingannato dalla marea - finisce intrappolato su una spiaggia, biascicò queste parole, sputacchiando sangue in giro: «Non voglio morire... cough... respingo il suicidio... ahh... chiedo perdono al Principe... ohh... accetto l'esilio.... hh-hhh...».
Agrippina boccheggiava.
C'era un clima di pesante attesa intorno a lei.
Ma lei voleva salvarsi a tutti i costi, perché riprendendosi il braccio caduto, si stirava addosso la tunica, mettendo in rilievo le zinne e tutto il resto.
Agrippina si aspettava di essere soccorsa da un momento all'altro.
«Tu... bel giovane... cough-cough...», parlare le costava molto, «non vorrai... farmi morire... hhh-hh...», ancora un rantolo pericoloso, uno degli ultimi avvertimenti.
La madre del Sommo Figlio, a sua volta Padre di tutti i Romani, e dunque nonna del Popolo, si era rivolta a una guardia, sperando di trovare aiuto.
Ormai aveva ceduto al panico e si aggrappava a tutto.
«Tu... dico a te... ho poco tempo... cough... corri dal Principe... hh... e digli... che la madre... oh... vuole vivere...
Se si sbriga... hh-hhh... la troverà... hghh...», l'ultima parola le si strozzò in gola.
Agrippina gemette, non riusciva più a parlare.
Tutti erano con il fiato sospeso, mentre cercavano di capire quanto le rimanesse.
Si chiedevano se la fine sarebbe giunta rapida, oppure dopo un ulteriore aggravamento.
Ci fu un'esclamazione collettiva di stupore, quando entrambe le braccia, una dopo l'altra, caddero nel vuoto, oltre la sagoma del letto.
Si era dunque giunti alla fine dello spettacolo?
Pareva di sì.
Il sangue di Agrippina sgocciolava lento e macabro, dal centro infossato del letto al pavimento.
Gli ultimi appelli dell'Augusta erano caduti nel vuoto.
Nessuno avrebbe mai fatto torto al Principe.
Solo lui avrebbe potuto salvare la madre.
Ma se pure una guardia, suggestionata da quel viscido spettacolo, fosse corsa da lui per avvisarlo e partecipargli le sofferenze della genitrice, ebbene... sarebbe stato troppo tardi!
La madre aveva esaurito i trucchi.
«Hh-hh... hh...», riusciva ancora a mandare qualche rantolo, ma era alla deriva.
I presenti trattenevano il fiato. Era finita. Non aveva trovato scampo.
Forse per non farsi vedere mentre moriva, almeno non da tutti, Agrippina ebbe la forza di girarsi su un fianco, l'occhio fisso sul nulla, l'altro nascosto tra le pieghe del lenzuolo, la bocca orrendamente spalancata.

Prendeva forma uno stupendo cadavere, grasso, bono e scosciato.
Il gelo calò tra i presenti posti su quel lato.
Gli altri, invece, pensavano fosse una reazione che mostrasse forza.
Capirono dallo sguardo attonito dei primi che la situazione era precipitata.
Tutti si accalcarono dallo stesso lato, per guardare Agrippina nell'occhio rimasto fisso.
Nessuno aveva il coraggio di toccare il corpo.
C'era incredulità e panico.
Agrippina non reagiva.
Nessuno credeva che potesse salvarsi, ma lo spettacolo era stato altamente drammatico e avrebbero voluto che proseguisse.
Di Agrippina nessuno era mai stanco.
Ma il Sommo Figlio aveva avuto il coraggio di liberarsene.
«Padrona... Padrona...», la invocò uno schiavo.
Una guardia intuì occorresse una prova.

Infilò la retropunta di un pilum nel culo di
Agrippina.
«Uuhmmm…».
Un gemito, il muggito della vacca imperiale, si liberò nell’aria.
La guardia ritirò l’arma.
L’esperimento aveva sortito i suoi effetti.
La zoccola imperiale, benché alla deriva, non era ancora affondata.
Agrippina aveva ritrovato un po’ di fiato e
riprese a sperare.
«Vieni… cough-cough…», chiamò la guardia con la mano lurida di sangue,
affinché si avvicinasse.
«Cough-cough… ho le budella… che mi stanno uscendo fuori…
ti faccio un bocchino… cough… se mi fai
tamponare…».
Un nuovo orrore si faceva avanti.
Sotto la tunica, intorno alla ferita, si erano formati dei grossi rigonfiamenti.
Tutti, inorriditi, avevano capito di cosa si trattasse.
Il pugio li teneva insieme come una spilla per capelli,
ma il problema sarebbe prima o poi scoppiato.
La guardia pretoriana approfittò dell’occasione e infilò il cazzo già duro nella bocca di
Agrippina, mentre con un cenno autorizzava gli schiavi a
portare soccorso.
Bende, spugne, sali: tutto arrivò in un attimo, già pronto, mentre anche lui
arrivava.
Agrippina mando giù tutta la sborra, perché era energia e vitalità.
Lui aveva il cazzo tutto sporco di sangue.
«Ascolta… bel giovane… cough…», gli parlava con un filo di voce.
«Io… sono vedova… ahh... tu chiederai… ohh… la
grazia… cough… per tua moglie… vivremo in esilio… cough… insieme… l'Augusta… sarà tua… hh-hhh…».
La guardia attese il responso del popolo.
«Evviva!», «Auguri!», «Bel colpo, la gran sorca è tua!», quest'ultimo venne da un suo
compagno.
E visto che, tra i curiosi presenti, c’era anche un Sacerdote di Iside, e i testimoni d'altronde non mancavano, la cosa fu presto fatta, anche perché di tempo
non ce n’era molto.
Lei lo sposò senza neppure conoscerne il nome, che comunque era Marco.
Giunta la risposta del Principe, che per sua munifica grazia concedeva alla
madre l’ultimo desiderio, Agrippina fu trasportata in lettiga fino al
porto, dove venne imbarcata per la Corsica, luogo d’esilio a vita, sebbene il termine
apparisse decisamente sarcastico.
![]()
Durante la navigazione, che in fondo
era anche un viaggio di nozze, sebbene il marito la rifornisse con regolarità
di sborra, la misera Agrippina fu quasi affondata da un
nuovo aggravamento, mentre le budella continuavano a uscirle
fuori, a causa della tosse convulsa e della tremenda ferita.
Con le viscere in mano non si va da nessuna parte, solo lei aveva avuto la
presunzione di farlo.
Ma lei non era stanca di vivere, nemmeno in quelle condizioni, e faceva progetti con il marito, per
lusingarlo e non farlo pentire,
arrogante e insolente come sempre, verso
l'intelligenza altrui.
Per le zinne e il grosso culo di Agrippina, per una sorca morente, suggestionato dagli ultimi sussulti della famosa Augusta, Marco si era rovinato per l'intera vita.
«Sono soddisfatto di te e di come stai gestendo la situazione, moglie mia», pare che disse, per lusingarla a sua volta.
«In Corsica nessuno dovrà vederti in queste condizioni, a parte i medici.
Non sarebbe dignitoso per te, Somma Augusta».
«Nessuno... deve vedermi... uhh... né sapere...
Ma ho i freni tirati... cough... e questo... mi fa stare tranquilla...
E anche tu... lo sei...
Sarò curata... ohh... farò venire... cough... i migliori medici...
Nessuno... uhh... potrà fermarci...».
Poco lucida, Agrippina fantasticava - in toni deliranti - di un'improbabile salvezza.
«Però se ci hanno lasciato andare, è perché ti considerano spacciata, lo sai...».
Marco sapeva risponderle a tono.
«No...! No... sono troppo stupidi... ohh... il loro è... cough... un errore di calcolo...».
Agrippina continuava ad alimentare - anche con accessi di rabbia - le proprie illusioni, incapace di accettare il proprio destino, che pure le mandava segnali precisi.
Marco, invece, stava rivelando la sua natura perversa, divertendosi a mettere in discussione le scellerate certezze della moglie, che anziché comprendere la misera fine che l'attendeva, pensava ancora di beffare tutti e ritornare al tavolo del potere...
«Tu... ancora non mi conosci... Marco... cough... io sono potente...», e gonfiava le zinne, pensando con quelle di ottenere tutto.
«Adesso, però, Potentissima Augusta, stai attenta a non farti sorprendere, non abbassare la guardia... il viaggio è ancora lungo...», Marco ricambiò l'arroganza della moglie con una velata minaccia e un triste gioco di parole.
Non era l'ingenuo che Agrippina pensava.
«Dubiti... di me... Marco...?».
«No, io credo in te, Agrippina.
Ma un pugio ti è uscito dalla schiena... e pezzi di budella dalla pancia...».
«Sì... è vero... ma il colpo... ahh... non mi ha uccisa... cough... non è mortale... Io stessa... l'ho indirizzato... uhh... come volevo... cough...
Ero allenata a questo... ahh... le budella... torneranno al loro posto... cough...».
«Adesso, basta... non parlare più...
Parlare ti fa tossire, e la tosse ti spinge fuori le budella...
Non devi aggravarti, o tirare i freni non basterà più...».
E Marco ebbe ragione, per Bacco e Priapo!
Si dice infatti che l'Augusta fosse già
cadavere quando fu sbarcata in Corsica, anche se le tendine della lettiga erano tenute
chiuse, durante la marcia forzata verso la casa
dell’esilio.
Calliope ha taciuto se fu lei a lasciar vedova la guardia, o quest'ultima la
moglie.
Non sempre al Vate è dato dissipare la nebbia delle Muse!
Se il fato è potente, il dubbio
lo è di più!
Comunque i suoi trucchi non le erano serviti a niente, se non a dare materia a questo spettacolo, in cui vengono sviscerate le ultime ore
miserabili di Agrippina Augusta - madre del Sommo Figlio, Padre di tutti i
Romani - affondata con le budella in mano, pisciando dalla pancia per tacer
d’altro!
Pare comunque certo che si possa presagire sin d'ora che lo spettacolo della grossa sorca, con la bocca spalancata, gli occhi fissi al cielo, le mani a trattenere disperate un ammasso di
budella schizzate fuori dalla pancia, la tosse che infierisce, e i gemiti gutturali
con cui invoca di essere salvata, ingoiando nel frattempo sperma che le cola via dalla pancia
aperta, pare certo che - dicevamo - non mancherà di spillare
sborra e curiosità anche alla posterità!
E tutto questo per un colpo di pugio mal digerito dalla vecchia zoccola!
«Applausi scroscianti, passerella e sipario: credo proprio - tempo una decade - che nessuno si ricorderà più di Ovidio!».
![]()
«La ferita non si rimargina. Agrippina soffre di continue emorragie».
«Anche se ha lo stomaco diviso in due, il potere sarà diviso in tre».
![]()
«Soffrire fa male... sfuggire alla morte è difficile... ma annaspare nello Stige può allungare la vita....», raccontava agli intimi. «L'importante è tirare avanti».
Una filosofia spicciola, ma efficace; e un leggero spasmo della pancia a tranquillizzare tutti.
![]()
9 giugno 68 d.C.


![]()
CRONOLOGIA STORICA
15 d.C. - Nascita di Agrippina
28 - Agrippina sposa il padre di Nerone
39 - Agrippina viene esiliata a Ponza dal fratello Imperatore, Caligola
40 - Morte del padre di Nerone
41 - Ascesa di Claudio e rientro a Roma di Agrippina
42 - Agrippina frequenta Galba
43 - Agrippina sposa Passieno Crispo
46 - Morte di Passieno Crispo
49 - Agrippina sposa l'Imperatore Claudio, suo zio
54 - Morte di Claudio e ascesa di Nerone
59 - Attentato ad Agrippina ed esilio in Corsica;
Agrippina, ridotta in fin di vita, sposa il pretoriano Marco
60 - Patto riservato di governo tra Agrippina, Seneca e Burro
61 - Morte del pretoriano Marco
62 - Agrippina sposa Burro con nozze private
65 - Morte di Seneca
68 - Morte di Nerone e rientro a Roma di Agrippina
69 - Anno dei Quattro Imperatori
69 - Agrippina interviene nella lotta tra Vitellio e Vespasiano,
e forma con loro un Triumvirato
79 - Morte di Vespasiano
79 - Il figlio di Vespasiano, Domiziano, reclama il potere assoluto
79-81 - Guerra civile tra Agrippina, Vitellio e Domiziano
80 - Morte di Burro
81 - Morte di Vitellio
81 - Domiziano è sconfitto ed esiliato in Mesia
82-85 Agrippina conquista la Germania Magna,
l'Impero è alla sua massima estensione
92 - Agrippina si ammala di cancro all'intestino
98 - Agrippina si aggrava e sposa Traiano, in seste nozze
101 - Agrippina è ridotta in fin di vita dal cancro
102 - Agrippina si fa trasferire in Egitto
104 - Notizia della morte di Agrippina e della sua imbalsamazione,
dopo 55 anni da Imperatrice
105 - Voci ricorrenti su Agrippina in cura ad Alessandria
106 - Voci su Agrippina trasferita d'urgenza presso la Regina di Persia


![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
![]()

![]()
Layla Galliani gondoleggia sul Canal Grande.

 Forse
l'hanno fatto grande perché doveva passarci lei.
Forse
l'hanno fatto grande perché doveva passarci lei.
Lei si sente la Dogaressa di Venezia e lo crede davvero.
Benché di origini libanesi e divorziata da un milanese, ha trovato qui il suo destino.
Il gondolio le rilassa le budella, e per lei vuole dire tanto.
«Sono malata, non so altro, lasciatemi in pace», aveva risposto due giorni prima al Commissario Conte.
L'omicidio è stato rivendicato dalle Brigate Rosse.
Tuttavia la Galliani non si è mai interessata di politica.
E ancor meno meno dopo che un tumore galoppante all'intestino le ha ipotecato il futuro.
 Lo stesso Zaia
ha avuto paura di ritrovarsi una biscia addosso.
Lo stesso Zaia
ha avuto paura di ritrovarsi una biscia addosso.
«È stato lui a mollarmi, quando mi sono aggravata. Non è stato molto carino».
«La capisco, signora, mi creda.
Però il suo risentimento può averla spinta a passare qualche informazione riservata ai terroristi, così da fargliela pagare...».
«Lei è uno stronzo, Commissario. Io sto crepando. Cosa vuole che me importi di quel pallone gonfiato. Posso avere tutti gli uomini che voglio...».
«Sicura che non si possa far niente?».
«Per cosa?».
«Per la sua malattia...».
«E a lei cosa gliene importa?».
Ormai ha capito; e cambia registro.
«Lei cerca di essere carino con me, e io lo apprezzo molto...
Purtroppo, però, non c'è molto da fare. Proverò ancora della radio. Ma solo per guadagnare tempo».
Gli si secca la lingua.
«Grazie».
![]()
«Commissario, mi dispiace disturbarla, ma non sto bene.
Ho mal di pancia e so di che si tratta...
No, non c'è bisogno del medico.
Però ho paura a rimanere sola durante queste crisi...
Mi farebbe piacere. L'aspetto».
![]()
«E se ti dicessi che l'ho ammazzato io?
Mi manderesti in prigione?
Tra non molto mi trasformerò in una biscia.
Sai cosa significa?».
«Sì, credo di sì».
«Mi piaci, perché non sei come gli altri.
Capisci le cose, nel verso loro, e parli con gli occhi.
In fondo hai le stesse iniziali del Grande Maestro».
![]()
![]()
Molteplici sono le ragioni per le quali piace: a parte l’amabile attaccatura dei capelli e l’inconfondibile mento in rilievo, è alta, sostanziosa, con una fronte da coronare e occhi che bruciano.
La morbida pancia botticelliana e le forme piene, solide, senza per questo essere grasse, costituiscono altre rotonde ragioni.
Si dice, inoltre, che abbia origini libanesi. In effetti, il fuoco che le brucia negli occhi depone a favore delle voci.
«La tua cura ha funzionato, Sal.
Spero di stare meglio anche domani, perché il Conte Bragadin mi ha invitato al suo ballo in maschera.
Vorrei che tu mi accompagnassi.
In maschera non ti riconoscerà nessuno.
Se accetti, il costume ti arriverà a casa».
«Non ti ho dato il mio indirizzo...».
«È vero, ma vuoi che il Conte Bragadin non sappia dove abiti?
Al ballo ci saranno anche il Prefetto e il Questore.
Se accetti una confidenza, il Ministro degli Interni si consulta con Bragadin prima di nominare qualcuno a Venezia. E questo da almeno 20 anni».
«Il Conte ti fa la corte?».
«Penso proprio di sì. Non sei un puttaniere, Sal».
«Intendevo il vero Conte...».
«Sei tu il vero Conte, Sal...».
![]()
Una scalinata in marmo bianco arriva lucida fino alle porte d’ingresso del salone e già dagli archi soprastanti, affrescati con raffigurazioni dai colori tenui, che vanno dal rosa antico al giallo ocra, passando per l’azzurro zaffiro, si nota un’assoluta eleganza, che può essere ammirata nella sua completezza non appena si spalanca agli occhi il salone da ballo, già affollato della Venezia che conta.
La sola grandezza basterebbe a distinguerlo da tutti gli altri: alto quasi come due piani e lungo come almeno quattro corridoi messi in fila, e poi affreschi a soffitto da guardare con la testa indietro e il naso all’insù, colonne pitturate e pareti abbellite da arazzi di differenti forme e colori, vetrate alte e nobili a guardare sul Canal Grande e lampadari di cristallo a far luce su tutta quella bellezza, con un pianoforte a coda sistemato in un angolo e ancora elegantemente silenzioso.
![]()
![]()
Il Conte Bragadin l’ha arredato a suo gusto, nel rispetto della Serenissima tradizione, e tale sfarzo, per alcuni eccessivo, è stata una sua consapevole scelta.
“Procul este profani”, sta inciso su un architrave all’ingresso.

Chi non ha la capacità di apprezzare, ne resti fuori.
«Tu sei l'unica a non essere in maschera...
Ti vesti adesso?».
«Sal... io sono la festeggiata.
La Dogaressa di Venezia non appare mai in maschera».
«Scusa; all'Accademia queste cose non le insegnano...».
«Scuse accettate», e si lascia prendere la mano dal Commissario, che la porta al centro del salone e delle danze.
Un attimo dopo, con cenno ieratico, il Conte comanda l'esecuzione dell'Anonimo Veneziano di Stelvio Cipriani, summa trionfale di Venezia.
Layla indossa la solita camiciona bianca a collo alto, di chiaro prestigio, attillata alle forme importanti, sbottonata da mignotta di lusso.
Intorno a loro si forma il vuoto, nessuno si avvicina a meno di quattro-cinque metri.
«Sembra quasi che ci evitino...», le sussurra il Commissario all'orecchio.
«Si usa così, tra nobili».
«Ma chi è questo fortunato?
Vogliamo vederlo in faccia!».
«E quello chi sarebbe?».
«Il Conte Bragadin.
Sei disposto a toglierti la maschera davanti a tutti?
Davanti al Questore?
E al Prefetto?».
«Certo.
Cosa me ne importa?
Se non dà fastidio a te...».
«Sei un uomo d'altri tempi, Sal».
«Vuole dunque Sua Grazia mostrare alla nobiltà della Serenissima il volto del suo galante accompagnatore?».
«Preferisco di no, Conte».
«Le vostre preferenze sono decreti, Serenissima Signora», il Conte si inchina e con un cenno fa riprendere la musica.
«Una donna d'altri tempi non mette in imbarazzo il suo uomo...», gli sussurra Layla all'orecchio.
![]()
La Galliani si stanca presto, le sue condizioni sono tuttaltro che buone.
«Mi gira la testa... accompagnami in fondo alla sala... c'è una sedia che somiglia a un trono...».
Il Commissario va oltre e la solleva da terra, prendendola tra le braccia.
Si guarda intorno e vede il trono.
L'adagia delicatamente e le prende la mano.
«Come ti senti?».
«Sono arrivata, Sal...
Non posso più sbattermi in giro... devo imparare a fare la biscia».
Il medico personale del Conte interviene subito con un tonico.
Le danze non si sono interrotte.
![]()
Una settimana dopo, Layla è ricoverata in gravi condizioni nel palazzo del Conte Bragadin.
Respira a fatica e c'è molta preoccupazione intorno a lei.
Si attende il suo crollo da un giorno all'altro.

 Ma
intanto tira avanti, va da San Polo a San Marco, e da San Marco a San Polo,
lungo i gradini di Rialto.
Ma
intanto tira avanti, va da San Polo a San Marco, e da San Marco a San Polo,
lungo i gradini di Rialto.
Va in giro da sola, a tarda notte.
Tra la nebbia.
Sbottonata, tra la nebbia.
Due uomini mascherati la affrontano minacciosi.
Uno viene da San Marco, l'altro da San Polo.


Layla si appoggia alla massiccia balaustra di marmo.

«Cosa volete?».
Nella destra dei sicari compare una daga finemente lavorata; una coppia gemella.


Un’arma di lusso per una donna di lusso.
Layla ha ormai capito che il suo momento è arrivato.
SZOCK
SZOCK
Si lascia colpire senza opporre resistenza e senza invocare aiuto.
Sarebbe servito a poco.
Trattiene anche i gemiti di dolore, cerca di morire da nobildonna veneziana.
SZOCK
SZOCK
Ancora un paio di colpi al ventre.
Layla si protegge d’istinto l’addome, voltandosi di schiena e aggrappandosi al profilo opposto della balaustra.
SZOCK
SZOCK
Due crudeli colpi alle reni.
Per la signora Galliani è un calvario.
Ma rimane in piedi.
Si lascia scivolare di un paio di gradini verso l'inferno, pur rimanendo in piedi; tanto per fare qualcosa.
Ma viene voltata a forza.
SZOCK
SZOCK
SZOCK
SZOCK
SZOCK
Una raffica rabbiosa di pugnalate al ventre.
Fiaccata da undici coltellate, ma non ancora stroncata, Layla si aggrappa di nuovo alla sagoma della balaustra, imprimendo sul marmo l’indelebile marchio del sangue, voltando la schiena agli assassini, precariamente in piedi.
SZOCK
SZOCK
Implacabili, i sicari infieriscono con altri colpi alle reni.
Sono tredici.
Si guardano, si confermano a vicenda il conto.
E se ne vanno nella nebbia.
Il calvario è finito.
Magra consolazione.
La signora Galliani è incredula.
S’è fatta ammazzare!
Non le hanno lasciato scampo.
Le gambe di Layla cedono.
E anche le braccia.
Rotola all'inferno lungo i gradini di Rialto.
Ma arriva qualcuno.
La vede.
La volta.
«Sei tu... ohh... gettami in acqua... ahh... voglio... essere sepolta qui... uhh...».
«No, andiamo a casa, Layla».
E la solleva da terra, tra le sue braccia.
![]()
Gli ha raccontato il sogno, prima di perdere conoscenza.
È chiaro che aveva visto la sua morte.
La situazione precipita.
Layla sta per entrare in coma, ormai è in fin di vita.
«Vuoi farla ricoverare?», chiede Bragantin al Commissario.
Mal rassegnato, il poliziotto si ostina a tamponarle il collo con un fazzoletto, asciugandole il sottile strato di sudore freddo che lo impregna.
«Sì, chiamiamo un'ambulanza, facciamo presto...».
![]()
 Sono
decine le persone che raggiungono l'Ospedale, nonostante l'ora tarda.
Sono
decine le persone che raggiungono l'Ospedale, nonostante l'ora tarda.
Layla è in Rianimazione.
Il medico di turno viene preso d'assalto.
«Non è una novità che la signora fosse arrivata alla stadio terminale», si giustifica il dottore. «Purtroppo non ha risposto ai trattamenti, il tumore non ha perso la sua aggressività. La signora è completamente invasa, è stata brava a resistere fino ad adesso, ma purtroppo siamo alla stretta finale. La prognosi è strettamente riservata».
«Non la possiamo portare in una clinica privata?», domanda il Commissario al Conte.
«Sì, è l'unica soluzione.
Ma dobbiamo aspettare che si stabilizzi.
Poi la faremo trasferire d'urgenza a Vicenza. E lì tenteremo una massiccia radioterapia, per fermare il cancro e le metastasi. Oppure per la Dogaressa non c'è scampo. È invasa».
Come nel sogno, il Commissario l'ha trovata ai piedi di Rialto con tredici coltellate in corpo. Eppure, l'ha tenuta a galla.
E - se lei si aggrappa alla balaustra - a galla vuole farla rimanere.
E fa venire la Tromba di Stelvio Cipriani in Rianimazione, per cantarle la sveglia.
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)
«Devi smetterla con ricatti e usura, tu gli succhi il sangue e loro, prima o poi, ti salderanno il conto!».
«No... io sono intoccabile, e poi ci sei tu...
Ho 64 anni, ma non sono finita, staremo sempre insieme...».
L'Ispettore McCain si è fatto ciucciare il cazzo da una vecchia e insaziabile cessa, Layla Coen, cartomante mignottona.
In là con gli anni, ma ben tenuta, si sente ancora una gran fica e spreme a fondo un uomo con 30 anni di meno.
Non vuole darsi limiti.


Il seno da stronza cova sensuale sotto la camiciona bianca a collo alto, importante, prestigiosa e sbottonata aggressivamente.
L'Ispettore copre i suoi traffici, intimidisce i testimoni e inquina le prove.
Per lei farebbe qualunque cosa, è solo preoccupato dall'età, piuttosto avanzata, e dal tumore all'intestino che l'affligge da due anni, e che si è molto allargato.
Layla sta sparando le ultime cartucce.
«È lento, non ti preoccupare».
«Ma non fai niente per curarti?».
 «Si è infilato nelle parti interne, non si può
togliere».
«Si è infilato nelle parti interne, non si può
togliere».
«E allora?».
«Ho ancora parecchio tempo, stai calmo».
Più avanti farò la radio. Non ci saranno problemi».
Malgrado la sua sicurezza, le risposte ai trattamenti non sono buone.
Il tumore è refrattario e si allarga.
Anche la Coen comincia ad avere paura...
Prendere tempo e mostrarsi sicura non basta più.
![]()
Tre coltellate, secche e profonde, sono tante anche per una come lei.
E tra la seconda e la terza, lasciata dentro, se la incula pure.
Però, quando l'assassino se ne va, senza averla sgozzata, si illude di salvarsi.
Cerca di raggiungere il telefono.
E ci riesce.
Dopo notevole sforzo.
Chiama lui. Non ha altro nella testa che lui. È vecchia, ma si è presa una bella cotta. Vuole morire tra le sue braccia.
«Vieni a vedere... fai presto...».
![]()
«Ma che cazzo fai, Layla! Te l'avevo detto!».
La reazione del suo uomo è rabbiosa.
«Chiamo subito un'ambulanza!».
 «Sì... fai pure... ma dammi un bacio... fai presto...».
«Sì... fai pure... ma dammi un bacio... fai presto...».
«Sei sempre bona...».
«John... ascolta... il tumore... è incurabile... forse... è meglio così...».
«Ma che dici, stupida!
L'ambulanza sta arrivando.
E rifaremo la radio. Andrà meglio, stavolta. Tu non ti fai fregare da un tumoraccio come una stronza qualsiasi».
«Sono vecchia... stanca...».
«No... tu non sei finita, Layla. L'hai sempre detto anche tu!».
È rabbioso. Non si rassegna.
«Io ti faccio le carte, Layla...».

«Sei uscita tu stessa.
Vuol dire che ce la farai anche questa volta...
Ti rialzerai anche questa volta, Layla!».

![]()
![]()
di Gianni Rodari e Salvatore Conte (1955-2024)
Correva l'anno milleseicento e un po', e correva tanto forte che ormai era quasi arrivato al traguardo: era precisamente la vigilia di Natale, e il giovane magro, cencioso e dalla pancia vuota - ovvero Arlecchino - malinconicamente accoccolato sotto un balcone di Venezia, lo sapeva fin troppo bene.
Tutti erano a tavola meno che lui, recriminava silente, quando uno spettacolo attrasse la sua attenzione. Una gondola costeggiava la riva e stava infilando il celebre rio in cui si specchia, spaventoso, il Ponte dei Sospiri. Una gondola, a Venezia, non è uno spettacolo strano: ce ne sono migliaia, tutte con il loro bravo gondoliere piantato a poppa come un albero senza vela. Ma quella gondola non aveva gondoliere, era vuota come una cassa da morto senza cadavere, eppure scivolava rapida sull'acqua, mossa da una forza invisibile e silenziosa.
«Guarda, guarda», si disse Arlecchino, «forse la tirano i pesci, per loro divertimento».
«Giovanotto», mormorò una voce femminile alle sue spalle, «volete guadagnare mille ducati?».
Una donna mascherata, di stazza, con grazie e zinne da zoccola, in sgargiante camicia sbottonata, di un colore particolare, stava curva su di lui.
«Mille ducati?».
«Non perdete tempo a contarli, adesso. Prendetemi a bordo, presto, e seguite quella imbarcazione».
Arlecchino balzò in piedi, corse lungo la riva e saltò in una gondola. Il misterioso mignottone lo imitò, sedette a prua e ordinò «Avanti, gondoliere! A tutta vela!».
Mentre slegava la fune dal palo, Arlecchino si ricordò improvvisamente che non era mai stato padrone di una gondola in vita sua, tanto meno di quella che stava rubando.
«Sarei matto a dirle che non sono un gondoliere!», pensò per tranquillizzarsi. «Chissà come si arrabbierebbe. E poi quant'è bona!
 È
meglio che stia zitto: dopo tutto ci sono mille ducati di mezzo, e questa
signora che è tanto bona... e non sembra nemmeno brutta.
È
meglio che stia zitto: dopo tutto ci sono mille ducati di mezzo, e questa
signora che è tanto bona... e non sembra nemmeno brutta.
Quel colore, poi... dove l'ho già visto...?
Quanto alla gondola, la prenderò in prestito».
![]()
 L'inseguimento
durò un paio d'ore.
L'inseguimento
durò un paio d'ore.
Per tutto quel tempo Arlecchino, senza cessar di remare vigorosamente, cercò invano di spiegarsi il mistero di un'imbarcazione vuota come una scodella leccata da un cane, che filava a discreta velocità, scegliendo con gran sicurezza la sua strada nella ragnatela dei rii, dei canali e dei ponti veneziani.
Siccome però a pensare si stancava troppo, finalmente concluse: «Sarà il diavolo che la fa andare. Messer Belzebú, per favore, vogate un po' più piano, perché le braccia cominciano a dolermi».
Arlecchino non poteva nemmeno consolarsi con la generosa scollatura della mignottona, perché questa non si voltava un attimo, impegnata a dargli consigli sulla direzione da prendere.
«Signora, vogliate scusarmi...!».
Ricorse allora a questo ingenuo tranello per attirare la sua attenzione e farla voltare.
Quella, però, non si smosse di una paglia.
«Vi scuserete dopo, adesso vogate, vogate!», aveva risposto.
Improvvisamente la gondola senza gondoliere svoltò tra due palazzi, con una mossa così brusca che Arlecchino, lanciato a tutta velocità, non riuscì a imitarla, proseguendo dritto per una decina di metri.
«Ferma, ferma!», gridò la signorona in maschera. «Torna indietro, idiota.
Se te la lasci scappare, non avrai mille ducati, ma mille bastonate!».
Arlecchino manovrò per girare la gondola, ma per la fretta si infilò in un canaletto cieco; tornò indietro, trovò la strada giusta, un rio nero e puzzolente che sembrava un budello dell'inferno.
Ed eccola là, cinquanta metri avanti, la gondola fantasma che si dondolava tranquillamente, abbandonata presso la riva.
Bastarono pochi colpi di remo per raggiungerla.
La potente signora la esaminò ansiosamente, dentro e fuori.
«A me sembra vuota...», commentò ironicamente Arlecchino, nel mentre, fingendo di cercare anche lui, si godeva la scollatura e le zinne pendenti dell'importante mignottona.
«Sì, maledetto. Lui non c'è più!».
«Lui, chi, di grazia? Messer Belzebú?».
«Non ti impicciare dei fatti altrui.
Ti basti sapere che mi hai fatto perdere almeno ventimila zecchini d'oro.
E scoppiando in pianto, la sconosciuta si strappò la maschera e la calpestò rabbiosamente.
«È da poco che siete giunta in città, vero, Signora?».
«E tu come fai a saperlo?».
«Perché nessuno parla ancora di voi...».
«Sbruffone, incapace!
Se non avessi sbagliato strada, non ci sarebbe scappato».
«Ma chi è scappato?».
«Mustafà, Alí Mustafà, il figlio del Califfo di Baghdad!
Era in carcere ai Piombi, capisci?».
«No, non capisco», rispose desolato Arlecchino, con gli occhi infilati nel camicione della zoccolona.
![]()
«È inutile che tu mi venga dietro come un cane raffreddato: mi hai fatto sfumare il più grosso affare della mia carriera da seduttrice, e non avrai un soldo».
Così continuava a borbottare Donna Manuela Moreno - giacché questo era il suo nome - mentre Arlecchino la seguiva a capo chino.
E fu proprio un peccato che tenesse il capo chino, perché quando lo rialzò fece appena in tempo a vedere la donna che spariva dentro l'uscio di casa, e il medesimo (l'uscio) che si richiudeva seccamente.
«Aspetterò qui fuori», si disse il nostro eroe, accoccolandosi sui gradini della soglia.
Ma non stava affatto comodo, e per giunta la pioggia, come se avesse ricevuto un segnale. cominciò a venir giù più forte, con vera malignità.
Arlecchino fece allora il giro della casa e vide un lume in cucina. Picchiò sui vetri e gridò: «Aprite! Sono bagnato come una gondola, fatemi entrare!».
Passò qualche secondo, poi la porta si aprì di un paio di centimetri. Arlecchino v'infilò subito il naso, pensando:«Dove passa il naso, passa tutto il corpo».
 «Ma
che maniere!», strillò la serva. «Non avevo nessuna intenzione di farvi
entrare».
«Ma
che maniere!», strillò la serva. «Non avevo nessuna intenzione di farvi
entrare».
«Peccato. Adesso sono qui e non mi muovo. La tua padrona mi deve mille ducati: se non mi paga, sono deciso a campare qui dentro, a sue spese, per mille giorni. Più altri cento giorni per gli interessi.
Ehi...!».
«Cosa?».
Finito il discorsetto, Arlecchino si accorse di tutto il resto.
Era vecchia; quasi una cessa decrepita.
Ma per tutto il resto, la serva a momenti era più bona della stessa padrona.
Senza tanti problemi, si portava in giro per la casa con una camiciona bianca sbottonata fino allo stomaco. Il fisico era solido, la stazza notevole.
«La vecchia Colombina non è ancora da buttare, giovanotto...», rimarcò orgogliosa la megera.
«Vedo, vedo».
«Senti, a me non danno fastidio i giovani.
Alla padrona, però, non piacciono i miserabili, o quelli che si vogliono ammazzare. Ne ho già uno per le mani, pensa che voleva farla finita proprio qui fuori».
Nella testa di Arlecchino improvvisamente si accese la luce di mille candele di purissima cera.
«Cosa, cosa?».
E va bene: tanto vale che tu conosca tutta la storia.
Esco fuori un attimo, per scaricare un po' d'acqua sporca, e che cosa vedo?
Un poveretto, aggrappato a una gondola, sul punto di affogare. Sono arrivata appena in tempo per salvarlo».
«E adesso dov'è?», domandò Arlecchino, tenendosi le due mani sul cuore per impedirgli di scoppiare.
«Là dentro», fece la vecchia, indicando la cassa della legna. «L'ho nascosto lì, quando ho sentito la padrona rincasare, ma per fortuna è salita subito nella sua camera.
Arlecchino spiccò un salto e andò a sedersi sulla cassa.
«Che cosa ti succede?», strillò la megera, spaventata.
«Che cosa mi succede? Lo vuoi proprio sapere? In questa cassa ci sono almeno ventimila zecchini d'oro».
«Non dire sciocchezze: non c'è che un poveraccio mezzo affogato. Levati di lì, sarà ora di fargli bere un sorso di grappa».
«Non mi credi, eh?», sibilò Arlecchino. «Sappi allora che questa sera la tua padrona ha fatto fuggire dai Piombi di Venezia, per incarico del pirata Alí Badalúk, il figlio del Califfo di Baghdad. Ella avrebbe dovuto portarlo in mare aperto, dove i pirati lo aspettano. Ma la sua avidità le ha suggerito un altro piano: mandare i pirati al diavolo e accompagnare lei stessa il fuggitivo a Baghdad, per avere dal Califfo una maggiore ricompensa. E così, dopo aver sedotto il Capo delle guardie, ha indicato al povero giovane la via di questa casa, suggerendogli di nuotare aggrappato alla gondola, per non farsi scorgere dalle altre guardie del Doge. Noi abbiamo seguito la gondola fino a poca distanza da qui, poi l'abbiamo persa di vista. Adesso la tua padrona è arrabbiata come un temporale di giugno: è convinta che il prigioniero sia caduto in brutte mani. E invece», concluse Arlecchino, picchiando sulla cassa, «il figlio del Califfo è venuto qui dritto dritto per farci ricchi tutti e due».
I colpi battuti sulla cassa erano stati abbastanza forti: ne uscì in risposta un lamento soffocato. Arlecchino saltò in piedi come se gli avessero punto il didietro, alzò il coperchio della cassa e avvicinò la lucerna.
«Guarda!», esclamò. «Che panni porta, secondo te?».
«Santo cielo!», fece Colombina. «È proprio l'uniforme dei carcerati».
«Mi credi, adesso?».
«Dev'essere lui senz'altro».
«Aspetta che rinvenga del tutto e glielo domanderemo.
Intanto», continuò Arlecchino, richiudendo la cassa, «ascolta la mia idea. Domattina il San Marco, un vascello sul quale ho servito da sguattero in gioventù, parte per la Siria. Conosco il comandante, il Capitan Tartaglia, e possa andargli a parlare, se non è troppo ubriaco. Gli dirò che vogliamo andare a cercare fortuna in Oriente, come Messer Marco Polo, e che lo pagheremo al nostro ritorno. Sono sicuro che ci darà un passaggio».
«Ma se dovesse riconoscere il figlio del Califfo? Dal colore della pelle, dalla lingua, capirà pure che non si tratta di un veneziano».
«Non capirà e non vedrà niente, perché il figlio del Califfo viaggerà in questa cassa: sarà il nostro bagaglio. Gli porteremo da mangiare in cabina e gli faremo prendere aria la notte. Gli diremo che è il solo mezzo per salvarlo dalle guardie e sarà ben contento di ubbedirci. Vedrai, anzi, che a Baghdad sarà lui stesso a presentarci al Califfo suo padre e a farci dare una ricompensa strepitosa».
«Sarà pure...», borbottò Colombina, «ma io non ci vedo tanto chiaro. E poi preferisco dirtelo: io da Venezia non mi muovo. Soffro il mal di mare, sono vecchia, e non mi divertirei molto in mezzo a dei marinai ubriachi.
Io resto».

«Ma no, ma no! Tu devi venire. Reciterai la parte di mia nonna e metterai a tacere chiunque voglia darci fastidio.
E alla fine ritornerai a Venezia ricca sfondata, più della tua padrona; e potrai goderti in pace la tua vecchiaia, magari con me...».
![]()
 Il
mattino seguente, sul ponte di comando del San Marco, Capitan Tartaglia si
sforzava invano di dirigere rapidamente le manovre per la partenza.
Il
mattino seguente, sul ponte di comando del San Marco, Capitan Tartaglia si
sforzava invano di dirigere rapidamente le manovre per la partenza.
«Sa... sa... sa...», cominciò a gridare. E voleva dire:«Salpate le ancore», ma i marinai non riuscivano a capire e domandavano: «Salame?».
«No! Sa... sa...».
«Sapone? Saccarosio?».
Quando finalmente Capitan Tartaglia riuscì a pronunciare fino in fondo l'ordine, la nave incrociava già al largo, perché i marinai conoscevano le manovre alla perfezione.
Capitan Tartaglia si asciugò il sudore e disse tra sé: «Bene, a partire ce l'abbiamo fatta. Speriamo adesso di arrivare.
Quei due strani passeggeri, voglio dire Arlecchino e Colombina, mi hanno promesso di pagarmi all'arrivo mille ducati: per la verità io li conosco per due pezzenti, gente che non deve aver mai visto un ducato intero; a parte forse lei...
Ma a me non la fanno: se non mi pagano, li venderò come schiavi ai turchi e non ci perderò nulla; anzi la Colombella è ancora un bel bocconcino e mi renderà parecchio.
Intanto, però, cercherò di capire che cosa tengono in quella grossa cassa.
Mercanzie? Gioielli? Stoffe preziose?
Non può trattarsi che di roba rubata. Sarà bene che li faccia tener d'occhio dal mio fido mozzo Magnapàn».
Non dovete meravigliarvi di sentire un discorso così lungo in bocca a Capitan Tartaglia: questo discorso il comandante l'aveva fatto col pensiero, e il pensiero, come si sa, non balbetta. Anzi c'è gente che parla piano con la bocca e pensa presto con la testa, e ce n'è dell’altra che parla con la bocca più svelta di una mitragliatrice, ma pensa più pianino di una lumaca. Che cos'è meglio?
Mentre riflettete sulla questione, lasciate che vi presenti il mozzo Magnapàn, il più giovane marinaio a bordo del San Marco: un perticone secco secco, sempre affamato. A tutte le ore del giorno e della notte lo si vedeva girellare su e giù per la nave, occupato a mordere coscienziosamente enormi pezzi di pane.
«Magnapàn», gli gridavano i marinai, «dove lo metti tutto quel pane che mangi, se sei sempre grasso come una lucertola?».
Magnapàn, senza rispondere, si toccava la testa con un dito, come per dire: «Mi va tutto in cervello».
E in realtà aveva un cervello sempre in funzione.
Quando Capitan Tartaglia lo mandò a chiamare nella cabina di comando, egli capí che c'era sotto qualche cosa di grosso.
«Ma... ma...», cominciò Capitan Tartaglia.
«Magnapàn», completò il mozzo, gentilmente, infilandosi in bocca un pezzo di pane che avrebbe affogato un bue romagnolo.
«Ce... ce... cercadisà... di sà...».
«Ho capito, Capitano: cerca di sapere cosa c'è nella cassa di quella strana coppia, che si spaccia per nonna e nipote».
«Bra... bra... brabrà».
«Bravo», terminò Magnapàn. «Grazie. E sapete che vi dico, Capitano? Che ho già visto quel che c'è da vedere. In quella cassa c'è un cadavere».
«Un ca... ca... un cacà...».
«Sì, precisamente: un cadavere morto, Capitano.
Ho aiutato io stesso a portare a bordo la cassa, stanotte, e mentre i due colombini si sistemavano nella loro cabina, ho alzato il coperchio e ho visto».
Capitan Tartaglia picchiò un pugno sul tavolo.
Tanta era la sua sorpresa che per un attimo le parole gli uscirono di bocca correndo una in fila all'altra come un branco di sardine in fuga.
«Maledizione, hanno scambiato la mia nave per un cimitero. Altro che colombini: quelli sono due assassini! E il morto, chi mai può essere?».
Io non gliel'ho domandato», rispose Magnapàn, «ho pensato che non mi avrebbe dato retta».
Tartaglia rifletteva rapidamente: «C'è una sola cosa da fare: arrestare i due briganti, mettere in mare una scialuppa e rimandarli a Venezia. Anche il morto, naturalmente. E subito, all'istante».
Senza perdere tempo a parlare, afferrò un braccio di Magnapàn e se lo tirò dietro.
![]()
 L'effetto
più importante delle bordata di avvertimento fatta sparare da Alí
Badalúc fu di svegliare Arlecchino e Colombina, che dormivano allacciati, come
piccioncini, nella loro cabina.
L'effetto
più importante delle bordata di avvertimento fatta sparare da Alí
Badalúc fu di svegliare Arlecchino e Colombina, che dormivano allacciati, come
piccioncini, nella loro cabina.
«Sembra che sia scoppiato un temporale...», osservò la vecchia bacucca, a palpebre e cervello chiusi.
«Se questi sono tuoni, io sono Giove tonante», disse Arlecchino. «Sono cannonate, cara mia. Scommetto che la Serenissima ha scoperto tutto e ci sta dando la caccia.
Tieni pronto il camicione, cercheremo di farci strada...».
Arlecchino si vestì in fretta, si assicurò che la cassa con il prigioniero fosse ben chiusa, si ficcò le chiavi nel taschino e si precipitò sul ponte di comando.
La prima persona che vide fu il mozzo Magnapan, intento a sgranocchiare la decima pagnotta della mattinata.
«Beato te... mentre la polizia della Repubblica ci dà l'assalto, tu pensi a dare l'assalto alle provviste di bordo».
«Dite piuttosto che il diavolo vi è venuto in aiuto...
Il Capitano e io stavamo per arrestarvi, quando è stata avvistata la Barba del Sultano...».
«Un momento: che cosa c'è c'entra quel potente signore?».
«Voltate il vostro naso a sud-ovest e guardate con i vostri occhi».
Arlecchino eseguì la manovra e, ormai certo che non si trattava della polizia, cacciò un grave respiro di sollievo.
«Vedo che vi rallegrate: tra assassini e pirati si va d'accordo, certo.
Immagino che offrirete in omaggio ad Ali Badaluc il cadavere che avete nella cassa, ed egli nominerà voi suo luogotenente, e la vecchia signora sua bagascia personale».
![]()
La battaglia navale tra il San Marco e la Barba del Sultano durò pochi minuti e portò a un notevole precipitare di eventi.
Intanto fu appurato che dentro la cassa non c'era un cadavere, ma neppure il figlio del Califfo.
Dentro la cassa c'era Pulcinella, un mariuolo napoletano, che era fuggito dai Piombi sostituendosi alla nobile prole.
Per evitare l'imbarazzante taglio della testa, Arlecchino escogitò un piano riparatore: lui e Magnapan avrebbero rapito la bella Donna Moreno, così da scambiarla poi, quale prezioso ostaggio, con il figlio del Califfo, ancorato ai Piombi!
Però un conto era sedurre il Capo dei secondini, un conto il Consiglio dei Dieci, formato da vecchi bacucchi.
Le trattative erano in stallo.
A quel punto, sempre per evitare l'imbarazzante taglio della testa, Arlecchino escogitò l'ennesimo piano risolutore: lui, esperto di tutto; Pulcinella, esperto di Piombi: e Tartaglia, esperto di mare e lagune; loro avrebbero liberato Mustafa!
![]()
Verso sera Pulcinella si presentò a uno dei guardiani dei Piombi, lo salutò gentilmente e lo informò che era tornato in prigione perché soffriva di nostalgia.
«Per carità!», mormorò il carceriere. «Vattene subito e non farti vedere.
Tu sei morto di colera».
«Oh cielo!», esclamò Pulcinella. «Come ho fatto a non accorgermene?
Perché non me lo ha detto nessuno?».
«Ma sì, è la storia che abbiamo raccontato al Governatore per spiegare la tua scomparsa. Non possiamo mica farti risuscitare!
Sei libero come l'aria».
«In questo caso, stammi a sentire... il colera è contagioso ed è anzi probabile che il mio compagno di cella sia pure morto di colera...».
In breve, con la promessa di un lauta ricompensa, il carceriere fu guadagnato alla causa. Lui stesso guidò i tre sul tetto dei Piombi e indicò loro la via per raggiungere la cella che li interessava.
I duemila zecchini d'oro andarono dunque a Capitan Tartaglia, Arlecchino e Pulcinella.
Tuttavia, poiché non era facile dividerli in tre parti, Tartaglia ne volle mille per lui solo, ostentando il titolo di Capitano. Allora anche Arlecchino ne pretese mille, visto che aveva portato con sé la nonna; e Pulcinella disse che aveva bisogno di pagarsi il funerale.
 Alì Mustafa, il figlio del Califfo, decise allora di abbassare il premio a
millecinquecento zecchini, affinché se ne andassero contenti.
Alì Mustafa, il figlio del Califfo, decise allora di abbassare il premio a
millecinquecento zecchini, affinché se ne andassero contenti.
«Abbi cura di lei».
Aggiunse, però, una borsa da ventimila zecchini d'oro.
E si congedò da lei.
«Tu sarai Califfa, un giorno.
Salirai su una gondola senza gondoliere, e prenderai terra a Baghdad, nella mia città. Farò tagliare l'Egitto in due per te, affinché il tuo viaggio non incontri mai terra fino alla mia.
Il tuo tempo non ha limiti. Sarai sempre la stessa».
Il lettore avrà capito benissimo a chi stia parlando il futuro Califfo.
L'avete capito, oppure no?
![]()
![]()
ASSALTO ALLA MINIERA FANTASMA
di Salvatore Conte (2024)



Anziché fare la domestica o la mignotta, ha imparato a sparare.
E lo ha imparato bene.
Si è fatta una discreta reputazione come vigilante, e adesso lavora per Mister Sutton al Two-Moons Ranch, in Arizona, nei dintorni di Phoenix.
La paga è buona e ogni tanto si fa scopare dal padrone per tenersi il posto e incassare qualche gratifica.
È un presuntuoso arrogante come tanti. Ma la paga è buona e di meglio in giro non c'è niente.
Leticia Munoz da Veracruz non ha tanti grilli per la testa. Ci sono un paio di vaccari piuttosto insistenti, ma lei preferisce non avere legami. Sono pericolosi.
Vuole fare un po' di soldi e poi cambiare aria.
Bella da giovane, adesso è più che altro una grossa cessa.
In genere, indossa un lungo camicione molto comodo,

 che
le arriva sotto le ginocchia dopo una lunga fila di bottoncini; malgrado tutto,
però, le forme pesanti
si intuiscono con facilità.
che
le arriva sotto le ginocchia dopo una lunga fila di bottoncini; malgrado tutto,
però, le forme pesanti
si intuiscono con facilità.
Nelle situazioni più complicate, si sbottona fin quasi alla sorca e impressiona Mister Colt e Mister Winchester con la pancia e le zinne da vacca.
Finora ha sempre funzionato.
Tuttavia con Mister Tomahawk potrebbe finire diversamente.
Oppure nello stesso modo.
![]()
Ci sono soldi da fare, ma il rischio è grosso.
Il padrone si è messo in testa di ficcarsi dentro i Monti Superstizione, alla ricerca di una miniera perduta.
Ha portato con sé quasi tutti i suoi uomini, inclusa Leticia.
 «Spero tu abbia capito che le cose potrebbero mettersi male.
«Spero tu abbia capito che le cose potrebbero mettersi male.
Ci conviene coprirci le spalle a vicenda...».
«E perché dovrei fidarmi di te?».
«Gli altri ti considerano una grossa zoccola e basta. Io, una signora».
«E magari una signora da sposare...».
«Perché no?».
«Ti ho detto di stare alla larga, Sam.
Non voglio uomini nella mia vita».
E sprona il cavallo, per staccarsi.
L'approccio non ha funzionato, ma lui la tiene nel mirino del suo fucile a canna corta.
«È solo una zoccola, amico. Non farti il sangue amaro».
«Sì, hai ragione, Bill».
![]()
 «Scusa per prima, Sam...
«Scusa per prima, Sam...
Sei sempre carino con me, e non allunghi le mani.
Devi capire che ho i miei tempi».
«Solo una donna di classe avrebbe chiesto scusa...».
«E allora?».
«Allora...?».
«Le scuse...».
«Accettate, ovvio. Anch'io ho le mie colpe».
«Bene, adesso ho da chiederti un favore».
Annuisce.
«Qua tira una brutta aria.
Se mi dovesse succedere qualcosa, vorrei che tu spedissi il mio denaro ai miei figli.
Lo faresti?».
«Mi interessi viva, Leticia: non mi piacciono questi discorsi».
«Lo faresti?».
«Nomi e indirizzo».
Miguel e Carmen Munoz Veloso, presso Phoenix Bank di Veracruz, Veracruz, Messico.
Ripeti».
«Miguel e Carmen Munoz Veloso... presso Phoenix Bank di Veracruz... Veracruz... Messico...».
«Da Phoenix arrivano come una fucilata.
 Mister Sutton già conosce la mia volontà. Gli dirò che ci penserai te».
Mister Sutton già conosce la mia volontà. Gli dirò che ci penserai te».
«Lo prenderà come un segno di sfiducia».
«Può darsi; infatti non mi fido di lui».
«Se vuole, può sbarazzarsi di chiunque, me incluso».
«Vero, ma non è detto che lo faccia. Questa è gente che pensa in maniera pratica. Se non gli dai fastidio, si trattiene entro certi limiti».
«Non ti fidi di nessun altro?».
«No».
«Allora hai capito?».
«Ho capito.
Tu devi pensare a qualcuno?».
«No».
Stavolta si sfila, rallentando leggermente l'andatura.
Il dialogo è durato fin troppo.
![]()
 «Ho dieci dollari per te, bellezza...», e
glieli mostra, usando una certa discrezione.
«Ho dieci dollari per te, bellezza...», e
glieli mostra, usando una certa discrezione.
«Per dieci dollari mi sbottono fino allo stomaco. Ma sei vuoi arrivare alla sorca, ce ne vogliono quindici... Rowdy...».
«Ci sto. Stanotte ci facciamo mettere di guardia insieme».
«Però non voglio chiacchiere. Il padrone si incazzerebbe».
«Lo sapremo solo io e te...».
Leticia annuisce al biondo sbruffoncello.
![]()
«Pare che anche Tex Willer e Kit Carson si siano messi contro di noi, Leticia...».
«Contro il padrone, vorrai dire...».
«Siamo noi che lo proteggiamo, ricordatelo».
«E chi sarebbero questi due?».
«Due Rangers del Texas molto pericolosi. Willer si fa passare per paladino degli indiani e ha preso le parti di Weiser perché ha la moglie apache».
«Secondo me vuole mettere le mani sulla miniera, come tutti noi».
«Già, ma anche se siamo una trentina, abbiamo contro Weiser e i suoi uomini, gli apache e i tagliatori di teste che infestano questa regione, e Willer con il suo socio che da soli fanno per trenta».
«Vuoi spaventarmi?».
«Solo metterti in guardia».
«Sono pronta...», e si allenta l'ennesimo bottone. «Anche gli apache hanno il pisello, ricordatelo».
Leticia si stacca dopo un sorriso sfuggente, affinché non si dica che faccia comunella con Sam. Scambia qualche parola anche con gli altri, ma probabilmente solo per la facciata.
La giornata a cavallo è lunga.
Voci, rumori, odori, tutto conta prima di arrivare al piombo.
![]()





BANG
BANG
BANG
Durante la divagazione intorno al bivacco, si scatena l'inferno. L'oro è sempre più un miraggio.
Uno dei colpi raggiunge Leticia allo stomaco; la donna crolla sulla schiena.
Sam, che la teneva d'occhio, se ne accorge subito e un brivido gelido gli percorre la spina dorsale.
«La tua Layla... è stata colpita... ohh...», sussurra da terra, ancora tramortita.
Ma non è finita qui; c'è di peggio in arrivo.
![]()
Sam è riuscito a portarla fuori dalla mischia appena in tempo...
Adesso marciano appaiati, lei ingobbita in avanti, lui che si volta spesso per controllare se riesca a mantenersi in sella.
«Pensi sia grave...?», gli chiede, alla prima sosta.
«Un po'».
«Se va storta... sai quello che devi fare...».
«Non andrà storta».
«Ci stanno seguendo...?».
«E chi? L'oro li ha chiamati... e l'oro li ha sepolti...».
«Meglio ripartire... non ho molto tempo...».
«Sì, muoviamoci, dobbiamo raggiungere in fretta un villaggio».
Rallentati dall'oscurità, i due ci mettono alcune ore per entrare a Mine Creek.
L'alba è arrivata da un pezzo, quando Leticia viene portata dal cavadenti del posto. La donna è ormai in fin di vita e si tiene stretta alla mano di Sam.
L'unico che ancora intraveda l'oro è lui.
Scavato e in bella vista; sudaticcio e pulsante.
«Io non ti lascio andare, e tu non ti lascerai andare: questo è l'oro che nessuno ci può rubare, Leticia».
Annuisce, stringendo un po' di più.
![]()
![]()
![]()
LA STAR DI FREGENE RIMANE UCCISA
di Salvatore Conte (2025)

![]()
Dal carcere, Giada Crescenzi accusa: «Mia suocera - sfruttando il fisico - faceva la mignottona in spiaggia; si portava a casa i figli di papà e li spennava fino all'ultimo euro; e a me non regalava niente.


Però non avevo nulla contro di lei: sono innocente.

Qualcuno a cui forse aveva sfilato un po' troppi soldi, e che poi magari aveva pure messo da parte...».
La nuora di Anna Frezzante fa di tutto per suggerire un movente agli investigatori, e cita un caso di cronaca molto pertinente.

![]()
Colpo di scena nel delitto di Fregene: l'assassinata è in coma.

Si apprende oggi che Anna Frezzante, benché in un primo momento rinvenuta cadavere, è stata rianimata durante il trasporto in ospedale ed è arrivata viva al Grassi di Ostia, dove i sanitari l'hanno posta in coma artificiale, per cercare di gestirne le gravissime ferite.
Questa la clamorosa rivelazione di oggi.

 La
notizia è stata differita per proteggere la vittima, favorire le indagini e
trarre in inganno gli autori del delitto.
La
notizia è stata differita per proteggere la vittima, favorire le indagini e
trarre in inganno gli autori del delitto.
Subito centinaia di persone si sono riversate all'ospedale di Ostia, sul litorale romano, per chiedere informazioni sulla Frezzante, molto popolare in zona, dopo che nei giorni scorsi era stato negato l'accesso all'obitorio, per ragioni oggi divenute chiare.


C'è entusiasmo, ma anche profonda preoccupazione, angoscia e ansia tra i numerosi ammiratori della donna ricoverata in condizioni disperate al Grassi di Ostia: i bollettini medici, diffusi dallo staff sanitario, sono infatti allarmanti.
Anna Frezzante è molto popolare a Fregene, i graffitari del posto la ritraggono spesso, e lei non si sottrae di certo; figura anche, come attrazione locale, sulla mappe turistiche del litorale romano.
Inoltre è trapelato che l'importante donna, esaltata dal successo riscosso nella sua cittadina, puntasse decisa a Cinecittà: in cantiere il remake di un film interpretato nel 1977 da Jacqueline Bisset.
La Frezzante si era anche proposta per un ruolo drammatico, un giallo in cui rimaneva uccisa a coltellate.
Il destino ha realizzato il suo sogno; però a spese sue.

La realtà l'ha cinicamente anticipata.
E adesso deve metterci il fisico e spremersi tutta, per non andare a fondo e sparire da tele e mappe.

![]()
È la realtà, ma sembra un film.

![]()
E adesso, fuori dall'ospedale, si scatenano madonnari, graffitari e fotograffitari, con la Frezzante ritratta in drammatiche allegorie, schiantata e braccata dalla morte e da cadaveri putrefatti.

![]()
![]()
![]()