![]()
![]()
![]()
La Canzone della Baronessa di Carini
![]()
![]()
La CANZONE DELLA BARONESSA DI CARINI
di Salvatore Conte (2024)
![]()
![]()
1. Piange Palermo, piange Siracusa, a Carini c’è il lutto in ogni casa.
Chi portò questa nuova dolorosa, mai pace possa avere alla sua casa.
Sento la mente mia così confusa... il cuore gonfia e il sangue stravasa.
Vorrei con una canzon lamentosa pianger chi fu colonna a la mia casa: il più bell’astro che rideva in cielo, anima senza manto e senza velo, il più bell’astro del cielo zaffireo, povera Baronessa di Carini!

2. Povera Baronessa di Carini!
Se si affacciava parea la luna che luccicava nelle acque marine: l’una dal cielo e l’altra dai balconi.
Ricorrevano a lei tutti i meschini, dava riparo a ogni mala fortuna, e le sue genti, lontane e vicine, adoravano tutte la padrona.
Ora spaccato è quel felice cuore e dal gran pianger Sicilia ne muore.
Sangue la torre e son sangue gli altari, e non ci resta più che il lacrimare.

3. Fiumi, montagne, alberi, piangete, e sole e luna più non vi affacciate; la bella Baronessa che perdete vi apprestava i suoi raggi innamorati.
Uccellini dell’aria, che volete?
Il vostro amore invano voi cercate.
Lente barchette che al lido volgete, le vele tinte a lutto ora spiegate, e tinte a lutto con gramaglie scure, ché perduta è la signora dell’amore.
4. Amore, amore, piangi la sciagura!
Quel gran cuore non
più ti rasserena, quegli occhi, quella bocca benedetta, oh Dio! Che neppur
l’ombra ne rimane.
Ma c’è il suo sangue che grida vendetta rosso sul muro, e vendetta ne aspetta; e c’è Chi viene con piedi di piombo, Colui che solo governa sul mondo; e c’è Chi viene con lento cammino, e ti raggiunge, anima di Caino!
5. La tua salma nessun poté infiorare, la tua immagine nessun ha più mirato, né per l’anima tua poté pregare sulla lapide inginocchiato.
Povero ingegno mio, mettiti l’ale per dipingere sì nero dolore!
Tante lacrime a scrivere e notare, vorrei la mente di Re Salomone.
Quella di Salomone vorria, che in fondo mi portò la sorte mia.
La mia barchetta fuor del porto resta, senza timone, in mezzo alla tempesta.
La mia barchetta resta fuor del porto, la vela rotta e il pilota morto.
![]()
2° Canto
1. Attorno del castello di Carini, passa e ripassa un vago cavaliere: il Vernagallo di sangue gentile, che della nobiltà il vanto tiene.
Dal far dell’alba fino all’imbrunire, giunge, volta, ritorna, va e viene, s’aggira come l’ape nell’aprile attorno ai fiori per sorbirne il miele.
E ora per la piana vi compare montando un baio che vola senz’ale, ora dentro la chiesa lo trovate sfavillando cogli occhi innamorati, ora di notte con un mandolino lo sentite cantare dal giardino.
2. Il giglio fine, che il profumo spande, con grazia avvolto alle sue stesse fronde, vuole sottrarsi agli amorosi affanni e a tante premure non risponde.
Egli dice: «Mi hai messo in queste fiamme e a soccorrermi adesso ti confondi? Per quanto ho camminato, le mie gambe sono stanche e il lastrico ne affonda».
E sempre più il suo senno s’arrovella, ché ha dinanzi una figura bella.
E sempre più il suo senno cede all’aura, ch’ei dice: «Tanto risplendi, donna Laura?».
Sempre più il senno perde di valore, ché tutti così domina l’amore.
3. Quel dolce fior nato con gli altri fiori, disbocciava di marzo a poco a poco;
aprile e maggio ne godé l’odore e col sole di giugno prese fuoco.
Questo gran fuoco a tutte l’ore alluma, alluma a tutte l’ore e non consuma...
Questo gran fuoco a due cuori dà vita e a sé li attrae come calamita.
4. Oh! Vita dolce, che null’altra vince!
Goderla tutta, al colmo del suo giro!
Il sole per il cielo passa e sosta, ai due amanti le stelle fanno ruota. Gradevole catena i cuori stringe, battono tutti e due sopra una nota, è la felicità che lor dipinge ogni cosa d’intorno d’oro e rosa.
Ma l’oro fa l’invidia di cento, la rosa è bella e fresca un sol momento.
L’oro nel mondo è una schiuma di mare, secca la rosa e disfogliata cade.
![]()
3° Canto
1. Il barone da caccia era tornato, «Mi sento stanco, voglio riposare», quando alla porta sua si è presentato un fraticello e gli vuole parlare.
Tutta la notte insieme sono stati... lunga conversazione hanno da fare...
Gesù e Maria! Che aria annuvolata!
Questo della tempesta è il segnale.
Il fraticello uscendo sogghignava, e il barone, di sopra, infuriava.
Di nuvole la luna s’ammantò, l’assiolo chiurlando svolazzò.
Ecco, afferra il barone spada ed elmo: «Vola, cavallo, fuori di Palermo!
E voi miei fidi, benché notte sia, venite a le mie spalle in compagnia».
2. Incarnata calava la chiaria sopra la schiena d’Ustica pel mare.
La rondinella vola e zinzulia e s’alza per il sole salutare.
Ma lo sparviero le rompe la via, che gli artigli si vuole piluccare.
Timida in un cantuccio essa si annida, che a mala pena vi si può salvare, e d’affacciarsi non azzarda tanto e più non pensa al suo felice canto.
3. Simil paura e simile terrore ebbe la Baronessa di Carini.
Avea seguito, stando sul balcone, l’innamorato, per vederlo ire, e ripensava alle felici ore che avean goduto gli svaghi e i piaceri, con gli occhi al cielo e la mente all’amore, termine estremo d’ogni suo desio...
«Vedo venire una cavalleria... Questo è mio padre che viene per me...
Vedo arrivare una cavallerizza, questo è mio padre, che viene e m’ammazza. Signore padre, che venite a fare?».
«Signora figlia, vi vengo a ammazzare!».
4. «Signore padre, accordatemi un poco il tempo di chiamarmi il confessore».
«Sono sei mesi che la pigli a gioco e ora vai cercando un confessore?
Non è più ora di confessione e nemmen di ricevere il Signore».
E dette appena sì amare parole: «Tira la spada per spaccare il cuore.
Tira, compagno mio, non la fallire con l’altro colpo che l’ha da ferire».
Il primo colpo la donna gemette, all’altro colpo la donna perdette.
Il primo colpo l’ebbe nelle reni, e l’altro le sfondò il petto sotto i seni.
5. «Il cuor dissi di tirar!», se ne lamentò il signor padre.
«Ella si mosse sui piedi, signor mio…».
«La tua mano malferma non volle sfinirla…».
«Morte lunga è tormento maggiore, mio signore».
6. Che sconforto per l’anima infelice quando da niuno si vide aiutare!
Terrorizzata cercava gli amici, di sala in sala si volea salvare.
Gridava forte: «Aiuto Carinesi!
Aiuto! Aiuto! Mi vuole scannare!».
E disperata: «Cani Carinesi!», l’ultima voce fu che
poté dare.
L’ultima voce col penultimo fiato, ché già il petto è trapassato.
L’ultima voce col penultimo dolore, ché già ha perduto sangue e colore.
7. Correte tutti, gente di Carini, or che spenta è la vostra signora.
È caduto il giglio che fiorì a Carini, e ne ha colpa un cane traditore.
Correte tutti, frati e sacerdoti, portatevela insieme in sepoltura.
Correte tutti, paesanelli buoni, portatevela in gran processione: accorrete con una tovaglietta per terger la sua faccia così bella, accorrete con una tovagliola per terger la sua bocca di viola.
![]()
4° Canto
1. A due, a tre, fanno crocchio le genti commiserando con petto tremante.
Un gran ronzio per la città si sente, mescolato con gemiti e con pianti.
«Che mala morte, che morte dolente! Lontana dalla madre e dall’amante!».
«È morta come un cane, in men d’un niente, senza poter raccomandarsi ai santi».
«C’è chi dice che l’ultimo fiato e l’ultimo dolor sian dentro il petto ancor!».
2. Quando al palazzo giunse la novella, la nonna cadde a terra e trangosciò.
Le sorelle strapparonsi i capelli, la sua mammina dagli occhi accecò.
Povera madre! Chi gliel’avrà detto?
Questo pugnale in cuor chi le piantò?
Dentro una notte sua figlia sparì, essa dentro una notte incanutì.
Seccarono i garofani alle graste, rimasero deserte le finestre.
Il gallo che cantava è ammutolito, sbattendo le alucce è via fuggito.
3. Tutta Sicilia s’è messa a rumore, la novella ha passato pure il mare.
Ma nessuno lo dice a don Asturi che la sua amata non può più trovare.
Egli, perseguitato dal barone, a Lattarini s’è andato a salvare.
E quando lo raggiunge il tormentone, comincia a vaneggiare.
«Sepoltura che agghiacci, oh sepoltura, come agghiacciasti tu la sua persona? No, non è morta la persona bella! Vado e la cerco per tutta la terra!».
4. Per istrada incontrò la morte scura: senz’occhi e bocca parlava e vedea, e gli disse: «Ove vai bella figura?».
«Cerco chi tanto bene mi volea, Morte, se il bene mio mi fai trovare, ti do uno scrigno pieno di denaro, ti do vestiti di seta e d’argento, se me la fai vedere un sol momento.
Morte, e se non vuoi farlo per favore, pigliati pure me con il mio amore, purché una volta ancor l’abbia baciata!».
«Non la cercare più, ché per te è sotterrata».
5. «E come s’è deformata nel tempo di un’ora!
La faccia fine com’è deformata!
Il topo rosicchiò la gola pura, che un giorno di collane era ingemmata.
Nido di topi la capigliatura di fiori, un tempo, e di perle adornata; rosicchiate le teneri mani, gli occhi neri che non aveano eguali».
«Oh mala sorte, quanto mi sei dura!
Nemmen vedere la mia amante amata!».
![]()
5° Canto
1. Come la fronda dai venti portata, andava errando per rampe e per rampe.
«Caro padrone, mutate contrada, perché i levrieri qui ci stanno ai fianchi».
«Fra pietraie e dirupi la mia strada, e già le gambe son lacere e stanche».
«Caro padrone, la scena è cambiata, annericaron le nuvole bianche».
«Così pure il mio cuore è annericato, e il valor suo l’ha abbandonato.
Il mio destin che lontan mi caccia, alla casa di lei chiude la traccia.
Chiude il verde della mia speranza, e amor ancora mi brucia e mi strazia».
2. «Diavolo, ti prego in cortesia, fammi la sola grazia che domando: fammi parlare con l’amante mia, pure se nell’inferno io mi condanno».
Il Serpe, che passava e lo sentia: «Cavalcami che sono al tuo comando».
Con lui scomparve in un’oscura via, e non so dire né il dove né il quando.
E non so dire se fu vero o sogno che uomo e demonio lasciarono il mondo; ché il forsennato si sentì portare in un profondo sotto terra e mare.
3. Giunge all’inferno, e mai ci fosse andato! Colmo era, e a stento entrarvi si poteva.
C’era il suo Giuda, il monaco dannato, che le perfide carni si cuoceva, messo dentro un paiolo arroventato, come una corda vi si contorceva.
Vedendo il vivo, col collo allungato gli disse: «Sei venuto qua con me!».
Egli rispose: «Il tempo mai non falla, ché non senza elemosina si campa.
Da’ tempo al tempo, poiché ruota è il mondo, s’asciuga il mare e sorge quel ch’è in fondo».
4. «Tu, piuttosto, nel tempo di un’ora sei qui convolato?».
«Il Barone venne, vide la moglie senza colore, lo vinse il dolore, e dal petto mi trasse il core!».
«Monaco scellerato, che tu per sempre sia dannato!».
Dette le tristi parole, il forsennato s’aggira fra la calca infelice, ma all’amata nessun ombra s’addice.
5. Come la fronda dai venti portata, errando va per tutte le rampe.
La calca se ne è andata, pochi sui lieti campi pestan le gambe.
Giunge d’un tratto l’ombra magna di Re Salomone, e così a lui parla: «Non ti giova metà dell’amata, lascia ai pescator pietosi l’intera tonnata».
Così a lui parla, e il Serpe da sotto terra e mare l’orma va a strappare.
![]()
6° Canto
1. O castello che il tuo nome hai perduto, lontan ti vedo e fuggo spaventato.
Sei messo in lista da capo bandito e da trecento spiriti abitato!
Quanto in te avevi di bello è finito, dove stava il tuo sole ora è murato.
Alle tue mura il lutto ora è venuto, e nel cuore di quel padre dannato.
Padre dannato che non dorme un’ora, e il cielo bestemmia e la natura.
«Apriti, cielo, e inghiottimi, terra: fulmine che mi avvampi e mi sotterri! Strappate questo cuore dal mio petto, coltellatemi la notte dentro il letto».
2. Col sospetto negli occhi spalancati, girovagando per le vie deserte, sente la notte dalle ali gelate che gli dice: «La tua pace è sommersa».
Lo inseguono gli spiriti dannati con ghigni e con sberleffi.
E va e torna, e riposo non trova, perché il suo letto è di spini e di chiodi.
E va e torna, e lo caccia un lamento che va dicendo: «Tormento! Tormento!».
3. L’abbattimento alfine lo raggiunge, perfino il sogno l’abbraccia e l’avvince, ma la sua fantasia tormenta e punge, con l’ombre e le fantasme che pinge, come la nebbia che a nebbia si aggiunge e corre e vola e ovunque si sospinge...
Vengono e vanno in sogno i lieti giorni, la cara gioventù che più non torna.
Vengono e vanno le smanie ardenti, di amori, onori, dominio potente.
E poi viene di figli una corona... e gira, gira, è ruota di fortuna.
4. E in quel sogno che non l’abbandona, cerca la figlia sua dov’è fuggita, la figlia che fa invidia alla luna, che pure il sole ha fatto impallidire.
E le camere fruga ad una ad una, e solamente l’eco si fa udire.
L’eco risponde dagli angoli, or qui, or lì, e par mormori: «Se n’è ita! Se n’è ita!».
L’eco triste risponde solamente, e dice: «Che più cerchi? Non c’è niente».
«Ah, che un artiglio mi soffoca il cuore! Dov’è, dov’è la figlia del mio cuore?
Ah, che un artiglio nel cuore mi scava! Dov’è la figlia mia che già qui stava?».
5. Buio e aria muta, cammina e cammina, di sala in sala gli cresce la pena: quando una vecchia gli appare vicina, che lo sogguarda con torbida cera.
«Vecchia, fammi trovare Laura, che delle belle porta la bandiera e l’aura».
La strega gialla, che non pare viva, stende la mano che tutta le trema: «Corri», gli dice, «guarda nel suo letto: sta con un fiore rosso in mezzo al petto.
Vola, Barone, la figlia è trovata: sotto la bianca coltre è coricata.
Vola, Barone, guarda la tua figlia: pare che dorma sotto la coltriglia».
6. Solleva un lembo e chiama: «Laura!».
E lo stesso silenzio gli risponde.
Spinge la mano sotto e la ritira insanguinata e tutto si confonde.
Sangue fumante che vendetta grida, brucia e dentro il suo cuore si sprofonda.
Chi sparse sangue, altro sangue s’attira, a lavarlo non possono le onde.
Il sangue sparso non si può scordare, e lavarlo non può nemmeno il mare…
E qui è finito il sogno di terrore, il funereo sogno del Barone.
7. L’ira fa schiava la nostra ragione, e a perdita ci porta anche l’amore.
Il sacrilegio suo l’empio Barone lo sconta, ché già suona la sua ora.
Ma maledetti più degli assassini vadano i traditori e i delatori.
E voi piangete, gente di Carini, or ch’è ita la vostra signora.
Pensate a Dio e per essa pregate.
Pensate alla vostra signora e per essa sperate.
![]()
![]()
di Salvatore Conte (2024)

Verona, 11 giugno 572.
«Portate il mio calice preferito!», ordinò Re Alboino.
La moglie impallidì alla vista dell’orrendo calice.
«Riempilo di buon vino, Rosmunda!».
La reazione della figlia di Cunimondo lo scontentò.
«Leggo un odio profondo nei tuoi occhi, donna!
Un odio mortale!
Non rispondi?
Come vuoi.
Tieni, bevi anche tu».
«Da quel calice?».
«Da questo, Rosmunda!
Bevi!».
La Regina accostò le labbra al teschio di suo padre, ma non riuscì a bere.
«AH-AH-AH!», la risata di Alboino risuonò nella sala.
Dopo il banchetto, la sorte decise di ricompensare la pazienza di Rosmunda.
Fu così che la figlia di Cunimondo colse una delle sue ancelle, Irina, nell’atto
di uscire dall’alloggio di Peredeo, un vigoroso guerriero della sua stessa
tribù, gli indomiti Gepidi, vincitori degli Unni, eppur sottomessi dai
Longobardi di Alboino.
La Regina, dal canto suo, intendeva procedere spedita con il piano che aveva in
mente da tempo e che prevedeva di forzare la mano di Peredeo, affinché la
liberasse dal marito.
Doveva continuare ad avere pazienza, ma alla fine sarebbe stata ricompensata. E
adesso la sorte le veniva incontro.
La mattina dopo, Rosmunda era già al lavoro: «Lascia quella veste e aiutami a
fare il bagno, Irina».
L’ancella ubbidì.
«Perché non entri anche tu nella vasca? Ci aiuteremo l’un l’altra».
«Come vuoi tu, mia padrona».
Irina prese a detergere il bellissimo corpo della sua Regina.
Le morbide frizioni dell’ancella eccitarono Rosmunda molto al di là delle sue
previsioni.
«Ora tocca a me».
«Ma posso farlo da sola».
La moglie di Alboino ignorò l’obiezione e deterse a sua volta il corpo
dell’ancella.
«Lo so, ma non è la stessa cosa. Non credi?».
«Io… Io non so…», rispose titubante la serva, timorosa di ricevere troppa
confidenza dalla sua Regina.
«Questa non serve. Preferisco usare le mani», disse allusivamente Rosmunda,
gettando via la spugna.
E senza esitazioni, piantò le unghie sui seni di Irina.
«Mi fai male…!», protestò l’ancella.
«Lo so, ma so anche che non ti dispiace. Dillo tesoro.
Dillo, Irina!».
«Non lo so… Mi sento così strana.
È… meraviglioso…», confessò l’ancella.
«Sì meraviglioso, accarezzami anche tu».
Consumato il bagno, le effusioni proseguirono oltre.
«Vieni sul letto…», incalzò la moglie di Alboino.
«Mi fai impazzire… Prendimi, ti prego…», Rosmunda era in preda alle delizie
dell’amore femminile.
«Sì… Sì…», Irina era travolta dalla passione della Regina.
«Ti è piaciuto, amore?», chiese infine Rosmunda.
«È stato bello… Fin troppo…», rispose sinceramente la serva.
«Vai, ora. Ci saranno altri momenti come questi».
L’ancella lasciò le stanze, ma Rosmunda non rimse sola che per pochi istanti.
«Ma chi… Ah! Sei tu Elmichi».
«Ho visto Irina uscire poco fa e ho immaginato che ti avrei trovata sola»,
spiegò il suo amante.
«Non speravo però di trovarti pronta ad amare!», chiosò il rivale di Alboino,
come se la nudità fosse la chiave dell’amore femminile.
«Perché no? Conquistare quella giovane è stato facile, ma mi ha messo addosso un
grande desiderio».
«Mi sarebbe piaciuto assistere allo spettacolo!».
«Sei uno sporcaccione… Ma ora taci e prendimi, fammi male, Elmichi!».
Detto-fatto.
«Pensi davvero di riuscire a costringere Peredeo?».
«Sì, non ho alcun dubbio, farà quanto vogliamo».
«Poi ci sposeremo e regneremo sul nostro popolo insieme».
Passarono i giorni, passarono soprattutto le notti, e Irina passò dal letto di
Peredeo a quello di Rosmunda…
«Eccoti, finalmente. Sei stata con Peredeo, vero?».
«Sì, mia padrona…».
«Lo ami?».
«No… no… Forse all’inizio, ma ora non più… Io amo te…».
«Ne sei certa?».
«Non ho dubbi… Tu mi hai dischiuso le porte della felicità… Ho imparato ad
amarti… Farei qualsiasi cosa per te…».
«Taci, ora… Pensa soltanto ad amarmi e lasciarti amare…».
La passione travolse la giovane Irina…
Furono attimi appassionati quelli vissuti dalle due donne…
Ma la passione della vendetta non era seconda a nessuna: «È stato bello, amore.
Ora però devo ricordarti quanto mi hai detto poco fa… che sei pronta a qualsiasi
cosa, per me».
«È così, te lo giuro.
Mettimi alla prova, se vuoi».
«È quello che sto per fare, infatti. Domani non andrai da Peredeo. Cederai a me
il suo posto».
«Cosa?!».
«Gelosa, piccola?».
«Non di Peredeo…».
«Di me allora? Non ne hai motivo. Peredeo è un uomo che piace alle donne, ma non
è per questo che voglio andare a letto con lui.
Quel che ti sto per dire è molto grave… Ho bisogno dell’aiuto del tuo amante per
uccidere Alboino».
«Per gli Dei…!».
Più tardi Rosmunda rivelò a Elmichi che il dado era tratto…
«Non temi che quella ragazza ti tradisca?».
«Sono certa che non lo farà. Non ti preoccupare.
Dovevo metterla al corrente dei nostri progetti. Mi serve il suo aiuto per
costringere Peredeo a partecipare alla congiura».
«Spero che tu non abbia commesso un errore. Ci costerebbe la testa».
«Stai tranquillo. Quella giovane mi ama. Si farebbe uccidere piuttosto che
tradirmi».
La notte seguente Peredeo trovò il letto occupato…
Pensò che Irina giocasse d’anticipo e lui non volle essere da meno…
«Sono qua, amore…», e glielo fece sentire, prendendola da dietro.
Lei rimaneva di spalle.
«OH…!».
«Non sei mai stata tanto appassionata, Irina…!».
O forse solo meno assuefatta…
In ogni caso Peredeo fu tratto in allarme da una luce proveniente
dall’anticamera.
«Chi è là?!».
Illuminata da una torcia, l’ “appassionata” Irina si stagliò sulla soglia.
«Irina! Ma allora chi mai…».
«Perché non la guardi, ora che la camera è illuminata?».
«Tu! La moglie del Re…!».
«Proprio io, Peredeo. Dovevo trovare il modo di costringerti a far parte della
congiura ed è quanto ho fatto».
«Se credi ch’io sia disposto a uccidere Alboino, significa che sei pazza!».
«Davvero? Sai cosa ti succederà se non accetti?
Dirò a mio marito che mi hai attirata in questa stanza e che mi hai violentata».
«È una vile menzogna!».
«È vero, ma crederà a me. Inoltre, Irina è pronta a testimoniare di averti
sorpreso mentre mi violentavi qui dentro».
«Non puoi farlo! Non capisci cosa significa?», protestò Peredeo, rivolto a
Irina.
«Farò tutto ciò che la mia padrona vorrà, Peredeo».
«Maledetta! Che tu sia maledetta, Irina!».
«Finiscila! Ucciderai Alboino o sarà lui a darti la morte per quanto hai fatto».
«Io… Io non voglio morire… Farò quanto vuoi».
La mattina dopo, Rosmunda scese nei sotterranei del castello…
«Ho radunato i nostri amici come volevi. Sono ansiosi di vedere a che punto
siamo», disse Elmichi.
«Peredeo è pronto. Stiamo aspettando l’occasione favorevole», spiegò Rosmunda.
«E se dovesse fallire?».
«Non fallirà, tuttavia abbiamo sempre una via di scampo: il Prefetto
dell’Imperatore!
A Ravenna egli attende notizie ed è pronto ad aiutarci in caso di bisogno.
Il
Prefetto tiene a liberarsi di Alboino… certo di poter trattare la pace con me, facendo così bella figura con
l’Imperatore».
Era la sera del 28 giugno quando Re Alboino, dopo l’ennesima sbornia, si accese
per la bella moglie, strattonandola fuori dal banchetto: «Vieni, donna. Ho
bisogno d’un buon sonno, ma prima voglio te».
Penetrato nelle stanze, la gettò sul letto.
«Via questa veste!», e gliela strappò da dosso.
«Così Rosmunda! Così…», sfondandola di brutto.
Abbattuto dal vino, Alboino cadde in un sonno profondo.
Rosmunda ne approfittò per legare la spada al fodero e far sparire pugnale e
scudo, così da rendere il marito il più inerme possibile.
Poi si affrettò a chiamare Peredeo.
Quando questi entrò nella stanza, con la spada sguainata, Alboino si era appena
riavuto, scosso da un fosco presagio.
«Era soltanto un incubo…
Peredeo!!».
Allora il Re comprese…
Cercò di difendersi ma la spada rimase nel fodero.
Si oppose lanciando uno sgabello.
Ma fu il suo ultimo atto notevole.
La spada di Peredeo lo trafisse, senza lasciargli scampo.
L’odio di Rosmunda l’aveva infine raggiunto.
Passarono molte settimane, e notti di piacere tra la vedova del Re e suo marito
Elmichi.
Rosmunda era soddisfatta. Aveva raggiunto il suo scopo, ma voleva ancora di
più.
«I duchi dovrebbero decidersi a farmi loro Re, ormai».
«Lo faranno, non temere. Sei il marito della Regina, no?
Non ci sono motivi perché non lo facciano, Elmichi», lo rassicurò la moglie.
Ma i motivi vennero.
Lo spettro di Alboino apparve alla figlia di primo letto e al duca che la
corteggiava, chiedendo vendetta.
La figlia di Alboino si precipitò furente da Rosmunda.
«Tu! Maledetta!».
«Cosa ti prende?!».
«So tutto…! Lo avete assassinato…!».
«Oh!».
«Dormi!», Elmichi la colpì alla testa.
«Siamo perduti!», esclamò Rosmunda, in preda al panico.
«No, se ci affrettiamo. Ci impadroniremo del tesoro di Alboino e fuggiremo con
l’imbarcazione del Prefetto».
«PRESTO! Mi occupo io di lei. Avverti Peredeo e gli altri», Rosmunda voleva
salvarsi a tutti i costi.
«Non ucciderla. Potrà servirci come ostaggio», ammonì prudentemente Elmichi.
Quella stessa notte, con il ricco tesoro del Re assassinato, con il loro
ostaggio, i congiurati fuggirono da Verona scendendo l’Adige.
Ma a un tratto…
«Guardate!», esclamò Elmichi.
Un’Ombra, dalle vaghe sembianze di Re Alboino, apparve sul ponte della nave,
prendendo il posto del timoniere.
Il terrore si impadronì dei congiurati, alcuni dei quali cercarono scampo nel
fiume, trovandovi la morte.
«Addosso!», Elmichi lanciò la carica e si scagliò contro lo spettro, calandogli
la spada sul collo…
Ma il risultato fu quello di stroncare il timoniere della nave, mentre l’Ombra
di Alboino sfumava, sghignazzando.
«Alboino sta vendicandosi!», imprecò Elmichi.
«Ero certo che non ci avrebbe dato pace», recriminò Peredeo.
«Vi state comportando da stupidi codardi!
Prendi il timone, Peredeo!», intervenne decisa Rosmunda.
«Non dirmi che non l’hai visto…! Che non hai udito la sua risata…!», indugiò
ancora Elmichi.
«S’è trattato d’uno scherzo della nostra fantasia, Elmichi. Non può essere che
così», cercò di minimizzare Rosmunda.
Passarono molte settimane, e intensi sguardi di desiderio tra la vedova del Re e
il Prefetto di Bisanzio.
«Tu mi stai provocando ormai da molto tempo, donna».
«Mi desideri, Longino?».
«Lo sai bene!».
«Prendimi, allora!
Cosa aspetti?», Rosmunda si offrì completamente nuda.
«Vieni…! Lasciati amare…!», e prese Longino fra le cosce calde.
«Ora parliamo…», disse infine il Prefetto, ricordandosi degli affari di Stato.
«Sai come vanno le cose a Verona?».
«Ho sentito dire che i duchi si combattono fra di loro!».
«È vero. I Bizantini sono pronti a muovere con le loro schiere da me guidate».
«Ciò significa che presto potrò regnare sul trono dei Longobardi», si lusingò
Rosmunda.
«Non al fianco di Elmichi, però. L’Imperatore non lo permetterà mai».
«Sì, credo tu abbia ragione!».
«Se però restassi vedova e sposassi me, tutto sarebbe diverso».
«Capisco. Sarebbe vantaggioso per entrambi…
Credo proprio che Elmichi possa scomparire dalla scena, Longino…».
«Se hai bisogno di aiuto…».
«No, posso arrangiarmi da sola».
E la sera stessa… Rosmunda avvelenò il vino che Elmichi era solito consumare prima di
addormentarsi.
«Hai sentito le novità? Il Prefetto si prepara a muovere contro i Longobardi».
«Magnifico!».
«Non sembri preoccupata. Pensi che l’Imperatore permetterà a un longobardo come
me di regnare?», disse Elmichi, impugnando la coppa del vino.
«Perché non dovrebbe? Se Alboino è morto, egli lo deve anche a te.
Bevi, non preoccuparti».
«Bevi, Elmichi!
Bevi il tuo vino avvelenato!», lo spettro di Alboino era tornato e aveva
parlato!
«Attento, Elmichi! Vuole disfarsi di te, come ha fatto con me, per regnare sul
mio popolo a fianco del Prefetto Longino!».
«Maledetta!», esplose furibondo Elmichi.
«Non è vero! …non è vero!», si difese Rosmunda, con scarsa convinzione, ormai
preda di un folle terrore.
«Falla bere dal tuo stesso calice!», incalzò l’Ombra di Alboino.
 «Sì… Sì…!», approvò Elmichi. «Bevi!», ordinò furioso a Rosmunda, protendendo la
coppa verso le sue labbra.
«Sì… Sì…!», approvò Elmichi. «Bevi!», ordinò furioso a Rosmunda, protendendo la
coppa verso le sue labbra.
«No, io…
NOO…! NON VOGLIO MORIRE…!», urlò terrorizzata Rosmunda, confessando il suo
complotto.
«AH! AH! AH!», rideva lo spettro di Alboino, prima di sfumare, ormai certo della
vendetta di Elmichi.
«Bevi!», Elmichi estrasse la spada e la puntò al collo di Rosmunda, rendendo
cogente il suo ordine.
Rosmunda preferì bere. La spada beve tutto d’un fiato. Così invece, bevendo un
sorso appena, poteva ancora sperare di commuovere il marito.
Aspirate le prime gocce, Rosmunda cambiò colore, diventando paonazza in volto,
mentre un cieco fuoco prese ad avvolgerla tra le sue spire.
Ma tanto non bastò a placare Elmichi.
«Bevi!».
Rosmunda si rassegnò a bere ancora.
Ormai non aveva più speranze.
«Chiama il confessore… Elmichi… sono perduta…!», disse sconvolta, portandosi le
mani sullo stomaco e finendo seduta sul letto.
«Bevi!», il marito non intendeva lasciarle alcuna possibilità.
Fu costretta a bere ancora.
Crollò sul letto, ormai definitivamente abbattuta.
«Elmichi… chiama… chi deve… sotterrare… tua moglie…», disse singhiozzando, in
attesa della fine.
Con gli occhi smarriti, struggendosi sul letto, vide qualcosa che ritenne frutto
della sua agonia, un allucinazione prodotta dal diffondersi del veleno.
Una lama protendeva dal petto di Elmichi.
Quando il marito stramazzò a terra, lasciando apparire la figura di Longino,
Rosmunda non seppe più cosa pensare.
Il Prefetto di Bisanzio in Italia avanzò verso Rosmunda, guardandola
impassibile.
La donna, aggredita da feroci fitte di dolore allo stomaco e all’addome, cercava
disperatamente di protrarre l’agonia, invocando aiuto con gli occhi.
«Avevi detto che ti saresti arrangiata da sola, Rosmunda…», rimarcò
pesantemente il Prefetto.
Con la bava alla bocca, affannando a ogni respiro, Donna Longobarda tornò a
intravedere una possibilità e cercò di commuovere Longino: «A-i-u-ta-mi…
A-i-u-ta-mi… Tu mi vuoi… Io sono tua…».
Il Prefetto rimase a fissarla, impassibile.
Era un uomo abituato a guardare con freddezza alle situazioni cui doveva
provvedere.
Uomo d’armi, ma non privo d’ingegno.
I suoi uomini si resero disponibili, rimanendo sulla soglia.
«Portatela via!», ordinò il Prefetto.
Rosmunda fu caricata su una lettiga e trasportata in una stanza appartata,
forse per sottrarla a occhi indiscreti mentre consumava la sua agonia.
Fu raggiunta poco dopo dallo stesso Longino, dal Vescovo e dagli ultimi
fedelissimi.
Rosmunda doveva essere viva, perché muoveva debolmente le labbra.
Il Vescovo le impartì l’estrema unzione; il medico ancora non arrivava.
Il Prefetto provò a farla vomitare, infilandole in bocca un dito.
Rosmunda era però quasi completamente insensibile, rigida sul letto; e neppure
questo drastico espediente riuscì a procurare una reazione in un corpo ormai
abbandonato a sé stesso e preda di un veleno implacabile.
Per colmo di sventura non era nemmeno una morte indolore, perché le fitte allo
stomaco e all’addome continuavano a tormentarla e a farla sobbalzare come
ricevesse improvvise stilettate.
Rivoli di sangue si aggiunsero alla bava biancastra che le colava dal labbro:
violente emorragie interne aggravavano le sue condizioni.
Se ne accorse anche lei e rispose, accentuando la pressione delle mani
sull’addome e spalancando la bocca per garantirsi il respiro; con gli occhi,
sempre più allarmati, scartò sul capannello dei presenti giunti al suo capezzale
e si fermò su quelli di Longino.
Da questa reazione si poteva capire che Rosmunda era, nonostante tutto, mal
rassegnata a finire, mal rassegnata a uscire di scena, sebbene condannata dalla
sua stessa durezza.
Ciò nondimeno, quasi tutti i presenti si auguravano in cuor loro che la Regina
smettesse di soffrire quanto prima.
Uno di questi mostrò il pugnale a Longino, alludendo all’opportunità di portare
riposo alla loro Sovrana.
Il Prefetto d’Italia lo fissò negli occhi fin quando questi non rinfoderò
l’arma; quindi conferì qualcosa all’orecchio di uno dei suoi e lasciò libero il
Vescovo di raggiungere i fedeli della città e di trasmettere loro la morte della
Regina dei Longobardi, uccisa dal suo stesso veleno, incappata nel suo stesso
complotto.
Finalmente arrivò il medico, ma Longino non lo fece neppure entrare.
Fece entrare, invece, una vecchia ben tenuta, di nome Suxana, i cui vivaci
ormoni senili avevano fatto crescere le zinne, la quale era seguita da
un servo molto robusto, carico di ceste e cestelli.

Gli astanti furono invitati a uscire; il cortigiano che aveva mostrato il
pugnale lanciò un cenno d’intesa al Prefetto; gli altri rabbrividirono.
Rimase il solo Longino.
La vecchia osservò la bava che fuoriusciva dalla bocca dell’inferma.
Quindi fece un gesto al servitore, che in risposta le porse un cestello.
L’anziana donna ne rovesciò il contenuto sulla mano di Rosmunda.
 Lo
scorpione azzurro colpì quasi subito.
Lo
scorpione azzurro colpì quasi subito.
Poi fu ricondotto nel cestello.
La vecchia se ne andò come era venuta.
In pochi minuti, bava e rivoli di sangue si spensero.
Il corpo di Rosmunda si rilassò.
Muoveva ancora le mani, ma senza premerle.
La Regina teneva gli occhi rivolti al soffitto, e sembrava, oltre che morente,
financo stordita.
Il Prefetto la fece trasportare in un’altra ala del palazzo.
La campana a morto, intanto, rintoccava cupa da tutte le sante bocche della
città.
Longino abbandonò Rosmunda e fece ritorno nella Sala della Prefettura.
Fra le altre cose, comandò di allestire una nave per Bisanzio.
Infine fece chiamare un canzoniere.
L’attacco ai Longobardi fu sospeso e il corpo di Rosmunda fu gettato in mare,
senza esequie, lungo la rotta per Bisanzio.
Longino non fece più ritorno a Ravenna. L’Imperatore nominò un nuovo Prefetto.
In Italia, nessuno seppe mai perché.
![]()
![]()
di Matthew Gwinn e Salvatore Conte (1603-2024)
![]()
![]()
![]()
NERO How hesitantly my mind freezes! Hope on the one hand, dread on the other:
hope is a dreamer’s vision
fear a Gehenna
When my mind goes back and forth in this dubious way I neither live nor die, but I am unhappy. Unhappy the man for whom hope and fear thus vacillate! If false hope cheats me, I am cheated to my unhappiness. How unhappily I dread, lest some true cause of dread oppress me! How unhappily I die, if my mother does not perish first! A great business is afoot, I confess. Let it be done featly, I pray. Hurry, Anicetus, finish it.
Show yourself a man
Serve me, and destroy her
Destroy her, or you are dead. We are both dead: you will have lost your loyalty, I my kingdom, and ruin will overhang the both of us.
Come, hurry, slay, beat, rend, stab, do in my mother
so that you may show me a true Caesar. Keep your name of Unconquerable as an unconquered omen. But she,
rich in influence
rich in coin
on her guard out of fear
saved by her servant’s loyalty
will sniff this out and anticipate it in her turn, overturning the scheme, turning it against me. And she will overturn everything along with me.
The ancient vixen does not quickly fall into the net
Rather this is a lioness who lays her snares to avoid mine
She will surpass my arts with her art, my violence with her violence, my evil with her own. Will Pentheus drive Agave from Bacchus’ sacrifices?
Agave will drive down Pentheus, a sacrifice to Bacchus
Thus there is only one choice: strike or perish.
Strike, Anicetus, and strike deep
Unless she is stricken, unless she perishes, my cruel quarry will strike us, and our only choice will be to perish. And thus hope on the one hand, dread on the other, toy with and shatter me. As a wave first raises up a ship, then casts it down, so my proud heart leaps up to the heights, now sinks under the weight of its heavy burden. In either condition it fares poorly, more out of hope and fear than reality. Here instinct says one thing has been done, hope another, fear a third, but they do not say what. Anicetus, preserve my hope, do the thing, banish my fear. But alas, hope flees, fear prevails. I believe what I hope, but what I fear I believe the more. Evils are the more to be feared, as they come the quicker. Thus hope on the one hand, fear on the other, become entangled, travel in new spirals, when great things are awaited. I have hope from Anicetus, but fear from Agrippina. Only Anicetus can place me in security. (Enter Anicetus). And see, he has returned.
Tell me, am I an unhappy dead man
Or have I killed her
ANIC. Must it be the one or the other
NERO It must.
ANIC. Then there’s no doubt you must hope for one of the two
NERO No. But since I remain in doubt I seem to be dying.
ANIC. There’s no delaying
NERO No delaying. You speak of death when you speak
of delay.
ANIC. Then I’m speaking of death.
NERO What? Mine?
ANIC. Gods forbid. I am speaking of your murdered
mother.
NERO My mother?
ANIC. Yours.
NERO Murdered?
ANIC. And by this hand.
NERO I praise your hand, I kiss it. But you say
this on your oath?
ANIC. Upon my oath.
NERO What? Her dead? Can I believe this? Or do you wish
ANIC. Believe that Anicetus is speaking the truth,
no less than you believe you are alive.
NERO I wish to, and I am unable to believe, thus
great is this good. Nor is it easy to believe such tremendous things. But tell
me the means. But now there is no need to know the means, as long as it
assuredly has been done.
It is a thing beyond belief, that you have been able to kill her
This is a deed
that cannot satisfy me in the hearing. It will not satisfy me unless the eye
happily sees what the ear has heard. In the seeing the eye guarantees the mind’s
security. I want to go and look, if I may do so safely. May I?
ANIC. Why not?
NERO You think her dead?
ANIC. I know it.
NERO You’ve seen?
ANIC. With these eyes.
NERO And by your hands?
ANIC. These very hands.
NERO But —
ANIC. What?
NERO I am afraid, lest she revive. Unless she has
died . . .
ANIC. Look at me.
NERO But if she is still breathing and gains her health
ANIC. Have no fear.
NERO You promise? I am going.
You are either benefiting me
or betraying me
or making me wholly blessed
AA·AA·AA
AA·AA·AA
AA·AA·AA
![]()
![]()
di Giorgio Scerbanenco e Salvatore Conte (1970-2024)

Il cavalletto era sistemato all’interno della stanza, quasi in mezzo, era molto simile a un robusto treppiedi da fotografo, ma non sosteneva una macchina fotografica, sosteneva un Winchester M2 semiautomatico, una delle più potenti carabine moderne.
E sulla canna era montato il cannocchiale, e la carabina era puntata verso la finestra e prendeva d’infilata Corso di Porta Nuova, a quell’ora di mezzogiorno così piena di sole.

Faceva molto caldo. Paolo si mise al calcio del Winchester e guardò attraverso
il cannocchiale, spostando lentamente l’arma. Si vedeva nitidamente a oltre
duecento metri, lesse senza fatica un manifesto che invitava a uno sciopero,
manovrando col calcio del fucile si ravvicinò a cinquanta metri, quasi
all’altezza del bar, e inquadrò una bella donna che si rifaceva il trucco.
Nessuno poteva vederlo, sia perché il Winchester era sistemato all’interno della
stanza, sia
perché la serranda della finestra era abbassata quasi a venti centimetri dal
davanzale della
finestra; ma lui con quel cannocchiale mirava a oltre duecento metri e adesso
distinse nettamente
l’orologio al polso, col quadrante nero, di un giovanotto che teneva il braccio
fuori del
finestrino dell’auto e se fosse andato più piano avrebbe potuto quasi leggere
l’ora.
A proposito: guardò l’ora al suo orologio, era mezzogiorno passato da pochi
minuti. Di solito
Tullio Marone Isombardi veniva a prendere Anna pochi minuti prima dell’una,
cioè quando
lei finiva il suo orario.

Veniva dai Bastioni con la sua Giulietta spider rossa e si fermava lungo il marciapiede, in sosta vietata, ma Tullio Marone non era persona che usasse spendere il suo tempo nel leggere la segnaletica stradale, e restava al volante, e qualche minuto dopo dal bar dall’altra parte della strada usciva Anna, a passo svelto, con le zinne che le ballavano nel camicione sbottonato come fosse una mignotta dei Navigli e non una cassiera del centro; quindi lo raggiungeva, sedeva vicino a lui, gli si buttava addosso con tutta la sua carne: li aveva visti tante volte a occhio nudo, e questa volta li avrebbe visti meglio con quel cannocchiale.

Non che Tullio Marone
venisse tutti i
giorni, poteva passare anche una settimana senza che si vedesse e allora
Anna usciva dal bar
e se ne andava in via dei Giardini a prendere il filobus.
Comunque adesso era appena mezzogiorno, e faceva in tempo a scendere al bar a
bere
l’aperitivo. Si staccò dalla carabina e dal cannocchiale come con un certo
rimpianto, svitò una
leva del cavalletto e sbloccò il Winchester dal gancio, poi, come gli aveva
insegnato il sergente
O’Hirt, dette un colpo secco col taglio della mano sul bottone a molla a metà
dell’arma tra il
calcio e la canna: la carabina si piegò in due, ormai stava benissimo in una
qualunque sacca da
viaggio, insieme col treppiedi che rientrò sulle sue gambe fino a ridursi alla
misura di uno di
quegli ombrellini da donna che si portano al polso. E la sacca era già lì, era
la sacca delle gite
di fine settimana, la sacca tranquilla con dentro il pigiama, la busta col
sapone e il dentifricio e
il rasoio, in quella sacca però adesso c’era un Winchester M2, quello in
dotazione alla NATO,
col quale si potevano sparare dai cinquanta ai sessanta colpi al minuto, alla
distanza anche di
duecento metri, pesava 2 chili e 700 grammi, era di calibro 7,62 e, nelle mani
di un esperto, era
più temibile di un mitra.
Paolo non era un esperto ma, per quello che doveva
fare, il sergente O’Hirt gli aveva insegnato abbastanza. Mise un paio di maglie sulla sacca, poi
tirò la chiusura
lampo, mise la sacca nell’armadio, chiuse a chiave l’armadio, mise la chiave nel
gancio del
portachiave che teneva nella tasca sinistra dei calzoni, e uscì dalla stanza.
Erano le dodici e otto
minuti.
«Torno subito», disse a Michelina, la vecchia domestica.
Dette un’occhiata nello specchio dell’anticamera chiuso in una severa cornice
ovale di legno
scuro: il grigio così chiaro gli stava bene, la cravatta color terra di Siena
aveva una somiglianza
di tonalità coi suoi capelli, non era alto, questo no, lo sapeva benissimo, era
un poco, anche se
assai poco, inferiore alla media, e non erano poche le ragazze più alte di lui.
Però era un Donati Sorel: Paolo Donati Sorel.
«Sì, dottore», disse Michelina, aprendogli le portine dell’ascensore interno.
«Se telefona mamma, per cortesia, le dica che richiamo io», disse alla vecchia
domestica
dall’interno della cabina.
Mamma era a Sanremo e telefonava due volte al giorno e se non lo trovava aveva
le crisi.
«Sì, dottore», disse Michelina.
Fuori, Via Annunciata era in ombra, ma appena attraversata la strada, in Corso
di Porta Nuova,
il sole lo schiacciò come un ferro da stiro rovente, restò correttamente rigido,
non si affrettò, ma
si sentì meglio quando raggiunse il bar ed entrò nell’ombra freddolina di aria
condizionata del
locale.
«Un Cointreau», disse, mettendo il biglietto da mille sul vassoietto della cassa.
Non alzò lo sguardo, non aveva bisogno di guardarla in viso per sapere che era
Anna, ne
sentiva le onde sensuali, come lui fosse un transistor che riceve dei segnali,
era venuto per
sentirla, più che per guardarla, prima di ucciderla.
«Corretto gin», aggiunse, ma lei aveva già battuto lo scontrino, perché sapeva
già che cosa
avrebbe ordinato, dato che da quando lei aveva cominciato a lavorare lì come
cassiera lui non
beveva che Cointreau corretto gin. Con la sua grassoccia, sensuale mano gli
dette il resto, tutto
in monete da cento.
Si fermò nel caffè quasi mezz’ora, come faceva sempre, col bicchiere di
Cointreau tintinnante
di ghiaccio in mano, cercando di guardare Anna quando lei non sapeva di
essere guardata:
non era bella e nemmeno giovane o ben tenuta, ma c’era qualcosa, nella struttura fisica, di tozzo, di volgare,
di molliccio, che era
un’esplosione di femminilità, non si poteva essere più donne di come era donna
lei.
 Vi erano
degli idioti, li aveva sentiti, lì, al caffè, che dicevano che era brutta;
forse, secondo Botticelli,
avevano ragione, ma bisognava essere degli incapaci per non sussultare appena
muoveva per
caso il braccio indietro così che il seno d’improvviso si sollevava ancor più di
quanto già era
sollevato.
Vi erano
degli idioti, li aveva sentiti, lì, al caffè, che dicevano che era brutta;
forse, secondo Botticelli,
avevano ragione, ma bisognava essere degli incapaci per non sussultare appena
muoveva per
caso il braccio indietro così che il seno d’improvviso si sollevava ancor più di
quanto già era
sollevato.
“Sei un maniaco sessuale”, si disse, finendo il primo Cointreau, seduto nel caffè
deserto, c’era
solo lui, il barista, e lei: Anna.
“Sì, sono un maniaco sessuale, non è che
una volgarissima sciacquapiatti, però oltre che a me è piaciuta a Tullio Marone. Ma quello te le
ha sempre portate
via per dispetto, appena vede una con te, chiunque sia, te la porta via”.
Andò alla cassa a prendere lo scontrino per un altro Cointreau, guardò la mano
di lei che gli
dava il resto e sentì come se quella mano lo carezzasse sul collo, e allora,
intenerito, alzò il viso
per guardarla.
Sperò che sorridesse, ecco, almeno un sorriso, ma lei non sapeva,
in quel
momento, che sarebbe stato meglio sorridere a quel piccolo, per non morire: come
avrebbe
potuto saperlo? Anzi restò col volto rigido, indispettito da quel suo sguardo.
“Bene”, lui pensò prendendo il resto dal vassoietto, “fra venti minuti sei un
cadavere”. Gli
sarebbe bastato un sorriso.
Andò col suo bicchiere di Cointreau al tavolino in fondo al bar e pensò che
doveva calmarsi e
lasciar perdere; era stato un bel divertimento farsi dare il Winchester dal
sergente O’Hirt, e
anche provarlo alla finestra, per giorni e giorni, ma sparare davvero era
diverso.
Paolo Donati Sorel non poteva rovinarsi per una sciacquapiatti, che andasse pure con tutti i
Tulli Maroni che
voleva. Era assurdo scoppiare solo per quegli 80 chili di carne di sesso
femminile.
“Sì”, si disse, bevendo un altro sorso di Cointreau nel caffè deserto e
silenzioso in quell’ora
bollente.
Sì, voleva dire che avrebbe riportato subito il Winchester al sergente O’Hirt e
poi, visto che
era un maniaco sessuale, avrebbe cercato altre donne, ce ne erano tante, il
mondo ne era pieno.
Infatti, proprio in quel momento, entrarono quattro studentesse con vistosi
fagotti di libri sulle braccia, la più anziana non aveva sedici anni.
C’erano troppe donne nel mondo, era idiota tagliarsi le gambe per una
sciacquapiatti
qualsiasi. Che Tullio Marone se la tenesse, presto la puzza di sciacquatura di
piatti sarebbe
arrivata fino a lui. Si alzò, posò il bicchiere vuoto sul banco del bar e andò
ancora alla cassa,
guardò un momento il dietro di una delle studentesse che stavano uscendo e disse
a lei, Anna:
«Un Cointreau, corretto gin».
Lei aveva già battuto lo scontrino e glielo dette, lui non aveva più spiccioli,
dal portafoglio
levò un biglietto da diecimila e mentre lei contava il resto per darglielo,
quasi barcollando, non
per quello che aveva bevuto, ma sotto le ondate che lei gli trasmetteva e che
gli facevano
perdere ogni dignità, le disse:
«Ti porto a casa io, oggi, vieni, Anna».
«Sei, sette, otto, nove, dieci», contò lei, dandogli il resto; e poi: «No».
Lui prese i biglietti da mille, le monete di metallo, andò al banco e disse al
barista:
«Un Cointreau, corretto gin».
Cercò di ingoiare l’orrenda umiliazione di quel "no", oh, fosse stato soltanto un
"no", era stato un "basta", volgarissimo, era stato un "ma non hai ancora capito che è no", e del
resto glielo aveva
già detto quella sera in auto: «Ma stai fermo con queste mani e portami a casa,
non mi piacciono
i nanetti».
«E allora perché sei salita in macchina?».
«Perché piove, nanetto, e per andare a casa devo prendere due tram».
Col bicchiere di Cointreau in mano ritornò al suo tavolino, beveva rapido, un
sorso dopo
l’altro. Guardò l’orologio: erano le 12 e 35, guardò senza timidezze o
inquietudini lei, Anna,
chiusa nel chioschetto della cassa, monumento sessuale di cui sentiva sempre,
come un
transistor, le onde di femminilità, onde che però adesso si convertivano,
anziché in amore, in
odio.
“Sei morta”, pensò, “fra venti, venticinque minuti”.
Aveva finito il Cointreau, si alzò, depose il bicchiere sul banco del bar e
uscì, nell’aria che
era come metallo. Gli bastò attraversare la strada e fu davanti al portone di
casa sua, in Via
Annunciata.
«Ha telefonato mamma?...», disse a Michelina.
«No, dottore», disse la vecchia.
Entrò nella sua stanza, studio, salotto, camera da letto, quando non aveva
voglia di isolarsi
nella faraonica stanza del peccato, con quel letto così vasto, come la chiamava,
perché era solo
e gli bastava il divano sotto l’arazzo rappresentante ninfe e fauni, in
settecentesche, ambigue
giaciture.
Con la chiave aprì l’armadio, dall’armadio levò la sacca, tirò la chiusura lampo
per aprirla,
levò le due maglie di copertura e tirò fuori il Winchester e il treppiedi.
Con un colpo secco, il sergente O’Hirt aveva insistito: «Un Winchester non è una signorina da accarezzare sulle chiome, va trattato a colpi secchi, certe volte mi arrivano delle reclute tubercolose che danno dei colpettini da ridere, tossicchiando, il Winchester non si monta e non si smonta coi colpettini: ci vuole un taglio secco, così», e lui dette il taglio secco, nel punto esatto e il Winchester, con un sonoro scatto metallico, si ricompose in tutta la sua lunghezza.
Poi allungò il
treppiedi, ne regolò
l’altezza sul misuratore e fermò la livella al numero 27 che era l’altezza
esatta, dopo prove di
molti giorni, e quindi fece scattare il gancio sulla testa del treppiedi e nel
gancio ad H infilò il
Winchester e subito controllò al cannocchiale se la posizione era giusta.
Era giusta, perfetta: la carabina prendeva d’infilata Corso di Porta Nuova,
esattamente al centro, sull’estremo limite di sinistra del campo visuale si
vedevano le due porte d’ingresso del caffè dal quale sarebbe uscita Anna, e
a destra del campo visivo c’era il paletto col segnale di sosta vietata sotto
cui regolarmente sostava la Giulietta di Tullio Marone.
Abbassò ancora un
poco la canna dell’arma. Guardò l’orologio, erano le dodici e quarantanove. Si
accese una
sigaretta e, mentre l’accendeva, suonò il telefono. Era Michelina.
«La signora la chiama da Sanremo, le passo la comunicazione».
«Sì, grazie».
Aspettò, fumando, e guardando il Winchester. E sudando per le vampate di caldo
che
entravano dalla finestra aperta.
«Paolo...».
«Sì, mamma».
«Oh, Paolo, è successa una cosa terribile».
Per mamma tutto era terribile, non accadeva nulla nella vita che non fosse
terribile.
«Sta’ calma, mamma».
«Oh, è terribile davvero, Paolo, mi vergogno a dirtelo, ma mi sono dimenticata
che oggi è il
quinto anniversario della morte di tuo padre. Sarei venuta a portargli un po’ di
fiori, a guardare
il ritratto, oh, Paolo, mi vergogno, mi vergogno, ma sono vecchia e non ho più
memoria, per
niente...».
«Mamma, sta’ calma, prenderò io i fiori per papà».
«Oh, sì, Paolo, ma valle a prendere tu, le rose rosa».
La voce di mamma si spezzò, come stesse per piangere, si spezzava spesso, ma non
piangeva
mai, Paolo non conosceva nessuna persona più gelida e calcolatrice di sua madre,
infatti era
l’unica giocatrice fissa di Sanremo che coi suoi sistemi e sistemini riuscisse a
guadagnarsi la
settimana.
«Sì, mamma, le vado a prendere io, le rose rosa», erano quelle che piacevano a
papà. «Come
stai, mamma?».
«Va tutto storto, Paolo, non solo ieri sera ho perso sempre, ma ho finito anche
il libretto degli
assegni, ho telefonato in banca a Milano, ma mi hanno detto che fino a domani non
possono farmi
avere un libretto di assegni nuovo». La voce le si spezzò ancora. «Così stasera
non posso
neppure giocare».
«Ma fatti prestare qualche cosa dalla direzione dell’albergo, mamma...».
«L’ho fatto, Paolo, mi hanno dato solo centomila lire, mi hanno detto che il
regolamento vieta
prestiti superiori». Questa volta sembrava davvero che stesse per piangere. «Con
centomila lire,
se va male, gioco solo dieci minuti».
«Su, mamma, non fare così, domani ti arriva il libretto degli assegni».
Schiacciò il mozzicone
della sigaretta nel portacenere. «Senti, per favore, hai potuto parlare col
colonnello Drew?».
«Oh, vedi come sono vecchia, non ho più memoria, nessuna memoria, certo che ho
parlato col
colonnello Drew e lui ha già firmato il congedo per il sergente O’Hirt, volevo
telefonare per
dirtelo, poi me ne sono dimenticata».
La lasciò parlare, ma guardava inquieto l’orologio: le dodici e cinquantacinque,
le dodici e
cinquantasette, alle dodici e cinquantanove poté riattaccare il ricevitore e si
mise subito dietro il
Winchester e guardò nel cannocchiale.
La Giulietta spider di Tullio Marone Isombardi era lì, sotto al segnale di sosta vietata.
Tullio Marone
era al volante e aspettava. Attraverso il cannocchiale ne vedeva la faccia
meglio che se gli
fosse stato davanti a parlare insieme, e quella faccia, in qualunque modo
l’avesse vista, col
cannocchiale o a occhio nudo, aveva sempre destato in lui ricordi spiacevoli o
umilianti. E
guardandolo, guardando quella faccia, spinse lo scorrevole della sicura e
sbloccò il grilletto:
adesso sarebbe bastato anche soltanto soffiare sul grilletto e il colpo sarebbe
partito.
Odiava quella faccia perché sembrava quella di un grande uomo, di un capo, uno
guardava
Tullio Marone e sentiva subito che era un comandante, anche se così giovane, e
la odiava,
appunto, perché lui comandava, comandava anche lui, gli aveva sempre fatto fare
le cose che
voleva lui, andare a una festa piuttosto che a un’altra, perfino comprare
l’orologio di una marca
e non di un’altra. E odiava quella faccia perché era una faccia che piaceva alle
donne, le donne
lo vedevano e cominciavano a corrergli appresso, lasciavano tutto, marito,
fidanzato, amante, e
anche figli. A lui portava via regolarmente le ragazze, era arrivato al punto di
dirglielo,
strafottente: «Non hai ancora capito che non devi farti vedere da me in giro con
una donna?».
Anna non era che l’ultimo caso, il più clamoroso perché ci si era messa
anche la volgarità
della donna, alta un metro e settanta, che lo aveva chiamato nanetto.
Bene: adesso il nanetto sparava.
Guardò l’orologio. Le tredici e due minuti. Tornò a guardare nel cannocchiale:
Tullio Marone
fumava quieto seduto al volante, ogni tanto guardava verso il caffè, e alle
tredici e cinque minuti
Anna, in una semplice maglietta chiara a V, uscì dal
caffè, attraversò la
strada ancheggiando e lui seguì col cannocchiale il morbido movimento dei
fianchi e delle zinne cedenti di lei e la vide salire sulla Giulietta scoperta vicino a Tullio
Marone.
Adesso
bisognava fare presto, prima che la macchina ripartisse, e Tullio era un alfista
e aveva le
partenze rapide.
Fece presto, l’occhio incollato al cannocchiale sfiorò il grilletto e partirono
due colpi, uno
dopo l’altro. Era proprio peggio di un mitra, non l’avrebbe mai immaginato.
 I due colpi polverizzarono il cristallo del parabrezza, per un attimo non vide
nulla, poi i
frantumi di vetro si volatizzarono, e oltre il vuoto lasciato
dal parabrezza
comparve nitidissimo sotto la lente, come sotto un microscopio, il viso
sanguinolento di Tullio
Marone, o quelli che erano i resti di quella faccia odiosa di comandante, che
ormai non
comandava più nulla, irrimediabilmente morto.
I due colpi polverizzarono il cristallo del parabrezza, per un attimo non vide
nulla, poi i
frantumi di vetro si volatizzarono, e oltre il vuoto lasciato
dal parabrezza
comparve nitidissimo sotto la lente, come sotto un microscopio, il viso
sanguinolento di Tullio
Marone, o quelli che erano i resti di quella faccia odiosa di comandante, che
ormai non
comandava più nulla, irrimediabilmente morto.
Vicino a lui, nel fondo nitido, luminoso come un cinemascope del cannocchiale,
vide Anna
che gli aveva messo una mano sul petto per sostenerlo e che ora si guardava,
inorridita, la mano
colante sangue, come l’avesse immersa in un barattolo di vernice rossa.
«Nanetto. Perché pioveva e devo prendere due tram per andare a casa, ecco perché sono salita in auto con te. Nanetto».
Il viso gonfio di lei era inquadrato in fondo al cannocchiale, la crocetta di collimazione centrava proprio la bocca spalancata da mignotta.
Il sergente O’Hirt gli aveva detto di far piano: «Ecco, in questo, sì, il Winchester assomiglia a una bella donna sensibile: appena la sfiora, salta su. Più tocca forte, più il Winchester spara colpi, se vuole sparare solo un colpo o due deve appena sfiorare il grilletto».
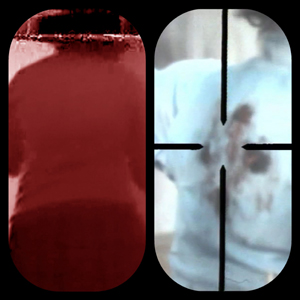

Intanto Anna, come avesse presagito che ora sarebbe toccato a lei, era scesa dall'auto, voltandosi di schiena e predisponendosi a una fuga disperata.
Ma non c'è fuga possibile da un Winchester M2, più veloce di uno schizzo di follia: la cinghialotta era stata inquadrata.
E lui lo sfiorò appena, per avere il tempo di comporre una tragica rosa di sangue sulla schiena ben tornita di Anna...
La donna inarcò le spalle e allargò le braccia, come in croce, colpita a morte, se non proprio fulminata; si avvitò su sé stessa, mostrando occhi impazziti di paura e stregati da una tragica consapevolezza... inutile bucarla anche in testa...
Quindi si staccò di colpo dalla carabina, andò alla finestra e lentamente abbassò tutta
la tapparella.
Non voleva vedere il resto; era un maniaco sessuale, non un assassino e non un sadico. E
del resto era
facile immaginare quello che stava succedendo.
Cominciava a tremare, si vide le mani tremare mentre staccava il Winchester M2
dal suo
treppiedi, e lo aveva preveduto, ma sarebbe passato, il tremito, con del
Cointreau. Il sergente
O’Hirt lo aveva detto: «Anche se il cinghiale vi passa davanti correndo con
tutte le sue gambe, e
lei non ha mai visto un’arma, neppure una sputapalle di ovatta, pure, dottore,
lei, con un
Winchester fisso sul suo cavalletto, non può sbagliare, il cinghiale cade
fulminato appena spara,
se passa in fondo al cannocchiale», perché ovviamente avevano parlato di caccia
al cinghiale, e
il sergente O’Hirt era troppo educato per mettere in dubbio le parole di un
giovane gentiluomo
milanese.
E infatti non aveva sbagliato, nemmeno lui che non aveva mai sparato neppure al tira
a segno del
luna park, anzi si era permesso di disegnare una perfetta rosa rossa sulla
schiena di Anna, neanche avesse avuto in mano un pennarello al posto del
Winchester M2.
Tremando, dette il colpo secco, col taglio della destra, al punto
giusto, e la carabina
gli si divise in due tra le braccia, la mise nell’apposito astuccio e solo
allora si ricordò di
spegnere la radio che aveva lasciato accesa piuttosto alta per coprire il secco tec-tec del
Winchester.
Con mani tremanti fece rientrare il treppiedi, lo ripose nel suo astuccio, mise
l’astuccio nella
sacca, insieme con l’astuccio del Winchester; mise nella sacca, questa volta,
invece che le
maglie, sopra al Winchester e al treppiedi, una ventina di pacchetti di
sigarette Camel che aveva
già preparato.
Tirò la chiusura lampo, mise la sacca nell’armadio, chiuse a
chiave l’armadio, si
mise la chiave in tasca, aprì la porta, uscì nel corridoio, le mani che gli
tremavano, e anche il
passo era come tremante, ma si controllò; dalla finestra, sia pure con le
tapparelle abbassate,
veniva un vocio confuso e nervoso: era normale, ma chiuse la porta dello studio-salotto, e non lo
udì più.
Andò in sala da pranzo, suonò il campanello, si preparò un Cointreau, lo bevve a
piccoli sorsi,
cercando di contenere il tremito della mano, gli pareva di sentire ancora del
vocio dalla strada,
ma non era possibile, la sala da pranzo dava dall’altra parte, sui giardini di Via Giardini.
Comparve Michelina.
«Porto subito, dottore».
Fece colazione, molto controvoglia.
E quando il tremito infine passò, guardò il quadro di suo padre.
Era a grandezza naturale, e stava in fondo alla troppo vasta sala da pranzo, vicino al finestrone più grande da
cui il dipinto, già paurosamente somigliante e veridico, riceveva una luce che
gli dava un
rilievo, e a volte sembrava perfino un movimento, come se suo padre intendesse
scavalcare la
cornice e venire a sedersi a tavola, con la sua inflessibile aria di inquisitore, lo
sguardo inflessibile
di un Donati Sorel.
“Sì, papà”, pensò, guardandolo, “sono un anormale e un delinquente. Avevi
ragione”. Bevette
ancora un po’ di vino e lo guardò di nuovo. “E anche un bastardo”.
Suo padre gli aveva detto queste cose quando lui aveva quattordici anni, prima
di mandarlo a
studiare a Londra. Gli aveva detto che non era a Londra che avrebbe dovuto
mandarlo, ma a un
riformatorio, e gli aveva detto che non solo era un anormale e un delinquente,
ma anche un
bastardo, perché sua madre era una così e così, e non aveva usato eufemismi, e
quindi lui non
poteva essere che un bastardo, figlio di un qualsiasi giardiniere, o autista, o
bagnino che sua
madre doveva aver intrattenuto brevemente, e questo discorso che si era sentito
fare a
quattordici anni era rimasto dentro di lui. Era cresciuto, con quelle
parole-pallottole in corpo,
anormale, delinquente, bastardo, e figlio di così e così, si era anche
divertito, ma le parole-pallottole
c’erano sempre.
Suonò il piccolo campanello di porcellana.
“Sì, papà, sono un anormale, un
delinquente e un
bastardo”, pensò. “Ora ne hai la prova”.
Michelina entrò.
«Per cortesia, Michelina, portami il telefono».
«Sì, dottore».
Il volto della vecchia, grassoccia e flaccida donna, sembrava un
poco alterato.
«Oh, dottore, sapesse, proprio qui davanti casa hanno sparato a due persone,
adesso-adesso: è
passata un’auto, hanno sparato dall’interno dell’auto e i due sono stati colpiti, un
uomo e una donna; il
nostro portinaio ha visto l’auto con l’uomo che sparava dal finestrino, ma non
ha potuto prendere
il numero della targa...».
Paolo Donati Sorel cominciò a recitare, da allora in avanti avrebbe dovuto
recitare molto.
«Adesso? Qui davanti?».
Pensò al portinaio che aveva "visto" l’auto dalla quale erano stati sparati i
colpi.
Michelina staccò l’apparecchio telefonico dal fondo della sala, lo portò sul
tavolo lungo e
ovoidale, sì, l’architetto aveva pensato a un tavolo quasi a forma di uovo, e
innestò la spina
nella presa a terra, sotto il tavolo.
 «Sì, proprio qui davanti a casa, c’è ancora un sacco di gente, è arrivata la
polizia e un'ambulanza, ed è ripartita di corsa», le tremava la
voce nel parlare.
«Sì, proprio qui davanti a casa, c’è ancora un sacco di gente, è arrivata la
polizia e un'ambulanza, ed è ripartita di corsa», le tremava la
voce nel parlare.
«Un'ambulanza?».
«Sì, un'ambulanza, dottore. Forse uno dei due non è rimasto ucciso, per
fortuna».
«Grazie, Michelina», disse.
C’era la possibilità che da un momento all’altro la polizia salisse in casa sua e lo arrestasse: era molto remota, e comunque non poteva farci niente.
Strano che fosse giunta sul posto un'ambulanza... per fare che, poi?
Di sicuro la vecchia si era sbagliata, confusa dalle sirene
della polizia.
Fece dunque tre telefonate.
Per prima cosa chiamò
Vicenza, la caserma
della NATO.
«Urgente», disse alla centralinista.
Poi chiamò il fiorista. «Sono
Donati Sorel, per
favore, signor Carlo, mi faccia avere nel pomeriggio trentasei rose rosa».
«Rosa? Oh, dottore, dovrò cercarle, io ne ho appena una dozzina».
Gli disse con estrema cortesia di cercarle, ma di fargliele avere prima delle
cinque.
Poi
telefonò al garage, riconobbe subito la voce della ragazza dal grosso seno che
faceva la
dirigente amministrativa della grande autorimessa.
«Donati Sorel, per cortesia, mi faccia mandare subito la Ferrari».
«Sì, dottore, faccio riempire il serbatoio?».
Al suono di quella voce, nonostante il tremore di terrore che internamente lo
pervadeva, la
sensazione di morbido di quel seno lo sommerse.
«Sì, signorina, molte grazie».
Poi suonò ancora il campanellino di porcellana, e attese Michelina.
«Per favore, Michelina, porta qui, non adesso, più tardi, il vaso Baviera.
Nel
pomeriggio
arriveranno delle rose da mettere davanti al ritratto di papà».
«Sì, dottore».
Il vaso Baviera era un vaso di cristallo alto uno e sessanta, quattro centimetri
più di lui; lo si
metteva, pieno di rose rosa, davanti al ritratto di papà, negli anniversari
della sua morte. Idea di
mamma, quella così e così.
Poi andò nella sua stanza, aprì la porta, aprì l’armadio, prese la sacca con
dentro il
Winchester, scese in strada, senza guardare davanti, in Corso di Porta Nuova
dove aveva
sparato.
La Ferrari era già lì, pronta, buttò la sacca con la carabina nei
sedili di dietro e,
pazientemente risalì in casa.
«Chiamano da Vicenza», disse Michelina, aprendogli la porta.
«Grazie». Prese il ricevitore del telefono che Michelina gli porgeva. «Per
cortesia, Sezione
11, sergente O’Hirt», disse.
«Sì, signore». Lungo, molto lungo silenzio, poi una voce:
«Sergente O’Hirt, chi parla?».
«Sono Paolo», disse lui. «Fra due ore, due ore esatte, sono lì».
«Sì, signore».
Tolse la comunicazione senza neppure salutare.
Scese, salì sulla Ferrari, erano le due e mezzo, in Corso Buenos Aires si fermò davanti a una banca, non era molto regolare, ma il direttore conosceva troppo bene i Donati Sorel per inimicarseli e gli dette mille e cinquecento dollari in biglietti da venti dollari.
Alle due e cinquantadue entrava
nell’autostrada Milano-Venezia e dopo qualche centinaio di metri cominciò a premere l’acceleratore,
sempre di più,
fuori c'era un caldo orribile, ma lui aveva aperto l’aria condizionata e stava
bene.
Gli piaceva guidare, e guidava bene, e la Ferrari corre bene, e lui viaggiò
sempre in corsia di
sorpasso e due ore dopo, precisamente due ore, usciva alla stazione di Vicenza
est e duecento
metri dopo lo snodo ecco, sullo stradone provinciale, la jeep del sergente O’Hirt.
La sorpassò e
si fermò qualche metro davanti, restando fermo al volante, il finestrino aperto,
e quindi l’aria
condizionata chiusa, nella vampa di caldo che veniva dallo stradone.
Il sergente O’Hirt scese dalla jeep e corse da lui, il viso grassoccio e gli
occhi così celesti.
«Prendi la sacca, lì dietro, ho messo delle sigarette per coprire».
Non lo
guardava neppure.
«Sì, signore», il sergente O’Hirt sudava dai baffetti rossi, allungò la mano
nell’interno
dell’auto, dal finestrino che lui aveva aperto e prese la sacca. «Grazie,
signore».
«Il colonnello Drew ha firmato il congedo, fra una diecina di giorni al massimo
potrai tornare
a casa tua, negli Stati Uniti».
«Grazie, signore, il furiere mi ha già detto che sono stato congedato.
Grazie,
signore, sono
molto contento».
«Questi sono mille e cinquecento dollari», gli dette la busta. «Tu non mi hai
mai veduto, non
mi conosci, non mi hai mai incontrato, neppure per caso, non mi hai mai prestato
un Winchester.
Cerca di ricordarlo: ti conviene».
Abbassò netto una mano come volesse tagliarlo in due.
«Va’
via e ricordati quello che ti ho detto».
Partì dolcemente, fece tutto lo stradone fino a raggiungere lo snodo
dell’autostrada dalla parte
Vicenza-Milano, e alle sette e un quarto era in Via Annunciata, a casa sua.
Andò in sala da pranzo per prepararsi da bere: le rose rosa erano arrivate, troneggiavano nel gigantesco vaso Baviera di cristallo, quattro centimetri più alto di lui, davanti al ritratto di suo padre.
Cominciò
a bere Cointreau, guardando le rose e suo padre, e aspettando di vedere che cosa
sarebbe accaduto; a un tratto gli sembrò che in mezzo alle trentasei rosa ne
spiccasse una rossa, più alta delle altre, alta un metro e settanta da terra.
Per il resto, accadde quello che lui aveva preveduto: sparando da una finestra del secondo
piano,
l’angolazione è così bassa che neppure l’autopsia più scrupolosa può sospettare
dall’angolo di
incidenza che il colpo sia stato sparato dall’alto, da una finestra. Per di più
un portinaio, proprio
il portinaio di casa sua, aveva visto un’auto dalla quale avevano sparato. E
questo era uno.
 Il due era, come aveva preveduto, che la polizia si era buttata addosso alla
traccia del
Winchester. Un Winchester M2 non si vende nelle cartolerie, o nei negozi di
profumi, e tanto
meno nei negozi per cacciatori e pescatori. Il Winchester M2 è un’arma di
guerra in dotazione
alle truppe della NATO, non è in commercio neppure per gli appassionati di
caccia grossa, e
Paolo Donati Sorel immaginava la sorpresa del perito balistico della questura,
quando il professore che aveva fatto l’autopsia gli aveva inviato il proiettile
estratto dal cadavere: un calibro 30 per Winchester M2; aveva la forma di un
rossetto da donna.
Il due era, come aveva preveduto, che la polizia si era buttata addosso alla
traccia del
Winchester. Un Winchester M2 non si vende nelle cartolerie, o nei negozi di
profumi, e tanto
meno nei negozi per cacciatori e pescatori. Il Winchester M2 è un’arma di
guerra in dotazione
alle truppe della NATO, non è in commercio neppure per gli appassionati di
caccia grossa, e
Paolo Donati Sorel immaginava la sorpresa del perito balistico della questura,
quando il professore che aveva fatto l’autopsia gli aveva inviato il proiettile
estratto dal cadavere: un calibro 30 per Winchester M2; aveva la forma di un
rossetto da donna.
La polizia, siccome l’arma era militare, seguiva una traccia di spionaggio,
tutte le caserme della NATO, in Italia e in Europa, stavano per essere
setacciate; comunque seguivano una strada sbagliata. E l’aveva previsto.
Inoltre, al quarto giorno, le rose rosa non erano ancora sfiorite, che già i
giornali non parlavano più della storia.
Entro certi limiti aveva preveduto anche questo, ma riconosceva che era stato
aiutato dalla
fortuna.
Di cosa imprevista ce n'era soltanto una, al momento. Una come le autopsie eseguite finora.
Michelina non si era sbagliata: un'ambulanza aveva raccolto dall'asfalto la povera Anna, con tutta la sua rosa calibro 30 tatuata a sangue sulla schiena. Era stata coperta con fogli di giornale dai passanti pietosi, ingannati dallo sguardo ghiacciato, ma la polizia si era accorta che respirava ancora.
La presuntuosa cassiera si era aggrappata alla vita, si era zavorrata ai suoi 80 chili. Un proiettile le aveva sfiorato il cuore, senza però ucciderla.
Era ricoverata senza speranze all'ospedale, non poteva neppure essere operata; era priva di coscienza, però ancora non moriva.
Aveva incassato quattro pallottole calibro 30, ma era talmente disperata da tenersi in vita; con la carne provava a mangiarsi il piombo.
Paolo sperava che resistesse un altro po', che riprendesse
conoscenza prima di morire; sarebbe anche andato al suo capezzale.
Fu al nono giorno, quando già da tempo aveva fatto togliere il vaso Baviera, non
è divertente
essere più basso di un vaso, ed era un caldo, sonnolento pomeriggio, che
Michelina gli telefonò
nel suo studio-salotto.
«C’è un signore che desidera parlare con lei», disse. «Ha detto che è un amico
del sergente
O’Hirt».
Per un poco, una vertigine lo rese quasi cieco. Poi si riprese. Con voce molto
lenta disse:
«Fallo passare in sala da pranzo».
«Sì, dottore».
«Prima, però, metti il telefono sul tavolo».
Vi sono persone che possono sentirsi imbarazzate a sedere davanti a un tavolo a
forma di
uovo, e dalla parte della punta dell’uovo, e lui sentiva che il visitatore era
una di queste
persone.
Andò in sala da pranzo: l’uomo era lì, in piedi, goffo e volgare come aveva
previsto.
«Sono un amico del sergente O’Hirt», disse.
«Si accomodi», disse. Lo invitò a sedere, dalla parte della punta dell’uovo, e
vide subito che
lui si sentiva a disagio.
Pur nella sua avvelenata disperazione ebbe voglia di ridere. Era un bianco, ma
sembrava
nativo della Beciuania.
«Sono un amico del sergente O’Hirt», disse il beciuano.
Lo guardava fissamente, perché lui capisse che era un amico del sergente O’Hirt.
«Sì», ammise lui, signorilmente, guardando il ritratto di suo padre che
assisteva al colloquio,
pronto a scavalcare la cornice. «Sì, e che cosa
desidera?».
«Il sergente O’Hirt beve», disse il beciuano, fissandolo: più che con le parole
sembrava
abituato a parlare con gli occhi, occhiate cariche di sottintesi, come nelle
comiche dei film muti
con torte in faccia.
«E allora?», lui domandò al beciuano.
Poteva darsi che il sergente O’Hirt bevesse, erano assai rari i sergenti astemi.
«Quando ha bevuto parla».
«E poi?»
«Io sono suo amico».
«Questo lo ha già detto. Soltanto che io non conosco né lei né questo sergente
O’Hirt».
«Il sergente O’Hirt beve molto e quando beve parla con gli amici. Io sono suo
amico, io
lavoro nelle cucine della caserma NATO, a Vicenza. E mi ha detto che
tornava a casa,
congedato, per questo si prendeva una sbornia».
«E allora?».
«Allora ha detto anche», disse il beciuano, «che c’era stato un signore che gli
aveva fatto
avere il congedo e in più mille e cinquecento dollari, per un piccolo favore».
«Sì», disse cortese, con molta paura, ma cortese, come lo è sempre un
gentiluomo, e si mostrò
curioso. «E che piccolo favore era?».
«Un Winchester M2 prestato per qualche giorno», disse il beciuano,
occhieggiando.
Paolo Donati Sorel si volse un momento a guardare il ritratto del padre che lo
irrideva. Non
era mai stato così stupido da pensare di compiere un delitto perfetto, solo i
cretini pensano al
delitto perfetto, e lui era tutto, anche bastardo e figlio di una così e così,
ma non cretino.
«E io che c’entro, in tutto questo?», disse, cortese e paziente.
Gli occhi occhieggiarono, le folte sopracciglia nere vibrarono, le basette
ondeggiarono, le
mani e le braccia si mossero come in una bracciata di crawl, e il beciauno
disse:
«Lei è il signore che si è fatto prestare il Winchester col cannocchiale e il
treppiede e che col
Winchester ha sparato a quei due dalle finestre di casa sua. Io leggo i giornali».
Paolo Donati Sorel abbassò lo sguardo sull’apparecchio telefonico che aveva
davanti a sé, e
disse, rialzando subito lo sguardo.
«Non ho capito quasi nulla di quello che lei dice. Comunque: che cosa vuole da
me?».
«Io sto per sposarmi e volevo comprare l’appartamentino a Cologno Monzese. Costa
dieci
milioni».
Gli fece segno di sì, che capiva: uno che si sposa ha bisogno dell’appartamento,
non può mica
fare la notte di nozze al Parco Ravizza.
«E almeno un trecentomila al mese, per i primi tempi», disse il beciuano.
«Non so se ho capito bene, ma lei vuole da me dieci milioni subito, e poi
trecentomila lire
ogni mese. È così?».
«Sì, è così».
«E perché io dovrei darle tutti questi soldi?».
«Perché se no, io vado in questura e racconto tutto».
Lo guardò, guardò quella melma sotto forma umana.
«Non occorre che lei vada in questura», conosceva troppo bene la sua sorte, dal
momento in
cui in fondo al cannocchiale del Winchester aveva inquadrato Anna e Tullio
Marone, e aveva
sparato, sapeva che non c’era scampo. Presto o tardi lo avrebbero preso. Si era
voluto soltanto
vendicare. «La chiamo io, la polizia».
Il beciuano rise, banalmente.
«Voglio vedere».
Paolo Donati Sorel compose il 113 senza rispondergli.
«Venite subito in Via Annunciata 4, secondo piano, sono in mano di un uomo che
mi minaccia
e mi ricatta», disse al milite e depose subito il ricevitore.
Era il miglior sistema per farli accorrere subito.
Il beciuano alzò una spalla, mosse ancora le braccia come nuotasse il crawl,
alzò le
sopracciglia, fece ondeggiare le basette, e poi rise:
«Signorino, non fate lo spiritoso, voi non avete telefonato a nessuno, voi avete
fatto finta di
telefonare, per spaventarmi, ma io non mi spavento. Datemi i soldi, se volete
vivere tranquillo».
Quando arrivarono i militi della volante, il beciuano non lo credeva ancora, e
quando se ne
convinse, cominciò a gridare: «Lui ha sparato a quei due qua sotto, con un Winchester,
gliel’ha dato il
sergente O’Hirt, per il congedo e mille e cinquecento dollari...», lo gridò con
tutta la sua voce,
per quasi un’ora di seguito, schiumante rabbia beciuana per la mancata riuscita
del ricatto.
Un brigadiere disse a Paolo Donati Sorel:
«Dottore... ma cosa sta dicendo?».
«La verità», rispose, pensando alle zinne di Anna e ai suoi camicioni
sbottonati.
![]()
«Scusa...», era stata la prima e unica parola detta da Anna nei brevi momenti in cui riprendeva una tribolata coscienza.
La donna versava in condizioni disperate, ma Paolo Donati Sorel l'aveva fatta trasferire in una prestigiosa clinica privata, dove poteva controllarla molto strettamente, ed era andato personalmente a trovarla, sebbene lui non fosse presente quando l'imponente donna aveva pronunciato quella parola, che però gli era stata puntualmente riferita dall'infermiera.
Molto probabilmente sarebbe stata l'ultima battuta della cassiera.
Il Comando NATO di Vicenza, con un laconico comunicato, aveva smentito le presunti farneticazioni attribuite al sergente O’Hirt, sotto-ufficiale di irreprensibile condotta, alle dirette dipendenze di un ufficiale superiore negli ultimi giorni di permanenza nella base.
Lo sciacquapiatti beciuano era stato licenziato in tronco, denunciato per diffamazione alle autorità USA e bollato come fiancheggiatore di forze ostili.
Le pallottole incassate da Anna era ancora tutte e quattro dentro il suo massiccio corpo. La sua autopsia, che avrebbe potuto rivelare l'angolo di incidenza dei proiettili, era sospesa, appesa al filo della flebo.
Il Winchester M2 del sergente O'Hirt era stato richiamato dall'azienda Winchester per un lievissimo, impercettibile, rarissimo difetto di fabbricazione, che per mera cautela la prestigiosissima azienda americana voleva esaminare al più presto. In ogni caso non sarebbe stato sequestrabile dalle autorità italiane.
Pertanto a carico di Paolo Donati Sorel non c'era praticamente nulla.
Soltanto lo sguardo ghiacciato di Anna, la quale vedeva la morte porgerle una rosa nera, mentre lui, l'assassino, le teneva la mano e la rassicurava.
![]()
![]()
![]()










